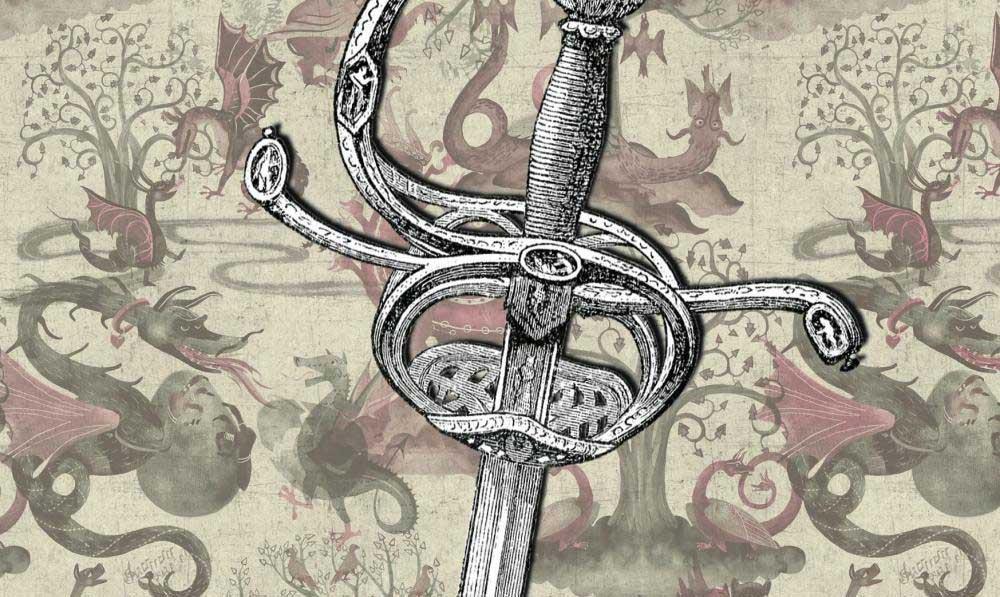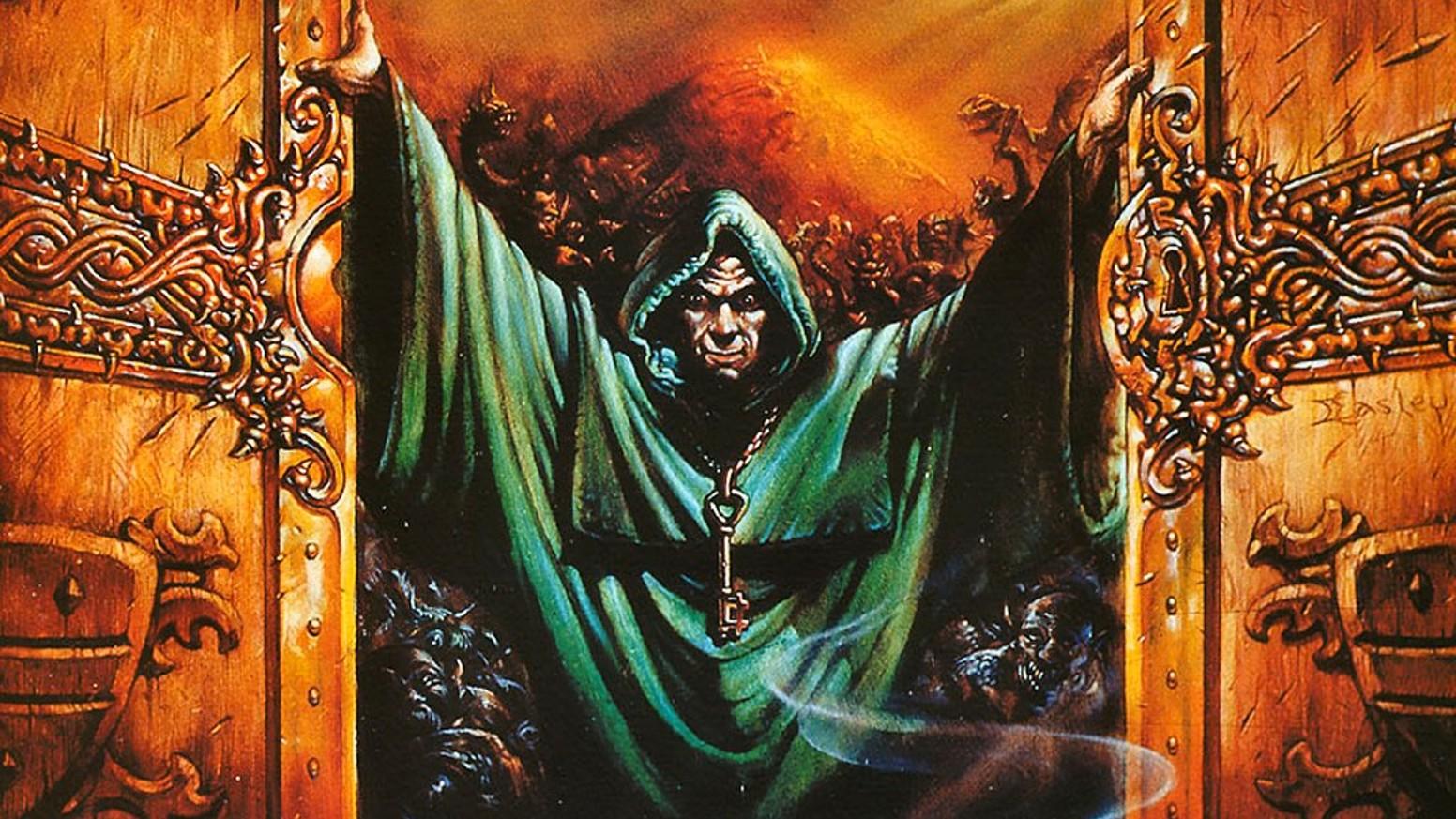
Tutti i contenuti pubblicati da aza
-
Il Catalogo Completo di Aurora
Vorrei iniziare col manuale più strano e originale che sia mai stato pubblicato per D&D: Aurora’s Whole Realms Catalogue. Il Catalogo Completo di Aurora è un manualetto (160 pagine) per i Forgotten Realms scritto nel 1992 ed è fondamentalmente un "grande libro di merci e attrezzature" estremamente divertente e con molte potenzialità. La sua originalità inizia con le sue dimensioni digest (16x23 cm), un formato che D&D non vedeva dai tempi dei 3 set originali (1974-1976). Il retroscena: Aurora l'eclettica è una maga ed esploratrice che, dopo avere girato tutto il Faerûn, si stabilì a Waterdeep nel 1370 e creò un redditizio negozio di import/export. Il suo emporio ha un ampio elenco di attrezzature e oggetti non magici a prezzi scandalosamente competitivi. In qualche modo, il suo piccolo negozio ha disponibile in pochi giorni qualsiasi cosa ordinata dal suo catalogo. A parte il divertimento di una vasta gamma di articoli e attrezzature, Aurora offre alcune utili opzioni per i DM che cercano idee. Questo è l'indice del manuale dove, come detto, non troverete alcun oggetto magico. La vastissima gamma di prodotti, da quelli banali (una libbra di polvere di gesso) agli articoli più speciali come i costumi da bagno Drow, passando per i giocattoli o i pezzi da scacchi che raffigurano i maghi famosi dei reami o l’orda Tuigan, rendono questo manualetto un pezzo unico e probabilmente irripetibile. Per quei DM che cercano costantemente di vendere cose ai giocatori, e per quei giocatori che tendono a trasportare un assortimento di prodotti strani, nel caso in cui si riesca a trovare un modo interessante e inaspettato di usarli. Il manuale si chiude con alcune invenzioni del grande gnomo eremita Nadul DaRoni: artista e inventore. Nel caso non abbiate un bue o un asino e non volete usare il suo "carro a fornace" perché lo ritenete troppo pericoloso (anche se ho sentito parlare di una sola persona bruciata viva), vi presento il progetto del suo "carro a mano": L’idea del manuale venne a Anne Brown la quale nella sua campagna di Call of Cthulhu, per andare incontro ai giocatori che chiedevano sempre quale equipaggiamento fosse disponibile, usò la ristampa di un famoso catalogo del 1902 di vendita per corrispondenza: il Sears-Roebuck (se volete sfogliare il catalogo del 1922 lo trovate online qui). Anne Brown e J. Robert King avrebbero dovuto creare il manuale insieme, ma la Brown dovette presto abbandonare a causa della sua gravidanza. Ciò lasciò a King un compito di ricerca monumentale, che prevedeva la lettura di oltre 10.000 pagine di materiale dalla Biblioteca dell'Università del Wisconsin, dalla Biblioteca della TSR e dalla biblioteca personale dello straordinario designer della TSR, Jon Pickens. Sebbene King abbia scritto lui stesso oltre la metà del libro, è stato aiutato dal resto dello staff TSR. Paul Culotta ha scritto un articolo intitolato "Aurora's Undermountain Sale" per Dragon # 239 (settembre 1997) che contiene strani equipaggiamenti da dungeon, scritti nello stesso stile di Whole Realms. I manuali “Guida di Volo” di dimensioni ridotte (1993-2000) sono stati probabilmente influenzati dal successo di questo manuale. Questo è stato l'ultimo importante lavoro di King per AD&D. Successivamente, ha trascorso la maggior parte del suo tempo nella scrittura di romanzi. Dopo la sua gravidanza, la Brown non ha più lavorato nel mondo dei giochi di ruolo per diversi anni, ma sarebbe tornata sul campo nel 1997 e 1998. Le curiosità sul prodotto sono state tratte dal magnifico lavoro di Shannon Appelcline: Designers & Dragons – storia dell'industria del gioco di ruolo
-
ManaDinamica – Magia ed Entropia
Dopo averci parlato di Magia e conservazione dell'energia, in questo articolo il prof. Marrelli ci parla di Magie e entropia. La magia può sembrare una cosa meravigliosa: si tratta di uno strumento in grado di fare, in prima approssimazione, qualunque cosa. Abbiamo tuttavia già visto nel precedente articolo che la faccenda non è così semplice: infatti, per ottenere un qualunque effetto magico che sia fisicamente coerente, abbiamo bisogno di spendere energia. E abbiamo bisogno di ottenere questa energia da qualche parte. Ma il problema non si ferma qui: ogni volta che l’energia viene trasformata da una forma all’altra, una porzione di essa sempre maggiore viene dispersa, diventando inutilizzabile per il suo scopo originario Oggi parliamo del secondo principio della termodinamica… applicato alla magia! Calore e movimento Se mettiamo a contatto tra loro due oggetti a diverse temperature, il più caldo comincerà a raffreddarsi e il più freddo a scaldarsi finché non raggiungeranno la stessa temperatura. Questo fenomeno, detto “principio zero della termodinamica”, è evidente se mettiamo un cubetto di ghiaccio nell’acqua d’estate: il cubetto si scalda, sciogliendosi, ma nel farlo raffredda l’acqua. Quello che è accaduto è che una certa quantità di energia, detta calore, ha abbandonato il corpo caldo, raffreddandolo, per introdursi in quello più freddo e riscaldarlo. Questo passaggio di energia può essere “imbrigliato” per ottenere movimento: le macchine in grado di compiere queste trasformazioni sono dette Motori Termici, tra cui il motore a scoppio, il motore stirling e l’immancabile motore a vapore. Un modellino di motore stirling. Una lieve differenza di temperatura tra il sopra e il sotto della base è sufficiente per far girare la ruota. Un motore termico ha infatti bisogno di due “ambienti”, uno più caldo dell’altro, e la sua capacità di funzionamento dipende proprio da tale differenza di temperatura. Quando, nel mondo reale, gli scienziati, ingegneri e inventori del ‘700 e ‘800 cominciarono a studiare il rapporto tra il calore fornito a una macchina a vapore e l’energia meccanica (cioè legata allo spostamento della vaporiera) che essa era in grado di rilasciare, si accorsero che una porzione di tale energia veniva perduta. Infatti, parte di quel calore andava comunque a riscaldare l’ambiente esterno, più freddo ovviamente della caldaia: questo implica che, se da una parte l’aria esterna circola ed è in grado di rinnovarsi, la caldaia va via via raffreddandosi e richiede sempre nuovo combustibile. Per quanto si possano migliorare numerose parti di un motore, per esempio riducendo gli attriti (che dissipano ulteriore preziosa energia), una porzione di dispersioni energetiche dovute a questo scambio di calore sarà sempre, inesorabilmente presente. Tale evidenza portò a una delle formulazioni del “Secondo Principio della Termodinamica”, quella di Lord Kelvin: “È impossibile realizzare una trasformazione ciclica il cui unico risultato sia la trasformazione in lavoro di tutto il calore assorbito da una sorgente omogenea” Fu questa triste scoperta, l’inevitabile dispersione dell’energia, che portò gli scienziati del tempo alla definizione di una nuova grandezza fisica: l’Entropia. Energie inutilizzabili L’Entropia viene spesso definita come lo “stato di disordine di un sistema”, ma si tratta di una definizione che può confondere: infatti non si tratta banalmente di sistemi nei quali gli elementi siano “riposti ordinatamente”. Due oggetti a temperature diverse e a contatto tra loro, infatti, sono ugualmente “ordinati” prima o dopo aver scambiato calore tra loro. Quello che invece sappiamo grazie ai motori termici è che se due oggetti hanno temperature diverse è possibile usarli per generare energia meccanica, mentre questo è impossibile se hanno la stessa temperatura. In questo secondo caso, infatti, la loro energia è stata “distribuita” tra di essi, mentre inizialmente essa era “disponibile” per generare lavoro. Se immaginiamo le unità di energia termica come palline, esse possono essere utilizzate per produrre movimento solo finché sono separate Badate bene che, dopo lo scambio di calore, tale energia non è stata “perduta” nel nulla: l’energia totale è conservata e così il primo principio della termodinamica, solo essa non è più “sfruttabile” alla stessa maniera. La sua “qualità” è diminuita. L’Entropia è, di fatto, la misura di questa “riduzione di qualità” dell’energia di un sistema. Un’evidenza nata sia dall’osservazione naturale che dagli studi di Carnot è che l’entropia è sempre in continua, inesorabile crescita, e quindi la “qualità” dell’energia è in perenne calo. Ciò ha portato a un’ulteriore formulazione del secondo principio della termodinamica: “in un sistema isolato l’entropia non può mai diminuire”. Tutti i fenomeni spontanei, infatti, aumentano (o quantomeno mantengono inalterata) l’entropia del sistema: il calore fluisce da un corpo caldo a uno freddo, anche quando si cerca di imbrigliarlo con un motore, riducendo inevitabilmente l’efficacia del processo (come abbiamo già visto). Tutti i fenomeni naturali che portano alla dispersione dell’energia sono prima o poi inevitabili: il ghiaccio fonde, gli oggetti cadono, il ferro si ossida, le pile si scaricano, le stelle si spengono e gli esseri viventi, alla fine, periscono. Questo non significa che sia impossibile ottenere effetti opposti a quelli spontanei: abbiamo ad esempio inventato frigoriferi e condizionatori per abbassare la temperatura. Tuttavia, tali macchinari si “limitano” a spostare il calore, ad esempio, del cibo congelato nell’ambiente fuori dal frigo, e consumano energia per farlo: parte di questa energia poi, ovviamente, non sarà utilizzabile per raffreddare gli alimenti ma verrà dispersa. Se noi cercassimo di utilizzare la differenza di temperatura tra frigo e stanza per alimentare un motore termico, otterremmo ancora meno energia di quella necessaria per mantenere il cibo congelato. L’energia necessaria per raffreddare un oggetto è insomma superiore a quella che si otterrebbe utilizzandolo come ambiente freddo per un motore termico: questo perché parte di quell’energia è stata dispersa proprio a causa dell’entropia. Come per un cambio di valuta, scambiare euro per dollari avrà un costo: riscambiando indietro dollari con euro, un ulteriore costo, ci troveremmo in mano meno soldi di quelli iniziali. Ogni trasformazione d’energia riduce quella disponibile per nella nuova forma, disperdendone inevitabilmente altra a causa dell’entropia Inoltre, andando ad effettuare il calcolo, vedremmo che, dove l’entropia dell’interno del frigorifero è diminuita, quella del suo esterno è aumentata di una quantità superiore: l’entropia totale infatti aumenta sempre. A seguito di un’azione su un sistema che ne riduca l’entropia ci sarà sempre un sistema più grande che lo circondi la cui entropia totale è aumentata (o al limite è rimasta identica): si dice in gergo che “l’entropia dell’universo” non può mai diminuire. Come per i frigoriferi, anche i meccanismi degli esseri viventi riescono a mantenere sotto controllo l’entropia, a scapito tuttavia delle sostanze che espellono: gli scarti del corpo umano, se anche non fossero per esso dannosi, sarebbero comunque meno nutrienti dell’equivalente cibo necessario per crearli. Se fossimo in grado di assimilare gli elementi nutritivi del terreno e produrre autonomamente determinate molecole biologiche necessarie per il nostro organismo, come alcune proteine, troveremmo svantaggioso nutrirci di piante e animali poiché il loro “passaggio” ha rubato energia. Ogni trasformazione di energia ha, infatti, un determinato “rendimento”, cioè una percentuale dell’energia investita che è effettivamente utilizzabile dopo una trasformazione: il rendimento è sempre inferiore al 100% e tale perdita, dovuta all’entropia, va accumulandosi ad ogni passaggio. Se, per esempio, della benzina viene bruciata per spingere un’automobile, tale processo è più efficiente (si ha cioè a disposizione più energia effettiva) che se tale motore fosse usato per produrre energia elettrica ed essa, a sua volta, utilizzata per alimentare un motore elettrico di un’automobile: motivo per cui le auto elettriche sono efficienti e meno inquinanti solo se ci sono scelte oculate nella produzione dell’energia elettrica. A loro volta, i combustibili fossili come il petrolio, “fonti” di energia, non sono che l’effetto della degradazione di energie ben superiori accumulate milioni di anni fa durante la crescita, ad esempio, delle piante ormai fossilizzate e dell’azione dei batteri su di esse: l’energia spesa, insomma, per creare un albero e trasformarlo in carbone fossile è superiore a quella ottenuta bruciando quello stesso combustibile. Per riassumere il concetto, l’entropia è la misura della degradazione dell’energia di un sistema: essa aumenta inesorabilmente a ogni trasformazione d’energia, rendendola sempre più inutilizzabile e portando spontaneamente a fenomeni come la dispersione del calore, dell’energia e la devastazione del tempo. Gli effetti sulla magia Ma quali effetti avrebbe l’entropia sulla magia, alla luce anche dell’articolo precedente? Tanto per cominciare, l’energia magica disponibile sarebbe, se possibile, ancora meno. Che sia accumulata fuori o dentro il mago, l’energia magica tenderebbe a disperdersi: sarebbe forse questo fenomeno a concedere l’esistenza di incantesimi che permettano la percezione della magia. Questo implicherebbe, per esempio, che gli effetti magici vadano a svanire nel tempo e causino tutti quei classici eventi come l’indebolimento dei sigilli magici per trattenere chissà quale oscuro demone del passato. Sarebbe anche molto in linea con tutte quelle ambientazioni nelle quali la magia si è via via ridotta e non sia più facile come un tempo produrre chissà quali effetti meravigliosi, un classico anche di tanti racconti che pongono spesso le vicende in epoche successive a quelle degli dei e degli eroi: un tale sapore si respira, ad esempio, nelle Cronache del ghiaccio e del fuoco, nel Signore degli Anelli ma anche, da un certo punto di vista, in ambientazioni dove magia e tecnologia si confondono come Warhammer 40.000. Ma come giustificare la presenza di antichi artefatti di ere perdute in grado di garantire immensi poteri, come quelli tipici della terra di mezzo? Una maniera per limitare lo scambio di energia al minimo è quello di utilizzare contenitori adiabatici, che riescono quasi ad azzerare lo scambio di calore (chiaramente non è possibile azzerare completamente le perdite per un tempo infinito… proprio per colpa dell’entropia!). L’idea di ridurre la dispersione dell’energia è ampiamente utilizzata in ambito tecnologico per materiali isolanti (basta pensare all’edilizia o ai termos) nonché per altre applicazioni come i Volani, pesanti oggetti tenuti in rotazione nel vuoto su cuscinetti magnetici in modo che non disperdano il loro movimento rotatorio (il quale viene poi utilizzato, all’occorrenza, per produrre energia). Impedire a un oggetto magico di rilasciare energia potrebbe essere sia una maniera per allungare la sua vita sia, nell’ottica precedente, di celarne la natura. Ma un oggetto di potere immenso in grado di durare millenni potrebbe somigliare di più a una forma di vita magica, che ottiene la sua energia dall’ambiente esattamente come le piante (entro un certo limite) dal sole. In base a come funzioni il mana in un mondo di finzione, oggetti e creature che si nutrono di esso potrebbero ridurne la disponibilità magica in una determinata area, cosa che potrebbe portare a divertenti implicazioni. Ma l’effetto più importante dell’entropia sulla magia è che la sua energia è ancora più preziosa: ad ogni trasformazione, infatti, viene dissipata, che sia per il passaggio dal metabolismo umano a una riserva magica, dall’ambiente circostante agli incantesimi stessi. Gli incantesimi poi dovrebbero, se possibile, agire in maniera estremamente diretta: sollevare un masso, per esempio, dovrebbe evitare di richiedere l’apertura di un portale sul piano elementale dell’aria per manifestare una corrente ascensionale (anche se può darsi che un mero sollevamento non sia poi così facile da ottenere… ma ne parleremo oltre!). Alla stessa maniera, una palla di fuoco potrebbe essere ottenuta separando ossigeno e idrogeno nel vapore acqueo presente nell’aria, spezzando i loro legami tra loro e ottenendo, per ricombinazione, un effetto esplosivo… ma questo richiederebbe un enorme dispendio di energia. Perfino l’arco elettrico di un fulmine sarebbe molto più semplice da causare, ma richiederebbe comunque più energia di una punta affilata sparata magicamente sul nemico. Diversa invece la situazione se queste energie magiche fossero presenti e pronte a svilupparsi in maniera selvaggia: in tal caso, il mago potrebbe limitarsi a gestire con perizia il flusso magico incontrollato, lasciando la dispersione energetica più grande alla fonte magica… Articolo originale: http://www.profmarrelli.it/2020/01/22/manadinamica-magia-ed-entropia/ Se questo articolo ti è piaciuto, segui il prof. Marrelli su facebook e su ludomedia. Visualizza articolo completo
-
ManaDinamica – Magia ed Entropia
La magia può sembrare una cosa meravigliosa: si tratta di uno strumento in grado di fare, in prima approssimazione, qualunque cosa. Abbiamo tuttavia già visto nel precedente articolo che la faccenda non è così semplice: infatti, per ottenere un qualunque effetto magico che sia fisicamente coerente, abbiamo bisogno di spendere energia. E abbiamo bisogno di ottenere questa energia da qualche parte. Ma il problema non si ferma qui: ogni volta che l’energia viene trasformata da una forma all’altra, una porzione di essa sempre maggiore viene dispersa, diventando inutilizzabile per il suo scopo originario Oggi parliamo del secondo principio della termodinamica… applicato alla magia! Calore e movimento Se mettiamo a contatto tra loro due oggetti a diverse temperature, il più caldo comincerà a raffreddarsi e il più freddo a scaldarsi finché non raggiungeranno la stessa temperatura. Questo fenomeno, detto “principio zero della termodinamica”, è evidente se mettiamo un cubetto di ghiaccio nell’acqua d’estate: il cubetto si scalda, sciogliendosi, ma nel farlo raffredda l’acqua. Quello che è accaduto è che una certa quantità di energia, detta calore, ha abbandonato il corpo caldo, raffreddandolo, per introdursi in quello più freddo e riscaldarlo. Questo passaggio di energia può essere “imbrigliato” per ottenere movimento: le macchine in grado di compiere queste trasformazioni sono dette Motori Termici, tra cui il motore a scoppio, il motore stirling e l’immancabile motore a vapore. Un modellino di motore stirling. Una lieve differenza di temperatura tra il sopra e il sotto della base è sufficiente per far girare la ruota. Un motore termico ha infatti bisogno di due “ambienti”, uno più caldo dell’altro, e la sua capacità di funzionamento dipende proprio da tale differenza di temperatura. Quando, nel mondo reale, gli scienziati, ingegneri e inventori del ‘700 e ‘800 cominciarono a studiare il rapporto tra il calore fornito a una macchina a vapore e l’energia meccanica (cioè legata allo spostamento della vaporiera) che essa era in grado di rilasciare, si accorsero che una porzione di tale energia veniva perduta. Infatti, parte di quel calore andava comunque a riscaldare l’ambiente esterno, più freddo ovviamente della caldaia: questo implica che, se da una parte l’aria esterna circola ed è in grado di rinnovarsi, la caldaia va via via raffreddandosi e richiede sempre nuovo combustibile. Per quanto si possano migliorare numerose parti di un motore, per esempio riducendo gli attriti (che dissipano ulteriore preziosa energia), una porzione di dispersioni energetiche dovute a questo scambio di calore sarà sempre, inesorabilmente presente. Tale evidenza portò a una delle formulazioni del “Secondo Principio della Termodinamica”, quella di Lord Kelvin: “È impossibile realizzare una trasformazione ciclica il cui unico risultato sia la trasformazione in lavoro di tutto il calore assorbito da una sorgente omogenea” Fu questa triste scoperta, l’inevitabile dispersione dell’energia, che portò gli scienziati del tempo alla definizione di una nuova grandezza fisica: l’Entropia. Energie inutilizzabili L’Entropia viene spesso definita come lo “stato di disordine di un sistema”, ma si tratta di una definizione che può confondere: infatti non si tratta banalmente di sistemi nei quali gli elementi siano “riposti ordinatamente”. Due oggetti a temperature diverse e a contatto tra loro, infatti, sono ugualmente “ordinati” prima o dopo aver scambiato calore tra loro. Quello che invece sappiamo grazie ai motori termici è che se due oggetti hanno temperature diverse è possibile usarli per generare energia meccanica, mentre questo è impossibile se hanno la stessa temperatura. In questo secondo caso, infatti, la loro energia è stata “distribuita” tra di essi, mentre inizialmente essa era “disponibile” per generare lavoro. Se immaginiamo le unità di energia termica come palline, esse possono essere utilizzate per produrre movimento solo finché sono separate Badate bene che, dopo lo scambio di calore, tale energia non è stata “perduta” nel nulla: l’energia totale è conservata e così il primo principio della termodinamica, solo essa non è più “sfruttabile” alla stessa maniera. La sua “qualità” è diminuita. L’Entropia è, di fatto, la misura di questa “riduzione di qualità” dell’energia di un sistema. Un’evidenza nata sia dall’osservazione naturale che dagli studi di Carnot è che l’entropia è sempre in continua, inesorabile crescita, e quindi la “qualità” dell’energia è in perenne calo. Ciò ha portato a un’ulteriore formulazione del secondo principio della termodinamica: “in un sistema isolato l’entropia non può mai diminuire”. Tutti i fenomeni spontanei, infatti, aumentano (o quantomeno mantengono inalterata) l’entropia del sistema: il calore fluisce da un corpo caldo a uno freddo, anche quando si cerca di imbrigliarlo con un motore, riducendo inevitabilmente l’efficacia del processo (come abbiamo già visto). Tutti i fenomeni naturali che portano alla dispersione dell’energia sono prima o poi inevitabili: il ghiaccio fonde, gli oggetti cadono, il ferro si ossida, le pile si scaricano, le stelle si spengono e gli esseri viventi, alla fine, periscono. Questo non significa che sia impossibile ottenere effetti opposti a quelli spontanei: abbiamo ad esempio inventato frigoriferi e condizionatori per abbassare la temperatura. Tuttavia, tali macchinari si “limitano” a spostare il calore, ad esempio, del cibo congelato nell’ambiente fuori dal frigo, e consumano energia per farlo: parte di questa energia poi, ovviamente, non sarà utilizzabile per raffreddare gli alimenti ma verrà dispersa. Se noi cercassimo di utilizzare la differenza di temperatura tra frigo e stanza per alimentare un motore termico, otterremmo ancora meno energia di quella necessaria per mantenere il cibo congelato. L’energia necessaria per raffreddare un oggetto è insomma superiore a quella che si otterrebbe utilizzandolo come ambiente freddo per un motore termico: questo perché parte di quell’energia è stata dispersa proprio a causa dell’entropia. Come per un cambio di valuta, scambiare euro per dollari avrà un costo: riscambiando indietro dollari con euro, un ulteriore costo, ci troveremmo in mano meno soldi di quelli iniziali. Ogni trasformazione d’energia riduce quella disponibile per nella nuova forma, disperdendone inevitabilmente altra a causa dell’entropia Inoltre, andando ad effettuare il calcolo, vedremmo che, dove l’entropia dell’interno del frigorifero è diminuita, quella del suo esterno è aumentata di una quantità superiore: l’entropia totale infatti aumenta sempre. A seguito di un’azione su un sistema che ne riduca l’entropia ci sarà sempre un sistema più grande che lo circondi la cui entropia totale è aumentata (o al limite è rimasta identica): si dice in gergo che “l’entropia dell’universo” non può mai diminuire. Come per i frigoriferi, anche i meccanismi degli esseri viventi riescono a mantenere sotto controllo l’entropia, a scapito tuttavia delle sostanze che espellono: gli scarti del corpo umano, se anche non fossero per esso dannosi, sarebbero comunque meno nutrienti dell’equivalente cibo necessario per crearli. Se fossimo in grado di assimilare gli elementi nutritivi del terreno e produrre autonomamente determinate molecole biologiche necessarie per il nostro organismo, come alcune proteine, troveremmo svantaggioso nutrirci di piante e animali poiché il loro “passaggio” ha rubato energia. Ogni trasformazione di energia ha, infatti, un determinato “rendimento”, cioè una percentuale dell’energia investita che è effettivamente utilizzabile dopo una trasformazione: il rendimento è sempre inferiore al 100% e tale perdita, dovuta all’entropia, va accumulandosi ad ogni passaggio. Se, per esempio, della benzina viene bruciata per spingere un’automobile, tale processo è più efficiente (si ha cioè a disposizione più energia effettiva) che se tale motore fosse usato per produrre energia elettrica ed essa, a sua volta, utilizzata per alimentare un motore elettrico di un’automobile: motivo per cui le auto elettriche sono efficienti e meno inquinanti solo se ci sono scelte oculate nella produzione dell’energia elettrica. A loro volta, i combustibili fossili come il petrolio, “fonti” di energia, non sono che l’effetto della degradazione di energie ben superiori accumulate milioni di anni fa durante la crescita, ad esempio, delle piante ormai fossilizzate e dell’azione dei batteri su di esse: l’energia spesa, insomma, per creare un albero e trasformarlo in carbone fossile è superiore a quella ottenuta bruciando quello stesso combustibile. Per riassumere il concetto, l’entropia è la misura della degradazione dell’energia di un sistema: essa aumenta inesorabilmente a ogni trasformazione d’energia, rendendola sempre più inutilizzabile e portando spontaneamente a fenomeni come la dispersione del calore, dell’energia e la devastazione del tempo. Gli effetti sulla magia Ma quali effetti avrebbe l’entropia sulla magia, alla luce anche dell’articolo precedente? Tanto per cominciare, l’energia magica disponibile sarebbe, se possibile, ancora meno. Che sia accumulata fuori o dentro il mago, l’energia magica tenderebbe a disperdersi: sarebbe forse questo fenomeno a concedere l’esistenza di incantesimi che permettano la percezione della magia. Questo implicherebbe, per esempio, che gli effetti magici vadano a svanire nel tempo e causino tutti quei classici eventi come l’indebolimento dei sigilli magici per trattenere chissà quale oscuro demone del passato. Sarebbe anche molto in linea con tutte quelle ambientazioni nelle quali la magia si è via via ridotta e non sia più facile come un tempo produrre chissà quali effetti meravigliosi, un classico anche di tanti racconti che pongono spesso le vicende in epoche successive a quelle degli dei e degli eroi: un tale sapore si respira, ad esempio, nelle Cronache del ghiaccio e del fuoco, nel Signore degli Anelli ma anche, da un certo punto di vista, in ambientazioni dove magia e tecnologia si confondono come Warhammer 40.000. Ma come giustificare la presenza di antichi artefatti di ere perdute in grado di garantire immensi poteri, come quelli tipici della terra di mezzo? Una maniera per limitare lo scambio di energia al minimo è quello di utilizzare contenitori adiabatici, che riescono quasi ad azzerare lo scambio di calore (chiaramente non è possibile azzerare completamente le perdite per un tempo infinito… proprio per colpa dell’entropia!). L’idea di ridurre la dispersione dell’energia è ampiamente utilizzata in ambito tecnologico per materiali isolanti (basta pensare all’edilizia o ai termos) nonché per altre applicazioni come i Volani, pesanti oggetti tenuti in rotazione nel vuoto su cuscinetti magnetici in modo che non disperdano il loro movimento rotatorio (il quale viene poi utilizzato, all’occorrenza, per produrre energia). Impedire a un oggetto magico di rilasciare energia potrebbe essere sia una maniera per allungare la sua vita sia, nell’ottica precedente, di celarne la natura. Ma un oggetto di potere immenso in grado di durare millenni potrebbe somigliare di più a una forma di vita magica, che ottiene la sua energia dall’ambiente esattamente come le piante (entro un certo limite) dal sole. In base a come funzioni il mana in un mondo di finzione, oggetti e creature che si nutrono di esso potrebbero ridurne la disponibilità magica in una determinata area, cosa che potrebbe portare a divertenti implicazioni. Ma l’effetto più importante dell’entropia sulla magia è che la sua energia è ancora più preziosa: ad ogni trasformazione, infatti, viene dissipata, che sia per il passaggio dal metabolismo umano a una riserva magica, dall’ambiente circostante agli incantesimi stessi. Gli incantesimi poi dovrebbero, se possibile, agire in maniera estremamente diretta: sollevare un masso, per esempio, dovrebbe evitare di richiedere l’apertura di un portale sul piano elementale dell’aria per manifestare una corrente ascensionale (anche se può darsi che un mero sollevamento non sia poi così facile da ottenere… ma ne parleremo oltre!). Alla stessa maniera, una palla di fuoco potrebbe essere ottenuta separando ossigeno e idrogeno nel vapore acqueo presente nell’aria, spezzando i loro legami tra loro e ottenendo, per ricombinazione, un effetto esplosivo… ma questo richiederebbe un enorme dispendio di energia. Perfino l’arco elettrico di un fulmine sarebbe molto più semplice da causare, ma richiederebbe comunque più energia di una punta affilata sparata magicamente sul nemico. Diversa invece la situazione se queste energie magiche fossero presenti e pronte a svilupparsi in maniera selvaggia: in tal caso, il mago potrebbe limitarsi a gestire con perizia il flusso magico incontrollato, lasciando la dispersione energetica più grande alla fonte magica… Articolo originale: http://www.profmarrelli.it/2020/01/22/manadinamica-magia-ed-entropia/ Se questo articolo ti è piaciuto, segui il prof. Marrelli su facebook e su ludomedia.
-
Guidiamo assieme la DL verso il futuro
Controlla ora.
-
ManaDinamica – Conservazione dell’Energia
Uno dei problemi da affrontare, nei giochi e nella fiction in generale, dovuto all’introduzione della magia è integrare tali fenomeni all’interno del mondo per creare un contesto coerente e in qualche modo credibile. In questa rubrica, dedicata soprattutto agli inventori di mondi (che siano scrittori o dungeon master), cercheremo di analizzare come potrebbe funzionare una magia “fisicamente corretta” ed evitare la classica domanda: “ma perché, se c’è la magia, la gente continua a zappare la terra e morire in modi atroci?”. IL PROBLEMA ENERGETICO Se la magia fosse fisicamente corretta, dovrebbe rispettare alcune leggi fra le quali i famosi Principi della Termodinamica (o, per l’occasione, della “Manadinamica”). Tra questi, il primo è il cosiddetto “Principio di conservazione dell’Energia” che richiede che l’energia totale coinvolta in un fenomeno sia conservata, cioè che la sua quantità totale al termine del processo sia uguale a quella iniziale (contando, in entrambi i casi, tutte le forme di energia presente). Ma cos’è l’Energia? L’Energia è una grandezza fisica che descrive vari fenomeni simili capaci di trasformarsi l’uno nell’altro: l’energia elettrica usata per alimentare una stufa si trasforma in energia termica, e quella termica in un motore produce energia meccanica sotto forma di velocità (energia cinetica) e/o sollevando pesanti carichi (energia potenziale). Ma l’energia è anche la base del funzionamento del nostro corpo: noi otteniamo energia dal cibo che mangiamo (dove è accumulata in forma di energia chimica dei suoi costituenti nutritivi) e usiamo questa energia per muoverci, respirare, pensare e per il corretto funzionamento del nostro metabolismo. Possiamo dire tranquillamente che la stragrande maggioranza dei fenomeni che conosciamo prevede trasformazioni e scambi di energia, e la magia non può non ricadere in questo sistema: per sollevare un masso con il potere di un incantesimo, l’energia necessaria deve essere ottenuta da qualche parte. È questo continuo richiamo al “pagamento” di energia che permette di creare un sistema magico fisicamente coerente. Non solo, l’incantesimo deve richiedere tutta l’energia necessaria per ottenere l’effetto desiderato: la generazione di temperature estreme di una palla di fuoco, la crescita di una pianta o lo spostamento di masse ingenti può richiedere una quantità estrema di energia, e talvolta anche difficile da calcolare (soprattutto quando ci sono di mezzo creature viventi o teletrasporti, ma avremo modo di parlarne in altri articoli). Cerchiamo dunque di rispondere alla domanda: da dove proviene tutta questa energia? MICROORGANISMI E CONDENSATORI Una prima possibilità evidente è che l’energia possa essere ottenuta da quella del mago stesso. Il corpo umano consuma l’energia ottenuta dal cibo per le sue attività, compresa una fetta importante (circa il 60-70%) unicamente per mantenere le funzioni vitali come la respirazione, la circolazione, il pensiero e il mantenimento della temperatura. Un essere umano, in base all’età, al sesso e all’attività che compie, ha un consumo energetico quotidiano che può andare tra le 1500 e le 2500 kilocalorie circa: la stessa quantità di energia, espressa in Joule (l’unità di misura dell’energia nel sistema internazionale), oscilla tra i 6300 e i 10500 KiloJoule. Se fosse possibile prendere una piccola frazione, ad esempio l’1% dell’energia di una “persona media” (8000 KJ per comodità), avremmo a disposizione 80 KJ, cioè 80.000 Joule. Ma “quanti” sono 80.000 Joule? Sono, ad esempio, pari all’energia necessaria per sollevare di un metro un masso di 8 tonnellate! L’energia per una simile impresa titanica, ben lontana dalle capacità umane e facilmente assimilabile a un “prodigio magico”, è pari al solo 1% dell’energia consumata da un essere umano “medio”. Ciò che impedisce a una persona di usare la sua energia in questa maniera è il concetto di “potenza”, cioè l’ammontare di energia che può essere emessa in un determinato ammontare di tempo. I nostri muscoli non sono abbastanza potenti da sollevare massi di una tonnellata (1000 kg) in alto di un metro, ma più che capaci di trasportare un oggetto di 10 kg per un dislivello di 100 metri: queste due azioni richiedono lo stesso ammontare di energia, ma la prima richiede molta più forza e molto meno tempo. Se riuscissimo a rilasciare energia in tempi inferiori, potremmo letteralmente dare vita alla magia partendo dalla stessa energia dei corpi umani: ma come accumulare questa energia e rilasciarla tutta assieme? Un mago potrebbe avere una “riserva” di energia magica che viene lentamente ricaricata dal suo stesso metabolismo e che può essere rilasciata rapidamente dando vita a effetti magici, e l’energia mancante del mago potrebbe giustificare la classica carenza di forza fisica che accomuna i maghi in molti giochi di ruolo. Un’opzione potrebbe essere fare ricorso a sostanze prodotte dall’organismo e accumulate in appositi tessuti, come facciamo già nella realtà con i grassi, in grado di essere “bruciate” per ottenere un picco di energia. Se invece non volessimo alterare la biologia umana, potremmo immaginarci un microorganismo simbiontico simile ai famosi Midi-Chlorian di Star Wars, in grado di sopravvivere solo in organismi molto specifici (magari in maniera simile a quello che accade con gli antigeni del sangue, solo più complesso). Infine, il mago potrebbe ottenere energia sottraendola dagli esseri viventi circostanti, in pieno stile “rituali sacrificali” o, più semplicemente, prendendo ispirazione dalla recente serie di The Witcher. Il rilascio dell’energia dovrebbe essere rapido, con un funzionamento simile a quello del flash delle macchine fotografiche. Le pile, infatti, non sono in grado di fornire una potenza sufficiente per il lampo: il flash, in questo caso, è ottenuto da un Condensatore, un componente dei circuiti in grado di accumulare al suo interno cariche elettriche (cioè, sostanzialmente, elettroni, le particelle che compongono la corrente elettrica) e di scaricarsi molto velocemente. In questo modo, anche se la velocità di ricarica della pila è ridotta, il condensatore è in grado di fornire rapidamente una grande quantità di energia per il flash: allo stesso modo, un mago dovrebbe essere in grado di bruciare rapidamente la sua riserva energetica per ottenere, in poco tempo, grandi quantità di energia per dare vita ai suoi incantesimi. Un condensatore. La vostra scheda madre ne è piena. CATALIZZATORI Se invece l’energia fosse ottenuta esternamente dal mago, come potrebbe egli averne accesso? E come giustificare una quantità limitata di uso di tale potere? Sempre pensando a un consumo (almeno iniziale) di energia da parte del mago, si potrebbe ipotizzare un’interazione tra il mago e una sostanza esterna, simile alla Trama nel mondo di Forgotten Realms, grazie al quale il mago ottiene i suoi effetti facendo da catalizzatore. In chimica, molti processi che trasmettono energia verso l’esterno (esoergodici) non avvengono spontaneamente, ma devono essere “stimolati” tramite una certa quantità di energia iniziale, detta energia di attivazione. Si può immaginare, ad esempio, che una certa reazione rilasci 5 Joule di energia, ma che la sostanza debba prima ricevere due Joule come energia di attivazione per avere inizio. Un esempio pratico di questi fenomeni sono le combustioni, delle quali parleremo in un futuro articolo: un oggetto che brucia emette energia termica, ma ha prima bisogno di un innesco, un evento in grado di fornirgli l’energia necessaria per far partire la combustione. Un Catalizzatore è un elemento, di solito una sostanza chimica, in grado di produrre un effetto di Catalisi, cioè di ridurre l’energia di attivazione: nell’esempio precedente la reazione potrebbe, grazie a un catalizzatore, richiedere un solo Joule per avere inizio. Se il mago fosse in grado di agire da catalizzatore per la magia, questo spiegherebbe come mai solo i maghi sono in grado di usare tale potere, cioè perché l’energia di attivazione è troppo elevata e i non-maghi non sono in grado di abbassarla. Contemporaneamente, se fosse sempre lui a fornire l’energia iniziale (ridotta grazie alla catalisi) si giustificherebbe anche un utilizzo limitato della magia da parte dell’incantatore. MASSA ED ENERGIA Un’ultima, notevole fonte di energia è la cosiddetta annichilazione della materia: la possibilità cioè di trasformare direttamente materia in energia mediante la famosa formula di Einstein. Si tratta di una quantità di energia enorme: mezzo grammo di materia produrrebbe la stessa energia della bomba di Hiroshima. Fortunatamente si tratta, nel mondo reale, di un processo assai complesso da ottenere: per avere una annichilazione è necessario far incontrare ogni particella del nostro materiale con la sua antiparticella. Queste ultime sono complesse da ottenere e prodotte solo da reazioni nucleari rare e altresì molto costose, in termini energetici (e non), da ottenere: all’attuale stato delle cose, il più grande apparato in grado di generare tali antiparticelle (il Large Hadron Collider, o LHC, del CERN di Ginevra) sarebbe in grado di ottenere un grammo di antimateria in… qualche milione di anni! Tuttavia, immaginando di ottenere energia dai due processi precedenti, sarebbe forse possibile annichilire quantità di materia sufficientemente piccole da concedere comunque effetti prodigiosi… se l’antimateria fosse già presente. Infatti, produrre antimateria richiede processi molto più costosi (in termini di energie) di quanto poi riottenuto dall’annichilazione, fino a 10 miliardi di volte tanto. Anche se, infine, essa fosse già disponibile al mago, questi dovrebbe assicurarsi di mantenere l’antimateria confinata nel vuoto, impedendogli di interagire con qualunque genere di materia, perfino l’aria: tale situazione viene comunemente ottenuta, nel mondo reale, tramite potenti campi elettromagnetici che possono risultare letali alle persone che si avvicinano troppo. Sarebbe invece possibile ottenere parte dell’energia dagli atomi mediante fusione e fissione: in questo caso, tuttavia, la quantità di energia ottenuta da ogni atomo è molto inferiore e sarebbero necessarie quantità importanti di materiale (e il materiale giusto!), nonché condizioni peculiari di temperatura e pressione altrettanto complesse da ottenere (che richiederebbero ulteriori, drammatiche energie iniziali). IL PREZZO DA PAGARE Questa (relativamente) vasta serie di opzione potrebbe far pensare che ottenere energia possa essere semplice, ma si tratta di una conclusione errata. Il mago dovrebbe indubbiamente pagare il prezzo iniziale consumando parte della sua stessa energia, energia che, se fosse accumulata in una sorta di condensatore magico, non sarebbe disponibile dell’incantatore (al di fuori del suo uso magico) e lo lascerebbe permanentemente spossato. Se facesse inoltre da catalizzatore per una qualche fonte esterna di energia, essa si andrebbe, nel tempo, a consumare inevitabilmente la fonte di energia magica esterna proprio come i combustibili che diventano inutilizzabili dopo essere bruciati. Infine, la stessa capacità di annichilire materia richiederebbe una grossa fonte di antimateria oppure energie tali da non giustificarne l’utilizzo, e anche l’energia nucleare si potrebbe sfruttare solo con condizioni estreme di temperatura e pressione. E’ evidente dunque che l’idea di usare la magia per affrontare problemi altrimenti risolvibili è una mossa assai sconveniente, e che rivolgersi agli incantesimi dovrebbe essere giustificato solo da una necessità particolare e immediata. E ancora non abbiamo parlato del fatto che non tutta quell’energia può essere utilizzata per lanciare una magia… ma per quello, aspettate il prossimo articolo di Manadinamica! Articolo originale: http://www.profmarrelli.it/2020/01/15/manadinamica-conservazione-energia/ Se questo articolo ti è piaciuto, segui il prof. Marrelli su facebook e su ludomedia.
-
ManaDinamica – Conservazione dell’Energia
Il prof. Marrelli ci parla di come potrebbe funzionare una magia “fisicamente corretta” nei monidi Fantasy. Uno dei problemi da affrontare, nei giochi e nella fiction in generale, dovuto all’introduzione della magia è integrare tali fenomeni all’interno del mondo per creare un contesto coerente e in qualche modo credibile. In questa rubrica, dedicata soprattutto agli inventori di mondi (che siano scrittori o dungeon master), cercheremo di analizzare come potrebbe funzionare una magia “fisicamente corretta” ed evitare la classica domanda: “ma perché, se c’è la magia, la gente continua a zappare la terra e morire in modi atroci?”. IL PROBLEMA ENERGETICO Se la magia fosse fisicamente corretta, dovrebbe rispettare alcune leggi fra le quali i famosi Principi della Termodinamica (o, per l’occasione, della “Manadinamica”). Tra questi, il primo è il cosiddetto “Principio di conservazione dell’Energia” che richiede che l’energia totale coinvolta in un fenomeno sia conservata, cioè che la sua quantità totale al termine del processo sia uguale a quella iniziale (contando, in entrambi i casi, tutte le forme di energia presente). Ma cos’è l’Energia? L’Energia è una grandezza fisica che descrive vari fenomeni simili capaci di trasformarsi l’uno nell’altro: l’energia elettrica usata per alimentare una stufa si trasforma in energia termica, e quella termica in un motore produce energia meccanica sotto forma di velocità (energia cinetica) e/o sollevando pesanti carichi (energia potenziale). Ma l’energia è anche la base del funzionamento del nostro corpo: noi otteniamo energia dal cibo che mangiamo (dove è accumulata in forma di energia chimica dei suoi costituenti nutritivi) e usiamo questa energia per muoverci, respirare, pensare e per il corretto funzionamento del nostro metabolismo. Possiamo dire tranquillamente che la stragrande maggioranza dei fenomeni che conosciamo prevede trasformazioni e scambi di energia, e la magia non può non ricadere in questo sistema: per sollevare un masso con il potere di un incantesimo, l’energia necessaria deve essere ottenuta da qualche parte. È questo continuo richiamo al “pagamento” di energia che permette di creare un sistema magico fisicamente coerente. Non solo, l’incantesimo deve richiedere tutta l’energia necessaria per ottenere l’effetto desiderato: la generazione di temperature estreme di una palla di fuoco, la crescita di una pianta o lo spostamento di masse ingenti può richiedere una quantità estrema di energia, e talvolta anche difficile da calcolare (soprattutto quando ci sono di mezzo creature viventi o teletrasporti, ma avremo modo di parlarne in altri articoli). Cerchiamo dunque di rispondere alla domanda: da dove proviene tutta questa energia? MICROORGANISMI E CONDENSATORI Una prima possibilità evidente è che l’energia possa essere ottenuta da quella del mago stesso. Il corpo umano consuma l’energia ottenuta dal cibo per le sue attività, compresa una fetta importante (circa il 60-70%) unicamente per mantenere le funzioni vitali come la respirazione, la circolazione, il pensiero e il mantenimento della temperatura. Un essere umano, in base all’età, al sesso e all’attività che compie, ha un consumo energetico quotidiano che può andare tra le 1500 e le 2500 kilocalorie circa: la stessa quantità di energia, espressa in Joule (l’unità di misura dell’energia nel sistema internazionale), oscilla tra i 6300 e i 10500 KiloJoule. Se fosse possibile prendere una piccola frazione, ad esempio l’1% dell’energia di una “persona media” (8000 KJ per comodità), avremmo a disposizione 80 KJ, cioè 80.000 Joule. Ma “quanti” sono 80.000 Joule? Sono, ad esempio, pari all’energia necessaria per sollevare di un metro un masso di 8 tonnellate! L’energia per una simile impresa titanica, ben lontana dalle capacità umane e facilmente assimilabile a un “prodigio magico”, è pari al solo 1% dell’energia consumata da un essere umano “medio”. Ciò che impedisce a una persona di usare la sua energia in questa maniera è il concetto di “potenza”, cioè l’ammontare di energia che può essere emessa in un determinato ammontare di tempo. I nostri muscoli non sono abbastanza potenti da sollevare massi di una tonnellata (1000 kg) in alto di un metro, ma più che capaci di trasportare un oggetto di 10 kg per un dislivello di 100 metri: queste due azioni richiedono lo stesso ammontare di energia, ma la prima richiede molta più forza e molto meno tempo. Se riuscissimo a rilasciare energia in tempi inferiori, potremmo letteralmente dare vita alla magia partendo dalla stessa energia dei corpi umani: ma come accumulare questa energia e rilasciarla tutta assieme? Un mago potrebbe avere una “riserva” di energia magica che viene lentamente ricaricata dal suo stesso metabolismo e che può essere rilasciata rapidamente dando vita a effetti magici, e l’energia mancante del mago potrebbe giustificare la classica carenza di forza fisica che accomuna i maghi in molti giochi di ruolo. Un’opzione potrebbe essere fare ricorso a sostanze prodotte dall’organismo e accumulate in appositi tessuti, come facciamo già nella realtà con i grassi, in grado di essere “bruciate” per ottenere un picco di energia. Se invece non volessimo alterare la biologia umana, potremmo immaginarci un microorganismo simbiontico simile ai famosi Midi-Chlorian di Star Wars, in grado di sopravvivere solo in organismi molto specifici (magari in maniera simile a quello che accade con gli antigeni del sangue, solo più complesso). Infine, il mago potrebbe ottenere energia sottraendola dagli esseri viventi circostanti, in pieno stile “rituali sacrificali” o, più semplicemente, prendendo ispirazione dalla recente serie di The Witcher. Il rilascio dell’energia dovrebbe essere rapido, con un funzionamento simile a quello del flash delle macchine fotografiche. Le pile, infatti, non sono in grado di fornire una potenza sufficiente per il lampo: il flash, in questo caso, è ottenuto da un Condensatore, un componente dei circuiti in grado di accumulare al suo interno cariche elettriche (cioè, sostanzialmente, elettroni, le particelle che compongono la corrente elettrica) e di scaricarsi molto velocemente. In questo modo, anche se la velocità di ricarica della pila è ridotta, il condensatore è in grado di fornire rapidamente una grande quantità di energia per il flash: allo stesso modo, un mago dovrebbe essere in grado di bruciare rapidamente la sua riserva energetica per ottenere, in poco tempo, grandi quantità di energia per dare vita ai suoi incantesimi. Un condensatore. La vostra scheda madre ne è piena. CATALIZZATORI Se invece l’energia fosse ottenuta esternamente dal mago, come potrebbe egli averne accesso? E come giustificare una quantità limitata di uso di tale potere? Sempre pensando a un consumo (almeno iniziale) di energia da parte del mago, si potrebbe ipotizzare un’interazione tra il mago e una sostanza esterna, simile alla Trama nel mondo di Forgotten Realms, grazie al quale il mago ottiene i suoi effetti facendo da catalizzatore. In chimica, molti processi che trasmettono energia verso l’esterno (esoergodici) non avvengono spontaneamente, ma devono essere “stimolati” tramite una certa quantità di energia iniziale, detta energia di attivazione. Si può immaginare, ad esempio, che una certa reazione rilasci 5 Joule di energia, ma che la sostanza debba prima ricevere due Joule come energia di attivazione per avere inizio. Un esempio pratico di questi fenomeni sono le combustioni, delle quali parleremo in un futuro articolo: un oggetto che brucia emette energia termica, ma ha prima bisogno di un innesco, un evento in grado di fornirgli l’energia necessaria per far partire la combustione. Un Catalizzatore è un elemento, di solito una sostanza chimica, in grado di produrre un effetto di Catalisi, cioè di ridurre l’energia di attivazione: nell’esempio precedente la reazione potrebbe, grazie a un catalizzatore, richiedere un solo Joule per avere inizio. Se il mago fosse in grado di agire da catalizzatore per la magia, questo spiegherebbe come mai solo i maghi sono in grado di usare tale potere, cioè perché l’energia di attivazione è troppo elevata e i non-maghi non sono in grado di abbassarla. Contemporaneamente, se fosse sempre lui a fornire l’energia iniziale (ridotta grazie alla catalisi) si giustificherebbe anche un utilizzo limitato della magia da parte dell’incantatore. MASSA ED ENERGIA Un’ultima, notevole fonte di energia è la cosiddetta annichilazione della materia: la possibilità cioè di trasformare direttamente materia in energia mediante la famosa formula di Einstein. Si tratta di una quantità di energia enorme: mezzo grammo di materia produrrebbe la stessa energia della bomba di Hiroshima. Fortunatamente si tratta, nel mondo reale, di un processo assai complesso da ottenere: per avere una annichilazione è necessario far incontrare ogni particella del nostro materiale con la sua antiparticella. Queste ultime sono complesse da ottenere e prodotte solo da reazioni nucleari rare e altresì molto costose, in termini energetici (e non), da ottenere: all’attuale stato delle cose, il più grande apparato in grado di generare tali antiparticelle (il Large Hadron Collider, o LHC, del CERN di Ginevra) sarebbe in grado di ottenere un grammo di antimateria in… qualche milione di anni! Tuttavia, immaginando di ottenere energia dai due processi precedenti, sarebbe forse possibile annichilire quantità di materia sufficientemente piccole da concedere comunque effetti prodigiosi… se l’antimateria fosse già presente. Infatti, produrre antimateria richiede processi molto più costosi (in termini di energie) di quanto poi riottenuto dall’annichilazione, fino a 10 miliardi di volte tanto. Anche se, infine, essa fosse già disponibile al mago, questi dovrebbe assicurarsi di mantenere l’antimateria confinata nel vuoto, impedendogli di interagire con qualunque genere di materia, perfino l’aria: tale situazione viene comunemente ottenuta, nel mondo reale, tramite potenti campi elettromagnetici che possono risultare letali alle persone che si avvicinano troppo. Sarebbe invece possibile ottenere parte dell’energia dagli atomi mediante fusione e fissione: in questo caso, tuttavia, la quantità di energia ottenuta da ogni atomo è molto inferiore e sarebbero necessarie quantità importanti di materiale (e il materiale giusto!), nonché condizioni peculiari di temperatura e pressione altrettanto complesse da ottenere (che richiederebbero ulteriori, drammatiche energie iniziali). IL PREZZO DA PAGARE Questa (relativamente) vasta serie di opzione potrebbe far pensare che ottenere energia possa essere semplice, ma si tratta di una conclusione errata. Il mago dovrebbe indubbiamente pagare il prezzo iniziale consumando parte della sua stessa energia, energia che, se fosse accumulata in una sorta di condensatore magico, non sarebbe disponibile dell’incantatore (al di fuori del suo uso magico) e lo lascerebbe permanentemente spossato. Se facesse inoltre da catalizzatore per una qualche fonte esterna di energia, essa si andrebbe, nel tempo, a consumare inevitabilmente la fonte di energia magica esterna proprio come i combustibili che diventano inutilizzabili dopo essere bruciati. Infine, la stessa capacità di annichilire materia richiederebbe una grossa fonte di antimateria oppure energie tali da non giustificarne l’utilizzo, e anche l’energia nucleare si potrebbe sfruttare solo con condizioni estreme di temperatura e pressione. E’ evidente dunque che l’idea di usare la magia per affrontare problemi altrimenti risolvibili è una mossa assai sconveniente, e che rivolgersi agli incantesimi dovrebbe essere giustificato solo da una necessità particolare e immediata. E ancora non abbiamo parlato del fatto che non tutta quell’energia può essere utilizzata per lanciare una magia… ma per quello, aspettate il prossimo articolo di Manadinamica! Articolo originale: http://www.profmarrelli.it/2020/01/15/manadinamica-conservazione-energia/ Se questo articolo ti è piaciuto, segui il prof. Marrelli su facebook e su ludomedia. View full article
-
Gallery di Tychondriax
Gallery ripristinata.
-
Guidiamo assieme la DL verso il futuro
Si, nessun dato è riconducibile a chicchessia. EDIT: nota aggiunta a inizio sondaggio.
-
Guidiamo assieme la DL verso il futuro
Il form non raccoglie nessun tipo di dato personale. E' tutto anonimo.
-
Nuovo download: Scheda PG D'L versione INGLESE
Vedi il file Scheda PG D'L versione INGLESE ***Aggiornato il 29/10/2014*** Aggiunta la versione compilabile della scheda. Scheda Dragons' Lair in formato A4 per la 5a Edizione di D&D. Questa è la versione INGLESE delle schede Dragons' Lair, sia quella a 4 facciate che quella a 2 facciate. AGGIORNAMNETO 07/06/2014 - La parte incantesimi adesso è uguale alla versione italiana. Per consigli, suggerimenti segnalazioni errori usate questo topic. Grazie. Inviato aza Inserito 04/09/2014 Categoria Schede
-
Scheda PG per D&D 5e by Dragons' Lair
Here you can find the English version: It should be the same as the Italian version.
-
Maestri d’Arme – Jari il Cacciatore di Mostri
Dopo l'uscita della serie TV di The Witcher, dedicata a Geralt di Rivia, il noto Strigo cacciatore di mostri, grande utente di alchimia sulla quale abbiamo già fatto questo precedente articolo. Per l’occasione, abbiamo deciso di intervistare Jari Lanzoni, (qui il suo sito), schermidore e appassionato di fantasy nonché di… lotta ai mostri! Ciao Jari, dicci chi sei e quali sono le tue esperienze in ambito di scherma e fantasy Direi uno strano amalgama di tante cose: direi principalmente un padre e un marito, poi un lettore, uno scrittore e un appassionato di combattimento storico. Al momento lavoro nel settore del turismo dopo aver cambiato una dozzina di mansioni e posti di lavoro, dal becchino al grafico, una necessaria flessibilità assai tipica di questo periodo che però mi ha permesso di mettere da parte una serie di competenze trasversali. Mi sono interessato alla scherma storica una ventina di anni fa, entrando in contatto con alcuni gruppi e assistendo ad un paio di seminari; nel 2002 ho conosciuto il metodo della Sala d’Arme Achille Marozzo, caratterizzato da un approccio rigoroso alle fonti e una forte purezza nella ricerca delle nostre tradizioni Marziali. In particolare, la Sala d’Arme Achille Marozzo si è sempre distinta per la scelta di pubblicare i risultati dei propri studi e contribuire alla diffusione della Scherma Storica. Dopo un paio d’anni di corso sono passato da allievo ad Aiuto-Istruttore dei corsi basi seguendo poi tutte le fasi per diventare docente. Al di là della mia esperienza come Istruttore ho avuto modo di pubblicare due manuali inerenti la scherma storica: “La Lancia, La Spada, la Daga” dedicato alla scherma medievale e “Il Combattimento Storico da Strada” dove approfondisco le più strane situazioni avvenute in duello e in battaglia. Direi che la mia esperienza con il fantasy nasce sia dalla grandissima passione per la lettura che per i giochi di ruolo, commistionando le due cose per divertimento personale. Ho pubblicato alcuni romanzi, tra lo storico e il fantasy, nel mio ultimo lavoro “La Scherma del Cacciatore di Mostri” (quì il link) ho voluto immaginare il ritrovamento di un trattato di scherma rinascimentale, a lungo occultato, dedicato non al duello contro altri schermidori ma contro gli Innaturi, esseri scaturiti da favole e leggende. L’Autore doveva necessariamente essere allievo di un Trattatista che conoscevo bene per poterne ricalcare le tecniche di combattimento: ecco quindi il bolognese Johanni della Viverna, divenuto Maestro d’Arme sotto la guidae del celebre Giovanni Dalle Agocchie. Parliamo di mostri: ogni creatura richiede le sue armi e le sue tecniche. Facci degli esempi… Avendo indicato il rigore per le fonti storiche come un attributo qualitativo, credo sia lecito non inventare nulla ma, appunto, citare qualcuno più autorevole di me. Il primo esempio che mi viene in mente è tratto da “Guerrino detto il Meschino” un eroe popolare del Basso Medioevo, nato dalla penna di Andrea da Barberino nel 1473. Si tratta di un guerriero che si è fatto da sé, ignora di possedere nobili natali e ha deciso di farsi strada nella vita apprendendo l’arte della spada. Tra le innumerevoli avventure (di cui consiglio la lettura) si trova anche lui a dover affrontare un Innaturo. E’ descritto come un “gran verme” ma in seguito si apprende che doveva avere due o quattro zampe artigliate. Prossimo al combattimento, Guerrino fa qualcosa di assolutamente naturale per chi è ormai un veterano del combattimento: valuta una Strategia. Il pensiero di ogni Schermidore deve essere Fluido. Non carica con il cavallo e la lancia in resta, azione potente ma inutile contro un avversario estremamente rapido e dal corpo serpentino. Guai se schivasse la lancia e, in un batter d’occhio, fosse padrone dello scontro. Spada e scudo sono e restano i compagni ottimali per difendere e offendere con perizia, specie un essere di manifesta forza. Si tratta di una coppia d’arme che denota anche prudenza, Guerrino ancora non conosce appieno tutte le risorse del nemico. Di nuovo un cambio di strategia, necessario vista l’abilità del nemico. Al Guerrino è bastato pochissimo per valutare le capacità dell’Innaturo rispetto alla scelta delle armi. Lasciata spada e scudo rotella, armi troppo lente e facilmente afferrabili, afferra il pugnale che ogni cavaliere porta con sé (forse la celebre misericordiae) e, giunto a stretto contatto, colpisce dove le scaglie si sono allargate per il movimento del corpo, affondando l’arma corta in un punto vitale dell’avversario. …e se una normale lama non bastasse? Cosa propone il manuale di “magico”? Quando ho iniziato la stesura del manuale ho ripensato all’esperienza de “Il Combattimento Storico da Strada” e di tutte le strane soluzioni che propone (lanci di cappe, di sostanze, accecamenti, false cadute etc etc…), ho anche riflettuto sul fatto che uno schermidore non si sarebbe affidato solo alla lama. L’idea di inserire la magia però non mi convinceva, forse per la vecchia dicotomia Guerriero-Mago di Dungeons & Dragons che mi porto dietro da trent’anni esatti. Come sempre mi sono affidato alle fonti storiche, cercando qualsiasi soluzione Alchemica che però derivasse da un vero trattato storico e che un lettore curioso potesse consultare. Ecco quindi “Opera” di Alchimia di Giovanbattista Birelli, il “Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium” di Giovanni Battista della Porta, ho attinto a piene mani dai “De’ capricci medicinali” di Leonardo fioravanti e altri testi ancora. Sarebbe stato più facile inventare di sana pianta una serie di soluzioni fantasiose, più spettacolaristiche e meno “rustiche”, ma credo sia anche affascinante “lavorare” imponendosi regole e “paletti” da non superare. Curiosamente, o forse no, è stata la Ricerca Storica che ha portato in evidenza il Fantastico e il Magico. Allo stesso modo, quasi tutti i mostri del libro provengono da testi storici o da trattati, primo fra tutti il “Compendio dell’arte essorcistica” di Girolamo Menghi. Questo assieme di risorse aumenta le abilità del Cacciatore di Mostri, li conferisce una serie di soluzioni per limitare le forze nemiche, ma anche per celare la propria identità e stordire eventuali testimoni al pari di un “Man in Black” rinascimentale. Occorre fare un esempio di come si applichino certe sostanze. Mi viene in mente il caso delle Streghe che presidiano pozzi o piccoli stagni. Si tratta dello spauracchio che le madri utilizzavano tempo fa per spaventare i bambini: se si fossero avvicinati troppo al pozzo il mostro li avrebbe presi e portati via. Uno stratagemma pedagogico rurale per chi deve lavorare duramente la terra tenendosi vicino i bambini, che di certo all’epoca non avevano un asilo o altre strutture in cui stare. La Marabecca siciliana, come la Jenny Dentiverdi inglese, la Bourda emiliano-romagnola o la Janara di Benevento, attende in prossimità di una cisterna. In questo caso il buon Johanni della Viverna avrebbe pronta una buona ronca dall’asta lunga, ottima per colpire a buona distanza, ma si sarebbe ben guardato da scendere nell’elemento di elezione dell’Innaturo. Ecco quindi una buona “mistura che arda sott’acqua” dal trattato di Alchimia Giovanni Battista della Porta, quando questa sorta di fuoco greco avrà incendiato parte dello specchio d’acqua la Strega dovrà salire in superficie per fuggire le fiamme, senza sapere che la via di scampo le è stata accuratamente preparata. A questo punto ci si affiderà all’abilità dello Schermidore con la ronca per ripulire la zona dal minaccioso Innaturo… Certo, tutto questo darsi da fare può attirare l’attenzione di testimoni, ma sempre il Birelli offre una soluzione con un composto “A far che le persone facilmente escano di sentimento, che paiano pazzi”, e così anche se raccontano ciò che hanno visto alla Loggia della Mercanzia, in Piazza Maggiore o agli uomini del Bargello nessuno gli crederà. La serie di The Witcher sta per uscire: dai filmati del gioco e le scene di combattimento della serie già uscite, cosa possiamo dire dello stile di combattimento dello Strigo, riferito agli stili storici e ai mostri che egli affronta? Devo premettere che di The Witcher io so pochissimo. Ricordo di aver installato il gioco, visto l’animazione iniziale con l’amico che me lo regalò e aver giocato tipo 5-10 minuti notando positivamente che permetteva di cambiare la guardia del personaggio. Di lì a poco nacque mia figlia e addio Strigi, Streghe e altro, dovevo gettarmi nella battaglia delle notti insonni, affrontare orde di rigurgiti e debellare pannolini. Non ho ancora letto i romanzi e quando me lo segnalarono dopo l’uscita del libro mi scoprii estremamente ignorante. Rispetto ai bellissimi filmati che ho visto online, lo stile scelto per Geralt di Rivia consiste in colpi ampi, grandi “caricamenti” con l’arma alzata fin sopra la testa e lame che proseguono il movimento fino a terra. Il corpo ruota completamente esponendo la schiena all’avversario, spesso vortica per eseguire una sequenza di colpi continui, in alcuni casi per aumentare la potenza d’impatto Geralt esegue attacchi dopo un balzo per aggiungere spinta e peso del colpo alla forza cinetica del taglio. Il tutto contro mostri grandi e grossi, e quindi bersagli ben definiti su cui sferrare Colpi Finiti, ossia a piena potenza e senza possibilità di cambiare il percorso dell’arma. Quando deve affrontare gli uomini non mancano calci, pugni e spallate per alternare le azioni della spada, oltre a del sano combattimento corpo a corpo e un buon utilizzo del pugnale con colpi di punta alla gola o sotto l’ascella, quindi in un punto non protetto. Tutto questo corrisponde alle necessità di spettacolarizzazione del prodotto ludico, in cui lo spettatore deve poter godere dell’intera dinamica dell’arma, essere copartecipe del movimento e della potenza dei colpi. Rispetto a queste logiche consiglio “the Game” di Baricco, che descrive in maniera perfetta il rapporto che si sviluppa tra lo strumento ludico e il corpo del giocatore. La Scherma Storica, ovviamente, è qualcosa di completamente diverso: non si espone mai la schiena all’avversario, non si tentano “scivolamenti” o spallate, niente pugni e calci perché occorre sempre gestire la distanza rispetto all’avversario. I colpi devono essere misurati: i caricamenti inutili sono da escludere, nel momento in cui si va a sollevare le braccia per aumentare la potenza d’impatto un avversario può colpire proprio gli arti, inoltre colpi troppo telefonati fanno esporre a contro-tecniche brevi e rapide, spesso proprio alla mano di chi sferra il taglio che di per sé ha il vantaggio della potenza ma lo svantaggio della lentezza. Ogni tanto Geralt ha infatti il buonsenso di infilare una punta rapida nella gola o nel petto degli avversari. C’è anche da dire che le finte, che richiedono falsi colpi e non Colpi Finiti, sono alla base della scherma e potrebbero non essere ben comprese dallo spettatore all’interno di un combattimento concitato In un vero combattimento si predilige l’economia di energie, i mezzi colpi, gli arretramenti e gli scarti laterali, le finte etc etc… non è così lineare come in The Witcher, in Berserk, nella serie Gundam Iron Blooded Orphans o nei vari film di Star Wars. E tuttavia lo stile di questo tipo di prodotti, così come è stato per l’ottima scherma rievocativa dei re-enactors, non è da disprezzare in quanto contribuisce fortemente alla narrazione, alla trasposizione dello spettatore all’interno della dinamica di combattimento. Si “racconta” del personaggio anche attraverso il suo corpo e il suo modo di combattere, se ne avverte la tensione, si accusano i colpi che subisce e si gode della raggiunta vittoria. Aggiungo un dettaglio, e forse una profezia. Sono certo che prima o poi salteranno fuori corsi di “Scherma Witcher” o “Scherma Strigoi” (o con altri nomi onde evitare problemi di copyright) come è accaduto per la Scherma Jedi che si sta affermando come disciplina in ogni parte del mondo. Premetto che un qualsiasi schermidore storico, con almeno un paio d’anni di esperienza di combattimento, non avrebbe problemi a vincere un confronto con questo tipo di appassionati, ma non è assolutamente questo il punto. Credo che qualsiasi Storia (perché è quella la leva fondamentale!) faccia uscire di casa un ragazzo o una ragazza, staccandolo da una console o dallo smartphone, in modo che stia con altri ragazzi, gli permetta di fare movimento fisico e intraprendere un percorso anche minimamente marziale, non possa che essere una cosa positiva. Fosse pure volteggiare in salto con la spada dello Strigo (ma perché la tiene sulla schiena?) o ruzzolare con una spada laser. E magari andarsi a bere una birra insieme dopo gli allenamenti! Chiaramente, un vero percorso di scherma storica sarebbe consigliabile, anche per suscitare maggior passione per lo studio, la storia e la cultura. Tuttavia non va assolutamente sottovalutato il valore umano e sociale che un qualsiasi corso di Scherma per Cacciatori di Mostri può avere. Sorge però un interrogativo: chi sarebbe il ”Maestro” di questi corsi? Chi diventerebbe il riferimento sportivo, ma anche morale, di questi ragazzi forse troppo manipolabili? Magari un furbetto che vuole fare del denaro, meglio se con la barba imbiancata, i modi dell’uomo vissuto e il carisma del mentore misterioso. Non ci sarebbe nulla di strano visto il proliferare di Maestri improvvisati e Guru della Scherma Storica di oltre vent’anni fa, quando questa disciplina e la rievocazione storica muovevano assieme i primi passi, con tutte le conseguenti e disastrose ricadute. E questo è forse l’unico elemento preoccupante dei futuri corsi da Strigo o AmmazzaDraghi. Per diventare Istruttori di scherma storica o moderna ci sono dei percorsi, è richiesto rigore, anche morale, la capacità di trasmettere correttezza e non furbizia, controllo e non violenza. L’attributo necessario, forse, andrebbe ricercato nell’ossatura di figure eroiche come Geralt. Se la Storia genera una disciplina, allora la direttiva morale del Personaggio può far comprendere il tipo di Maestro da cercare. Grazie ancora per l’intervista. Trovate qui il sito di Jari con le sue opere. E voi lettori, se vi è piaciuto l’articolo date un’occhiata anche a quelli qui sotto ❚ 5 falsi miti sulla spada medievale ❚ Affondo vs fendente – La fisica in 7 punti – Battle Science III ❚ 5 errori sulle armature in Dungeons & Dragons Articolo originale: http://www.profmarrelli.it/2019/12/18/jari-lanzoni-cacciatore-mostri-witcher/ Se questo articolo ti è piaciuto, segui il prof. Marrelli su facebook e su ludomedia.
-
Maestri d’Arme – Jari il Cacciatore di Mostri
Il Prof. Marrelli intervista Jari Lanzoni, schermidore e appassionato di fantasy nonché di… lotta ai mostri! Dopo l'uscita della serie TV di The Witcher, dedicata a Geralt di Rivia, il noto Strigo cacciatore di mostri, grande utente di alchimia sulla quale abbiamo già fatto questo precedente articolo. Per l’occasione, abbiamo deciso di intervistare Jari Lanzoni, (qui il suo sito), schermidore e appassionato di fantasy nonché di… lotta ai mostri! Ciao Jari, dicci chi sei e quali sono le tue esperienze in ambito di scherma e fantasy Direi uno strano amalgama di tante cose: direi principalmente un padre e un marito, poi un lettore, uno scrittore e un appassionato di combattimento storico. Al momento lavoro nel settore del turismo dopo aver cambiato una dozzina di mansioni e posti di lavoro, dal becchino al grafico, una necessaria flessibilità assai tipica di questo periodo che però mi ha permesso di mettere da parte una serie di competenze trasversali. Mi sono interessato alla scherma storica una ventina di anni fa, entrando in contatto con alcuni gruppi e assistendo ad un paio di seminari; nel 2002 ho conosciuto il metodo della Sala d’Arme Achille Marozzo, caratterizzato da un approccio rigoroso alle fonti e una forte purezza nella ricerca delle nostre tradizioni Marziali. In particolare, la Sala d’Arme Achille Marozzo si è sempre distinta per la scelta di pubblicare i risultati dei propri studi e contribuire alla diffusione della Scherma Storica. Dopo un paio d’anni di corso sono passato da allievo ad Aiuto-Istruttore dei corsi basi seguendo poi tutte le fasi per diventare docente. Al di là della mia esperienza come Istruttore ho avuto modo di pubblicare due manuali inerenti la scherma storica: “La Lancia, La Spada, la Daga” dedicato alla scherma medievale e “Il Combattimento Storico da Strada” dove approfondisco le più strane situazioni avvenute in duello e in battaglia. Direi che la mia esperienza con il fantasy nasce sia dalla grandissima passione per la lettura che per i giochi di ruolo, commistionando le due cose per divertimento personale. Ho pubblicato alcuni romanzi, tra lo storico e il fantasy, nel mio ultimo lavoro “La Scherma del Cacciatore di Mostri” (quì il link) ho voluto immaginare il ritrovamento di un trattato di scherma rinascimentale, a lungo occultato, dedicato non al duello contro altri schermidori ma contro gli Innaturi, esseri scaturiti da favole e leggende. L’Autore doveva necessariamente essere allievo di un Trattatista che conoscevo bene per poterne ricalcare le tecniche di combattimento: ecco quindi il bolognese Johanni della Viverna, divenuto Maestro d’Arme sotto la guidae del celebre Giovanni Dalle Agocchie. Parliamo di mostri: ogni creatura richiede le sue armi e le sue tecniche. Facci degli esempi… Avendo indicato il rigore per le fonti storiche come un attributo qualitativo, credo sia lecito non inventare nulla ma, appunto, citare qualcuno più autorevole di me. Il primo esempio che mi viene in mente è tratto da “Guerrino detto il Meschino” un eroe popolare del Basso Medioevo, nato dalla penna di Andrea da Barberino nel 1473. Si tratta di un guerriero che si è fatto da sé, ignora di possedere nobili natali e ha deciso di farsi strada nella vita apprendendo l’arte della spada. Tra le innumerevoli avventure (di cui consiglio la lettura) si trova anche lui a dover affrontare un Innaturo. E’ descritto come un “gran verme” ma in seguito si apprende che doveva avere due o quattro zampe artigliate. Prossimo al combattimento, Guerrino fa qualcosa di assolutamente naturale per chi è ormai un veterano del combattimento: valuta una Strategia. Il pensiero di ogni Schermidore deve essere Fluido. Non carica con il cavallo e la lancia in resta, azione potente ma inutile contro un avversario estremamente rapido e dal corpo serpentino. Guai se schivasse la lancia e, in un batter d’occhio, fosse padrone dello scontro. Spada e scudo sono e restano i compagni ottimali per difendere e offendere con perizia, specie un essere di manifesta forza. Si tratta di una coppia d’arme che denota anche prudenza, Guerrino ancora non conosce appieno tutte le risorse del nemico. Di nuovo un cambio di strategia, necessario vista l’abilità del nemico. Al Guerrino è bastato pochissimo per valutare le capacità dell’Innaturo rispetto alla scelta delle armi. Lasciata spada e scudo rotella, armi troppo lente e facilmente afferrabili, afferra il pugnale che ogni cavaliere porta con sé (forse la celebre misericordiae) e, giunto a stretto contatto, colpisce dove le scaglie si sono allargate per il movimento del corpo, affondando l’arma corta in un punto vitale dell’avversario. …e se una normale lama non bastasse? Cosa propone il manuale di “magico”? Quando ho iniziato la stesura del manuale ho ripensato all’esperienza de “Il Combattimento Storico da Strada” e di tutte le strane soluzioni che propone (lanci di cappe, di sostanze, accecamenti, false cadute etc etc…), ho anche riflettuto sul fatto che uno schermidore non si sarebbe affidato solo alla lama. L’idea di inserire la magia però non mi convinceva, forse per la vecchia dicotomia Guerriero-Mago di Dungeons & Dragons che mi porto dietro da trent’anni esatti. Come sempre mi sono affidato alle fonti storiche, cercando qualsiasi soluzione Alchemica che però derivasse da un vero trattato storico e che un lettore curioso potesse consultare. Ecco quindi “Opera” di Alchimia di Giovanbattista Birelli, il “Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium” di Giovanni Battista della Porta, ho attinto a piene mani dai “De’ capricci medicinali” di Leonardo fioravanti e altri testi ancora. Sarebbe stato più facile inventare di sana pianta una serie di soluzioni fantasiose, più spettacolaristiche e meno “rustiche”, ma credo sia anche affascinante “lavorare” imponendosi regole e “paletti” da non superare. Curiosamente, o forse no, è stata la Ricerca Storica che ha portato in evidenza il Fantastico e il Magico. Allo stesso modo, quasi tutti i mostri del libro provengono da testi storici o da trattati, primo fra tutti il “Compendio dell’arte essorcistica” di Girolamo Menghi. Questo assieme di risorse aumenta le abilità del Cacciatore di Mostri, li conferisce una serie di soluzioni per limitare le forze nemiche, ma anche per celare la propria identità e stordire eventuali testimoni al pari di un “Man in Black” rinascimentale. Occorre fare un esempio di come si applichino certe sostanze. Mi viene in mente il caso delle Streghe che presidiano pozzi o piccoli stagni. Si tratta dello spauracchio che le madri utilizzavano tempo fa per spaventare i bambini: se si fossero avvicinati troppo al pozzo il mostro li avrebbe presi e portati via. Uno stratagemma pedagogico rurale per chi deve lavorare duramente la terra tenendosi vicino i bambini, che di certo all’epoca non avevano un asilo o altre strutture in cui stare. La Marabecca siciliana, come la Jenny Dentiverdi inglese, la Bourda emiliano-romagnola o la Janara di Benevento, attende in prossimità di una cisterna. In questo caso il buon Johanni della Viverna avrebbe pronta una buona ronca dall’asta lunga, ottima per colpire a buona distanza, ma si sarebbe ben guardato da scendere nell’elemento di elezione dell’Innaturo. Ecco quindi una buona “mistura che arda sott’acqua” dal trattato di Alchimia Giovanni Battista della Porta, quando questa sorta di fuoco greco avrà incendiato parte dello specchio d’acqua la Strega dovrà salire in superficie per fuggire le fiamme, senza sapere che la via di scampo le è stata accuratamente preparata. A questo punto ci si affiderà all’abilità dello Schermidore con la ronca per ripulire la zona dal minaccioso Innaturo… Certo, tutto questo darsi da fare può attirare l’attenzione di testimoni, ma sempre il Birelli offre una soluzione con un composto “A far che le persone facilmente escano di sentimento, che paiano pazzi”, e così anche se raccontano ciò che hanno visto alla Loggia della Mercanzia, in Piazza Maggiore o agli uomini del Bargello nessuno gli crederà. La serie di The Witcher sta per uscire: dai filmati del gioco e le scene di combattimento della serie già uscite, cosa possiamo dire dello stile di combattimento dello Strigo, riferito agli stili storici e ai mostri che egli affronta? Devo premettere che di The Witcher io so pochissimo. Ricordo di aver installato il gioco, visto l’animazione iniziale con l’amico che me lo regalò e aver giocato tipo 5-10 minuti notando positivamente che permetteva di cambiare la guardia del personaggio. Di lì a poco nacque mia figlia e addio Strigi, Streghe e altro, dovevo gettarmi nella battaglia delle notti insonni, affrontare orde di rigurgiti e debellare pannolini. Non ho ancora letto i romanzi e quando me lo segnalarono dopo l’uscita del libro mi scoprii estremamente ignorante. Rispetto ai bellissimi filmati che ho visto online, lo stile scelto per Geralt di Rivia consiste in colpi ampi, grandi “caricamenti” con l’arma alzata fin sopra la testa e lame che proseguono il movimento fino a terra. Il corpo ruota completamente esponendo la schiena all’avversario, spesso vortica per eseguire una sequenza di colpi continui, in alcuni casi per aumentare la potenza d’impatto Geralt esegue attacchi dopo un balzo per aggiungere spinta e peso del colpo alla forza cinetica del taglio. Il tutto contro mostri grandi e grossi, e quindi bersagli ben definiti su cui sferrare Colpi Finiti, ossia a piena potenza e senza possibilità di cambiare il percorso dell’arma. Quando deve affrontare gli uomini non mancano calci, pugni e spallate per alternare le azioni della spada, oltre a del sano combattimento corpo a corpo e un buon utilizzo del pugnale con colpi di punta alla gola o sotto l’ascella, quindi in un punto non protetto. Tutto questo corrisponde alle necessità di spettacolarizzazione del prodotto ludico, in cui lo spettatore deve poter godere dell’intera dinamica dell’arma, essere copartecipe del movimento e della potenza dei colpi. Rispetto a queste logiche consiglio “the Game” di Baricco, che descrive in maniera perfetta il rapporto che si sviluppa tra lo strumento ludico e il corpo del giocatore. La Scherma Storica, ovviamente, è qualcosa di completamente diverso: non si espone mai la schiena all’avversario, non si tentano “scivolamenti” o spallate, niente pugni e calci perché occorre sempre gestire la distanza rispetto all’avversario. I colpi devono essere misurati: i caricamenti inutili sono da escludere, nel momento in cui si va a sollevare le braccia per aumentare la potenza d’impatto un avversario può colpire proprio gli arti, inoltre colpi troppo telefonati fanno esporre a contro-tecniche brevi e rapide, spesso proprio alla mano di chi sferra il taglio che di per sé ha il vantaggio della potenza ma lo svantaggio della lentezza. Ogni tanto Geralt ha infatti il buonsenso di infilare una punta rapida nella gola o nel petto degli avversari. C’è anche da dire che le finte, che richiedono falsi colpi e non Colpi Finiti, sono alla base della scherma e potrebbero non essere ben comprese dallo spettatore all’interno di un combattimento concitato In un vero combattimento si predilige l’economia di energie, i mezzi colpi, gli arretramenti e gli scarti laterali, le finte etc etc… non è così lineare come in The Witcher, in Berserk, nella serie Gundam Iron Blooded Orphans o nei vari film di Star Wars. E tuttavia lo stile di questo tipo di prodotti, così come è stato per l’ottima scherma rievocativa dei re-enactors, non è da disprezzare in quanto contribuisce fortemente alla narrazione, alla trasposizione dello spettatore all’interno della dinamica di combattimento. Si “racconta” del personaggio anche attraverso il suo corpo e il suo modo di combattere, se ne avverte la tensione, si accusano i colpi che subisce e si gode della raggiunta vittoria. Aggiungo un dettaglio, e forse una profezia. Sono certo che prima o poi salteranno fuori corsi di “Scherma Witcher” o “Scherma Strigoi” (o con altri nomi onde evitare problemi di copyright) come è accaduto per la Scherma Jedi che si sta affermando come disciplina in ogni parte del mondo. Premetto che un qualsiasi schermidore storico, con almeno un paio d’anni di esperienza di combattimento, non avrebbe problemi a vincere un confronto con questo tipo di appassionati, ma non è assolutamente questo il punto. Credo che qualsiasi Storia (perché è quella la leva fondamentale!) faccia uscire di casa un ragazzo o una ragazza, staccandolo da una console o dallo smartphone, in modo che stia con altri ragazzi, gli permetta di fare movimento fisico e intraprendere un percorso anche minimamente marziale, non possa che essere una cosa positiva. Fosse pure volteggiare in salto con la spada dello Strigo (ma perché la tiene sulla schiena?) o ruzzolare con una spada laser. E magari andarsi a bere una birra insieme dopo gli allenamenti! Chiaramente, un vero percorso di scherma storica sarebbe consigliabile, anche per suscitare maggior passione per lo studio, la storia e la cultura. Tuttavia non va assolutamente sottovalutato il valore umano e sociale che un qualsiasi corso di Scherma per Cacciatori di Mostri può avere. Sorge però un interrogativo: chi sarebbe il ”Maestro” di questi corsi? Chi diventerebbe il riferimento sportivo, ma anche morale, di questi ragazzi forse troppo manipolabili? Magari un furbetto che vuole fare del denaro, meglio se con la barba imbiancata, i modi dell’uomo vissuto e il carisma del mentore misterioso. Non ci sarebbe nulla di strano visto il proliferare di Maestri improvvisati e Guru della Scherma Storica di oltre vent’anni fa, quando questa disciplina e la rievocazione storica muovevano assieme i primi passi, con tutte le conseguenti e disastrose ricadute. E questo è forse l’unico elemento preoccupante dei futuri corsi da Strigo o AmmazzaDraghi. Per diventare Istruttori di scherma storica o moderna ci sono dei percorsi, è richiesto rigore, anche morale, la capacità di trasmettere correttezza e non furbizia, controllo e non violenza. L’attributo necessario, forse, andrebbe ricercato nell’ossatura di figure eroiche come Geralt. Se la Storia genera una disciplina, allora la direttiva morale del Personaggio può far comprendere il tipo di Maestro da cercare. Grazie ancora per l’intervista. Trovate qui il sito di Jari con le sue opere. E voi lettori, se vi è piaciuto l’articolo date un’occhiata anche a quelli qui sotto ❚ 5 falsi miti sulla spada medievale ❚ Affondo vs fendente – La fisica in 7 punti – Battle Science III ❚ 5 errori sulle armature in Dungeons & Dragons Articolo originale: http://www.profmarrelli.it/2019/12/18/jari-lanzoni-cacciatore-mostri-witcher/ Se questo articolo ti è piaciuto, segui il prof. Marrelli su facebook e su ludomedia. Visualizza articolo completo
-
Armature vs Armi da fuoco rinascimentali – Historia
ATTENZIONE: Questo articolo è la seconda parte del precedente sulle armi da fuoco: prima di proseguire la lettura, potete mettervi in pari cliccando qui! Abbiamo visto come le armi da fuoco siano apparse clamorosamente nei campi di battaglia dell’europa di metà ‘300 e nei secoli successivi si siano affermati anche nelle loro forme “manesche” (cioè utilizzabili da una persona sola, “a mano”, come un archibugio). Questo però non ha portato a un’immediata scomparsa delle armature, e anzi per secoli esse hanno continuato a prosperare fornendo spesso una protezione importante a chi le indossava, persino contro i temibili archibugi. Ma come hanno fatto? Andiamo a scoprirlo insieme! FERRO E ACCIAIO Ricostruzione di altoforno rinascimentale, Deutsches Museum (Foto CC0) L’acciaio è una sostanza metallica, una lega di Ferro e Carbonio. Per quanto la sua invenzione sia comunemente associata all’età moderna, in realtà nella lavorazione alla forgia del ferro, il carbonio presente nel carbone della forgia stessa va a legarsi con il ferro formando uno strato superficiale di lega ferro-carbonio. L’effetto di questa lega può essere di vario tipo, come andremo a vedere, in base alla percentuale di carbonio e ai metodi di raffreddamento di questo. Significa comunque che, in un certo qual modo, si hanno le prime armi e armature costituite parzialmente d’acciaio sin dall’età del ferro. Pensare inoltre che, nell’antichità, si usasse come materiale di partenza il ferro puro è un’imprecisione: la maggior parte del ferro, infatti, si otteneva dalla fusione dei minerali ferrosi attraverso una fornace, operazione che lasciava sempre delle inevitabili impurità nel metallo. Alle temperature della fornace, infatti, il ferro non si liquefà mai del tutto, ma viene in qualche modo a “colare” dalla pietra in una sostanza viscosa che si porta inevitabilmente dietro impurità della roccia d’origine. Le caratteristiche della fornace, oltre a determinare la qualità del metallo finale, limitano anche la quantità di materiale ottenibile in un singolo processo. Si tendeva, infatti, a partire da un’unica massa di metallo per costruire oggetti poiché saldare più pezzi metallici avrebbe portato a caratteristiche fisiche peggiori. Per ottenere singole masse di metallo maggiore, tuttavia, sono necessarie fornaci più grandi che richiedono a loro volta temperature maggiori non banali da raggiungere! Per amor di completezza, anche se non tratteremo qui l’argomento, sono state prodotte invece nel medioevo lame d’acciaio di altissima qualità ottenute battendo insieme lamine metalliche diverse in quello che è comunemente noto come “acciaio a pacchetto” o “acciaio di Damasco”. In “Ryse: Son of Rome” il protagonista indossa una tipica Lorica Segmentata. Nel mondo antico, l’impero romano aveva costruito delle fornaci più grandi e calde, necessarie per ottenere lamine abbastanza grandi da costituire le piastre della Lorica Segmentata: l’armatura a piastre più famosa del periodo pre-medievale e che tutti noi identifichiamo oggi come la classica protezione del legionario imperiale. Tuttavia la lenta fine dell’impero e l’abbandono di tali corazze in favore della più economica Lorica Hamata, a tutti gli effetti un cotta di maglia, portarono al disuso di tale tecnologia. La capacità di ottenere piastre di dimensioni considerevoli tornò in auge con l’invenzione, verso la metà del ‘300 (ma diffusasi successivamente), dell’altoforno, una fornace in grado di raggiungere dimensioni e temperature capaci di fondere completamente il ferro. Oltre a permettere di ottenere agglomerati metallici di dimensioni considerevoli e molto più poveri di impurità, l’altoforno produce una lega di ferro ad alto contenuto di carbonio, chiamata ghisa. A differenza del ferro, che deve essere battuto per essere lavorato, la ghisa, trovandosi allo stato liquido quando esce dall’altoforno, può essere versata in uno stampo per produrre lavorati per fusione, in modo simile al bronzo. BOOM! (Assassin’s Creed: Brotherhood) Tuttavia questo tipo di lega, pur essendo usata all’epoca per la creazione di cannoni e relativi proiettili, è inadatta alle altre armi e armature poiché troppo fragile (come vedremo dopo). Per ottenere invece un materiale lavorabile e adatto a tali armamenti, la ghisa veniva soggetta a un successivo trattamento di raffinazione, nella quale veniva nuovamente riscaldata in un ambiente ricco di ossigeno: in questa maniera, oltre a eliminare ulteriori scorie, parte del carbonio presente nel materiale si legava all’ossigeno formando anidride carbonica e abbandonando il metallo. Questo processo forniva come risultato una lega di ferro con percentuale di carbonio inferiore al 2%, cioè quello che noi chiamiamo Acciaio! PROPRIETA’ MECCANICHE Due sono le proprietà meccaniche dell’acciaio che ci interessano: la sua Durezza e Tenacità. La durezza è la resistenza, da parte del materiale, alle deformazioni: essa dipende sostanzialmente dal tipo di struttura che assumono gli atomi in toto all’interno del metallo. Abbiamo già parlato di materiali duri in questo articolo sulle proprietà fisiche di armi e armature La presenza di carbonio all’interno del ferro è in grado di raddoppiare la durezza rispetto al ferro ricco di scorie ottenuto mediante la fornace: per aumentare ulteriormente tale proprietà è necessario temprare il metallo, ovvero regolare come esso si raffredda dopo aver raggiunto una temperatura sufficiente a “riorganizzare” la struttura interna della lega. Nel medioevo era uso comune una tempra non rapidissima in grado di formare un acciaio duro 3-4 volte il ferro ottenuto dalla fornace: è possibile invece temprare rapidamente il metallo, formando un acciaio estremamente duro, fino al doppio del precedente. Tuttavia, questo tipo di tempra rischia di rendere l’acciaio fragile ed è dunque inadatto ai nostri scopi. Ma cos’è la fragilità? Perfino le armi più dure possono rompersi – Narsil, dalla trilogia del signore degli anelli Un materiale si dice fragile se è facile spezzarlo: l’esempio classico di materiale duro e fragile è il vetro, che è difficilissimo da deformare ma si rompe con facilità. La capacità di resistere alla rottura di un materiale è detta Tenacia ed è la caratteristica più importante per le armature: infatti la tenacia di un metallo definisce quanta energia è necessaria per perforarlo. Questa energia dipende dalla qualità del materiale: un acciaio con un contenuto di carbonio dello 0.85%, ad esempio, ha una tenacia fino a 3-4 volte maggiore rispetto a quella del ferro di bassa qualità. ENERGIE DI PENETRAZIONE Per calcolare l’energia necessaria per penetrare una piastra di un’armatura entrano in gioco i seguenti fattori: la forma dell’arma usata; lo spessore della corazza; la qualità del metallo; l’angolo con il quale il colpo incide sulla corazza. Partiamo dalla prima: come già detto nell’articolo sulle proprietà delle armi e armature (che trovate qui), la forma dell’arma, o meglio, della parte dell’arma che colpisce l’armatura definisce la pressione che essa è in grado di impartire: minore la superficie di contatto, maggiore è la pressione, minore è l’energia necessaria per perforare un materiale. Si capisce dunque subito che le frecce, pur avendo energie decisamente inferiori a disposizione, sono molto più efficienti dei proiettili, che all’epoca consistevano in delle semplici sfere metalliche (da cui “pallottola”), e anche le lame, per risultare efficaci contro le armature, devono essere il più piccole possibili. Mantenendo dunque il nostro studio unicamente sulle armi da fuoco, andiamo a vedere quanta energia serve a una pallottola per perforare una corazza. Una stima delle energie a disposizione per vari tipi di armi da fuoco è stata fatta nella prima parte dell’articolo che trovate qui Se partiamo ci riferiamo ancora una volta all’appendice di The Knight and the Blast fournace, partendo da una corazza spessa due millimetri di acciaio di buona qualità vediamo che servono poco più di 800 J affinché un’arma da fuoco perfori una simile corazza: immaginando di poter aggiungere 150 J extra per perforare ulteriori protezioni sottostanti (come imbottitura e cotta di maglia) vediamo che una tale armatura è ben lontana dal proteggere da un colpo di archibugio a distanza ravvicinata. Tuttavia, una simile armatura ha ampio spazio di manovra per quanto riguarda il suo spessore. L’energia necessaria per perforare un’armatura cresce come il suo spessore elevato alle 1.6: in pratica, raddoppiare lo spessore triplicherà (all’incirca) l’energia necessaria per perforare l’armatura. Vediamo dunque che la stessa armatura spessa 3 mm richiede quasi 1900 J per essere perforata e un esorbitante 3800 J se portata a 4 mm, ponendo quindi il cavaliere al sicuro anche dai colpi dei primi moschetti! Armatura da corazziere del ‘600, Morges military museum Queste spesse armature, tuttavia, risultavano estremamente pesanti e furono in uso principalmente dopo il ‘600: infatti, con l’avvento degli eserciti nazionali, i vari regnanti cominciarono a ricorrere ad armamenti di massa, producendo corazze più spesse ma di qualità inferiore, riducendo l’energia necessaria a perforarle a un 50-75% di quella di un buon acciaio: queste armature, più che assicurare una protezione totale contro i nemici, servivano a ridurre il rischio di morte di un proiettile sparato da lontano. L’estremo peso di queste protezioni portò a produrre armature complete solo per la cavalleria, andando a creare la figura del corazziere, cavaliere pesante con armi da fuoco, mentre la fanteria andò pian piano a ridurre l’armatura a pochi pezzi, principalmente il busto e l’elmo. Un’altra opzione era ovviamente puntare su acciai di qualità migliore: i più raffinati potevano aumentare di un ulteriore 50% l’energia necessaria alla penetrazione, rendendo ad esempio la precedente corazza a piastre da 2 mm impervia ai comuni archibugi. L’ultimo elemento da tenere in conto è l’angolo di incidenza tra il proiettile e la piastra: infatti, se il proiettile non raggiunge perpendicolarmente la corazza, esso tenderà a dissipare la sua energia e dunque l’energia necessaria alla perforazione verrà moltiplicata per un fattore pari all’inverso del coseno dell’angolo di incidenza. Ricordiamo che il coseno è una proprietà degli angoli ed è un fattore compreso (per angoli inferiori ai 90°) tra 0 e 1: famosi valori sono circa 0.8 per un angolo di 30°, circa 0.7 per uno di 45° e 0.5 per uno di 60°. Un proiettile che raggiunga una piastra con un angolo di trenta gradi richiederà il 25% circa di energia in più per perforarla: questo fenomeno non deve essere necessariamente causato dalla scarsa mira o fortuna del tiratore, infatti le armature venivano costruite con delle forme arrotondate o angolose proprio per far sì che i proiettili colpissero il bersaglio in maniera non perpendicolare. Ovviamente quelli che stiamo facendo sono ragionamenti di massima: in diversi momenti e zone dell’europa post-medievale abbiamo visto una grande varietà nella qualità, forma e fattura di armi e armature. Un problema annoso, ad esempio, era quello della disomogeneità degli acciai, ovvero l’impossibilità di costruire oggetti (come armature) in acciaio le cui proprietà fisiche fossero le stesse in tutti i punti: in questo modo era possibile che due colpi sostanzialmente identici, raggiungendo punti diversi dell’armatura, ottenessero risultati di penetrazione diametralmente opposti. Inoltre, con l’avanzare del tempo, anche le energie delle armi da fuoco sono andate via via ad aumentare: ad esempio un moschetto del 1600 poteva arrivare, con la giusta polvere da sparo, a imprimere quasi 4000 J di energia al proiettile. La presenza inoltre di miglioramenti bellici come la rigatura della canna, in grado di imprimere al proiettile un moto elicoidale che ne stabilizzasse la traiettoria, e le cartucce per rendere il caricamento più rapido resero indubbiamente le armi da fuoco sempre più letali. IN CONCLUSIONE… Le armature del rinascimento erano, in generale, in grado di proteggere chi le indossava dai proiettili delle armi da fuoco a patto che esse fossero relativamente leggere (pistole e in parte archibugi) e/o facessero fuoco da abbastanza lontano. Per quanto si tratti di condizioni apparentemente poco interessanti, ricordiamo comunque che in assenza di armatura un proiettile in tali condizioni sarebbe indubbiamente letale, se colpisse zone vitali! La protezione poteva essere ottenuta e migliorata andando ad agire sulla qualità dell’acciaio, sullo spessore della corazza e sulle sue forme: questi fattori portarono, da un lato, allo sviluppo di armature molto costose, in grado di proteggere i ricchi signori dai proiettili più comuni, dall’altro a una produzione massiva di corazze di bassa qualità molto pesanti, che proteggevano interamente solo i reparti di cavalleria mentre i fanti si limitavano ad indossarne alcune porzioni. L’azza: un letale mix di ascia, martello e lancia. Photo by Javy Camacho. Questo sviluppo dell’armatura ebbe effetto anche sulle armi da mischia: da una parte, infatti, nel ‘400 si ha il massimo splendore delle armi in asta, come le alabarde o le temutissime azze e martelli da guerra, in grado di minacciare i nemici più corazzati grazie a una letale combinazione di massa, leva e spunzoni o piccole lame d’ascia in grado di penetrare più facilmente l’armatura. Le picche, inoltre, diventeranno elemento fondamentale del campo di battaglia prima dell’invenzione della baionetta, in grado di minacciare sia la cavalleria, nello specifico tenendo a distanza i cavalli, sia la fanteria dall’armatura ridotta. Nella prima metà di questo periodo nascono nuove spade per affrontare nemici corazzati come lo stocco, che non è il rapier inglese come Dungeons & Dragons ci suggerisce ma l’estoc, una spada a lama triangolare da infilare nelle giunture delle armature nemiche, oppure come lo spadone (zweihander, montante ecc) di dimensioni ragguardevoli e di importanza strategica nella lotta alle formazioni di picchieri. La riduzione dell’armatura da fanteria, tuttavia, porterà successivamente all’invenzione di spade più sottili e agili come la striscia, che è il vero rapier di Dungeons & Dragons, un’arma eccezionale nei colpi di punta, o come la sciabola che rappresenterà il simbolo della cavalleria fino alla sua scomparsa nel ‘900. Insieme di armi rinascimentali, tra cui un peculiare stocco con guardia a testa di martello BONUS – Cosa giocare? Se la sfida tra armi da fuoco rinascimentali e armature vi appassiona e volete provare l’ebbrezza di metterle a confronto, se vi piacciono i giochi di ruolo (e se non vi piacciono è probabilmente perché non li avete provati), non posso che consigliarvi ampiamente Historia! Historia è un’ambientazione tutta italiana per Dungeons & Dragons (quinta edizione) che vi cala in un rinascimento popolato da… animali antropomorfi! Lungi dall’essere un mondo “carino”, Historia vi porrà in mezzo a intrighi, lotte politiche, battaglie campali, dilemmi etici, un mondo dove Alchimia, Magia e Religione si sfidano ogni giorno dove Spade, Armature e Pistole vivono fianco a fianco. VAI AL KICKSTARTER! Oltre a ciò, in ambito videoludico, abbiamo recentissimo Greedfall, ambientato in una versione fantasy dell’età delle esplorazioni, dove le armi da fuoco si incontrano ogni giorno con le corazze dell’acciaio migliore… con un pizzico di magia! Inoltre, ha decisamente fatto scuola Mount & Blade: With Fire and Sword, l’espansione standalone del mitico Warband, passata purtroppo in sordina, che ci pone nel complesso panorama dell’europa orientale di metà ‘600, durante la rivolta cosacca contro il commonwealth Polacco-Lituano (per inciso, è grazie a questo titolo che so dell’esistenza di suddetto commonwealth…). Come non citare poi la saga di Ezio di Assassin’s Creed, dove le armi da fuoco, appena accennate in Assassin’s Creed 2, si fanno sempre più presenti nei seguenti Brotherhood e Revelations, come a mostrare la lenta ma inesorabile diffusione di queste armi nel rinascimento. E già che citiamo Ezio, non possiamo non guardare le produzioni italiane: se vi piacciono i librogame e i giochi di ruolo non posso che consigliarvi la saga di Ultima Forsan, ambientata in un macabro rinascimento assediato dai non morti dove solo le nuove tecnologie del ‘500 potranno tenere i nostri eroi in salvo dagli abomini! Uno degli autori, Mauro Longo, famoso autore di librogame italiano nonché gestore del blog Caponata Meccanica e di una pagina su libri da tavolo per bambini (Bambini e Draghi), ha scritto numerosi libri game di Ultima Forsan e inoltre alcuni romanzi ambientati sempre in questo periodo come Guiscardi senza Gloria e il fabbricante di spettri. Se l’argomento vi è piaciuto, vi invito a leggere The Knight and the Blast Furnace di Alan Williams. Se invece cercaste una lettura (lievemente) più leggera, questo stesso argomento è stato affrontato e approfondito nel 2008 sul blog Baionette Librarie del mitico Duca, alias Marco Carra, con una serie di articoli sulle armi e gli acciai, più tecnici, che potete trovare qui. Articolo originale: http://www.profmarrelli.it/2019/10/01/armature-vs-armi-da-fuoco/ Se questo articolo ti è piaciuto, segui il prof. Marrelli su facebook e su ludomedia.
-
Armature vs Armi da fuoco rinascimentali – Historia
Dopo il primo articolo sull'arrivo delle armi da fuoco, il prof. Marrelli ci parla di come le armature si sono adattate e hanno continuato a proteggere chi le indossava da questo nuovo tipo di arma. ATTENZIONE: Questo articolo è la seconda parte del precedente sulle armi da fuoco: prima di proseguire la lettura, potete mettervi in pari cliccando qui! Abbiamo visto come le armi da fuoco siano apparse clamorosamente nei campi di battaglia dell’europa di metà ‘300 e nei secoli successivi si siano affermati anche nelle loro forme “manesche” (cioè utilizzabili da una persona sola, “a mano”, come un archibugio). Questo però non ha portato a un’immediata scomparsa delle armature, e anzi per secoli esse hanno continuato a prosperare fornendo spesso una protezione importante a chi le indossava, persino contro i temibili archibugi. Ma come hanno fatto? Andiamo a scoprirlo insieme! FERRO E ACCIAIO Ricostruzione di altoforno rinascimentale, Deutsches Museum (Foto CC0) L’acciaio è una sostanza metallica, una lega di Ferro e Carbonio. Per quanto la sua invenzione sia comunemente associata all’età moderna, in realtà nella lavorazione alla forgia del ferro, il carbonio presente nel carbone della forgia stessa va a legarsi con il ferro formando uno strato superficiale di lega ferro-carbonio. L’effetto di questa lega può essere di vario tipo, come andremo a vedere, in base alla percentuale di carbonio e ai metodi di raffreddamento di questo. Significa comunque che, in un certo qual modo, si hanno le prime armi e armature costituite parzialmente d’acciaio sin dall’età del ferro. Pensare inoltre che, nell’antichità, si usasse come materiale di partenza il ferro puro è un’imprecisione: la maggior parte del ferro, infatti, si otteneva dalla fusione dei minerali ferrosi attraverso una fornace, operazione che lasciava sempre delle inevitabili impurità nel metallo. Alle temperature della fornace, infatti, il ferro non si liquefà mai del tutto, ma viene in qualche modo a “colare” dalla pietra in una sostanza viscosa che si porta inevitabilmente dietro impurità della roccia d’origine. Le caratteristiche della fornace, oltre a determinare la qualità del metallo finale, limitano anche la quantità di materiale ottenibile in un singolo processo. Si tendeva, infatti, a partire da un’unica massa di metallo per costruire oggetti poiché saldare più pezzi metallici avrebbe portato a caratteristiche fisiche peggiori. Per ottenere singole masse di metallo maggiore, tuttavia, sono necessarie fornaci più grandi che richiedono a loro volta temperature maggiori non banali da raggiungere! Per amor di completezza, anche se non tratteremo qui l’argomento, sono state prodotte invece nel medioevo lame d’acciaio di altissima qualità ottenute battendo insieme lamine metalliche diverse in quello che è comunemente noto come “acciaio a pacchetto” o “acciaio di Damasco”. In “Ryse: Son of Rome” il protagonista indossa una tipica Lorica Segmentata. Nel mondo antico, l’impero romano aveva costruito delle fornaci più grandi e calde, necessarie per ottenere lamine abbastanza grandi da costituire le piastre della Lorica Segmentata: l’armatura a piastre più famosa del periodo pre-medievale e che tutti noi identifichiamo oggi come la classica protezione del legionario imperiale. Tuttavia la lenta fine dell’impero e l’abbandono di tali corazze in favore della più economica Lorica Hamata, a tutti gli effetti un cotta di maglia, portarono al disuso di tale tecnologia. La capacità di ottenere piastre di dimensioni considerevoli tornò in auge con l’invenzione, verso la metà del ‘300 (ma diffusasi successivamente), dell’altoforno, una fornace in grado di raggiungere dimensioni e temperature capaci di fondere completamente il ferro. Oltre a permettere di ottenere agglomerati metallici di dimensioni considerevoli e molto più poveri di impurità, l’altoforno produce una lega di ferro ad alto contenuto di carbonio, chiamata ghisa. A differenza del ferro, che deve essere battuto per essere lavorato, la ghisa, trovandosi allo stato liquido quando esce dall’altoforno, può essere versata in uno stampo per produrre lavorati per fusione, in modo simile al bronzo. BOOM! (Assassin’s Creed: Brotherhood) Tuttavia questo tipo di lega, pur essendo usata all’epoca per la creazione di cannoni e relativi proiettili, è inadatta alle altre armi e armature poiché troppo fragile (come vedremo dopo). Per ottenere invece un materiale lavorabile e adatto a tali armamenti, la ghisa veniva soggetta a un successivo trattamento di raffinazione, nella quale veniva nuovamente riscaldata in un ambiente ricco di ossigeno: in questa maniera, oltre a eliminare ulteriori scorie, parte del carbonio presente nel materiale si legava all’ossigeno formando anidride carbonica e abbandonando il metallo. Questo processo forniva come risultato una lega di ferro con percentuale di carbonio inferiore al 2%, cioè quello che noi chiamiamo Acciaio! PROPRIETA’ MECCANICHE Due sono le proprietà meccaniche dell’acciaio che ci interessano: la sua Durezza e Tenacità. La durezza è la resistenza, da parte del materiale, alle deformazioni: essa dipende sostanzialmente dal tipo di struttura che assumono gli atomi in toto all’interno del metallo. Abbiamo già parlato di materiali duri in questo articolo sulle proprietà fisiche di armi e armature La presenza di carbonio all’interno del ferro è in grado di raddoppiare la durezza rispetto al ferro ricco di scorie ottenuto mediante la fornace: per aumentare ulteriormente tale proprietà è necessario temprare il metallo, ovvero regolare come esso si raffredda dopo aver raggiunto una temperatura sufficiente a “riorganizzare” la struttura interna della lega. Nel medioevo era uso comune una tempra non rapidissima in grado di formare un acciaio duro 3-4 volte il ferro ottenuto dalla fornace: è possibile invece temprare rapidamente il metallo, formando un acciaio estremamente duro, fino al doppio del precedente. Tuttavia, questo tipo di tempra rischia di rendere l’acciaio fragile ed è dunque inadatto ai nostri scopi. Ma cos’è la fragilità? Perfino le armi più dure possono rompersi – Narsil, dalla trilogia del signore degli anelli Un materiale si dice fragile se è facile spezzarlo: l’esempio classico di materiale duro e fragile è il vetro, che è difficilissimo da deformare ma si rompe con facilità. La capacità di resistere alla rottura di un materiale è detta Tenacia ed è la caratteristica più importante per le armature: infatti la tenacia di un metallo definisce quanta energia è necessaria per perforarlo. Questa energia dipende dalla qualità del materiale: un acciaio con un contenuto di carbonio dello 0.85%, ad esempio, ha una tenacia fino a 3-4 volte maggiore rispetto a quella del ferro di bassa qualità. ENERGIE DI PENETRAZIONE Per calcolare l’energia necessaria per penetrare una piastra di un’armatura entrano in gioco i seguenti fattori: la forma dell’arma usata; lo spessore della corazza; la qualità del metallo; l’angolo con il quale il colpo incide sulla corazza. Partiamo dalla prima: come già detto nell’articolo sulle proprietà delle armi e armature (che trovate qui), la forma dell’arma, o meglio, della parte dell’arma che colpisce l’armatura definisce la pressione che essa è in grado di impartire: minore la superficie di contatto, maggiore è la pressione, minore è l’energia necessaria per perforare un materiale. Si capisce dunque subito che le frecce, pur avendo energie decisamente inferiori a disposizione, sono molto più efficienti dei proiettili, che all’epoca consistevano in delle semplici sfere metalliche (da cui “pallottola”), e anche le lame, per risultare efficaci contro le armature, devono essere il più piccole possibili. Mantenendo dunque il nostro studio unicamente sulle armi da fuoco, andiamo a vedere quanta energia serve a una pallottola per perforare una corazza. Una stima delle energie a disposizione per vari tipi di armi da fuoco è stata fatta nella prima parte dell’articolo che trovate qui Se partiamo ci riferiamo ancora una volta all’appendice di The Knight and the Blast fournace, partendo da una corazza spessa due millimetri di acciaio di buona qualità vediamo che servono poco più di 800 J affinché un’arma da fuoco perfori una simile corazza: immaginando di poter aggiungere 150 J extra per perforare ulteriori protezioni sottostanti (come imbottitura e cotta di maglia) vediamo che una tale armatura è ben lontana dal proteggere da un colpo di archibugio a distanza ravvicinata. Tuttavia, una simile armatura ha ampio spazio di manovra per quanto riguarda il suo spessore. L’energia necessaria per perforare un’armatura cresce come il suo spessore elevato alle 1.6: in pratica, raddoppiare lo spessore triplicherà (all’incirca) l’energia necessaria per perforare l’armatura. Vediamo dunque che la stessa armatura spessa 3 mm richiede quasi 1900 J per essere perforata e un esorbitante 3800 J se portata a 4 mm, ponendo quindi il cavaliere al sicuro anche dai colpi dei primi moschetti! Armatura da corazziere del ‘600, Morges military museum Queste spesse armature, tuttavia, risultavano estremamente pesanti e furono in uso principalmente dopo il ‘600: infatti, con l’avvento degli eserciti nazionali, i vari regnanti cominciarono a ricorrere ad armamenti di massa, producendo corazze più spesse ma di qualità inferiore, riducendo l’energia necessaria a perforarle a un 50-75% di quella di un buon acciaio: queste armature, più che assicurare una protezione totale contro i nemici, servivano a ridurre il rischio di morte di un proiettile sparato da lontano. L’estremo peso di queste protezioni portò a produrre armature complete solo per la cavalleria, andando a creare la figura del corazziere, cavaliere pesante con armi da fuoco, mentre la fanteria andò pian piano a ridurre l’armatura a pochi pezzi, principalmente il busto e l’elmo. Un’altra opzione era ovviamente puntare su acciai di qualità migliore: i più raffinati potevano aumentare di un ulteriore 50% l’energia necessaria alla penetrazione, rendendo ad esempio la precedente corazza a piastre da 2 mm impervia ai comuni archibugi. L’ultimo elemento da tenere in conto è l’angolo di incidenza tra il proiettile e la piastra: infatti, se il proiettile non raggiunge perpendicolarmente la corazza, esso tenderà a dissipare la sua energia e dunque l’energia necessaria alla perforazione verrà moltiplicata per un fattore pari all’inverso del coseno dell’angolo di incidenza. Ricordiamo che il coseno è una proprietà degli angoli ed è un fattore compreso (per angoli inferiori ai 90°) tra 0 e 1: famosi valori sono circa 0.8 per un angolo di 30°, circa 0.7 per uno di 45° e 0.5 per uno di 60°. Un proiettile che raggiunga una piastra con un angolo di trenta gradi richiederà il 25% circa di energia in più per perforarla: questo fenomeno non deve essere necessariamente causato dalla scarsa mira o fortuna del tiratore, infatti le armature venivano costruite con delle forme arrotondate o angolose proprio per far sì che i proiettili colpissero il bersaglio in maniera non perpendicolare. Ovviamente quelli che stiamo facendo sono ragionamenti di massima: in diversi momenti e zone dell’europa post-medievale abbiamo visto una grande varietà nella qualità, forma e fattura di armi e armature. Un problema annoso, ad esempio, era quello della disomogeneità degli acciai, ovvero l’impossibilità di costruire oggetti (come armature) in acciaio le cui proprietà fisiche fossero le stesse in tutti i punti: in questo modo era possibile che due colpi sostanzialmente identici, raggiungendo punti diversi dell’armatura, ottenessero risultati di penetrazione diametralmente opposti. Inoltre, con l’avanzare del tempo, anche le energie delle armi da fuoco sono andate via via ad aumentare: ad esempio un moschetto del 1600 poteva arrivare, con la giusta polvere da sparo, a imprimere quasi 4000 J di energia al proiettile. La presenza inoltre di miglioramenti bellici come la rigatura della canna, in grado di imprimere al proiettile un moto elicoidale che ne stabilizzasse la traiettoria, e le cartucce per rendere il caricamento più rapido resero indubbiamente le armi da fuoco sempre più letali. IN CONCLUSIONE… Le armature del rinascimento erano, in generale, in grado di proteggere chi le indossava dai proiettili delle armi da fuoco a patto che esse fossero relativamente leggere (pistole e in parte archibugi) e/o facessero fuoco da abbastanza lontano. Per quanto si tratti di condizioni apparentemente poco interessanti, ricordiamo comunque che in assenza di armatura un proiettile in tali condizioni sarebbe indubbiamente letale, se colpisse zone vitali! La protezione poteva essere ottenuta e migliorata andando ad agire sulla qualità dell’acciaio, sullo spessore della corazza e sulle sue forme: questi fattori portarono, da un lato, allo sviluppo di armature molto costose, in grado di proteggere i ricchi signori dai proiettili più comuni, dall’altro a una produzione massiva di corazze di bassa qualità molto pesanti, che proteggevano interamente solo i reparti di cavalleria mentre i fanti si limitavano ad indossarne alcune porzioni. L’azza: un letale mix di ascia, martello e lancia. Photo by Javy Camacho. Questo sviluppo dell’armatura ebbe effetto anche sulle armi da mischia: da una parte, infatti, nel ‘400 si ha il massimo splendore delle armi in asta, come le alabarde o le temutissime azze e martelli da guerra, in grado di minacciare i nemici più corazzati grazie a una letale combinazione di massa, leva e spunzoni o piccole lame d’ascia in grado di penetrare più facilmente l’armatura. Le picche, inoltre, diventeranno elemento fondamentale del campo di battaglia prima dell’invenzione della baionetta, in grado di minacciare sia la cavalleria, nello specifico tenendo a distanza i cavalli, sia la fanteria dall’armatura ridotta. Nella prima metà di questo periodo nascono nuove spade per affrontare nemici corazzati come lo stocco, che non è il rapier inglese come Dungeons & Dragons ci suggerisce ma l’estoc, una spada a lama triangolare da infilare nelle giunture delle armature nemiche, oppure come lo spadone (zweihander, montante ecc) di dimensioni ragguardevoli e di importanza strategica nella lotta alle formazioni di picchieri. La riduzione dell’armatura da fanteria, tuttavia, porterà successivamente all’invenzione di spade più sottili e agili come la striscia, che è il vero rapier di Dungeons & Dragons, un’arma eccezionale nei colpi di punta, o come la sciabola che rappresenterà il simbolo della cavalleria fino alla sua scomparsa nel ‘900. Insieme di armi rinascimentali, tra cui un peculiare stocco con guardia a testa di martello BONUS – Cosa giocare? Se la sfida tra armi da fuoco rinascimentali e armature vi appassiona e volete provare l’ebbrezza di metterle a confronto, se vi piacciono i giochi di ruolo (e se non vi piacciono è probabilmente perché non li avete provati), non posso che consigliarvi ampiamente Historia! Historia è un’ambientazione tutta italiana per Dungeons & Dragons (quinta edizione) che vi cala in un rinascimento popolato da… animali antropomorfi! Lungi dall’essere un mondo “carino”, Historia vi porrà in mezzo a intrighi, lotte politiche, battaglie campali, dilemmi etici, un mondo dove Alchimia, Magia e Religione si sfidano ogni giorno dove Spade, Armature e Pistole vivono fianco a fianco. VAI AL KICKSTARTER! Oltre a ciò, in ambito videoludico, abbiamo recentissimo Greedfall, ambientato in una versione fantasy dell’età delle esplorazioni, dove le armi da fuoco si incontrano ogni giorno con le corazze dell’acciaio migliore… con un pizzico di magia! Inoltre, ha decisamente fatto scuola Mount & Blade: With Fire and Sword, l’espansione standalone del mitico Warband, passata purtroppo in sordina, che ci pone nel complesso panorama dell’europa orientale di metà ‘600, durante la rivolta cosacca contro il commonwealth Polacco-Lituano (per inciso, è grazie a questo titolo che so dell’esistenza di suddetto commonwealth…). Come non citare poi la saga di Ezio di Assassin’s Creed, dove le armi da fuoco, appena accennate in Assassin’s Creed 2, si fanno sempre più presenti nei seguenti Brotherhood e Revelations, come a mostrare la lenta ma inesorabile diffusione di queste armi nel rinascimento. E già che citiamo Ezio, non possiamo non guardare le produzioni italiane: se vi piacciono i librogame e i giochi di ruolo non posso che consigliarvi la saga di Ultima Forsan, ambientata in un macabro rinascimento assediato dai non morti dove solo le nuove tecnologie del ‘500 potranno tenere i nostri eroi in salvo dagli abomini! Uno degli autori, Mauro Longo, famoso autore di librogame italiano nonché gestore del blog Caponata Meccanica e di una pagina su libri da tavolo per bambini (Bambini e Draghi), ha scritto numerosi libri game di Ultima Forsan e inoltre alcuni romanzi ambientati sempre in questo periodo come Guiscardi senza Gloria e il fabbricante di spettri. Se l’argomento vi è piaciuto, vi invito a leggere The Knight and the Blast Furnace di Alan Williams. Se invece cercaste una lettura (lievemente) più leggera, questo stesso argomento è stato affrontato e approfondito nel 2008 sul blog Baionette Librarie del mitico Duca, alias Marco Carra, con una serie di articoli sulle armi e gli acciai, più tecnici, che potete trovare qui. Articolo originale: http://www.profmarrelli.it/2019/10/01/armature-vs-armi-da-fuoco/ Se questo articolo ti è piaciuto, segui il prof. Marrelli su facebook e su ludomedia. Visualizza articolo completo
-
L’arrivo delle Armi da Fuoco – Historia
Per secoli armi da fuoco e armature convivono una accanto all’altra, senza mai completamente surclassarsi reciprocamente: ma come funzionano queste tecnologie? Quali segreti nascondono la polvere da sparo e l’acciaio? Andiamo a scoprirlo assieme! Anno 1326: in un periodo in cui la spada lunga è l’arma nobiliare d’eccellenza e la corazza a piastre deve ancora riuscire a ricoprire totalmente il cavaliere, si hanno le prime testimonianze di cannoni in occidente (in questo arrivato molto tardi rispetto all’oriente). Ci vorrà l’inizio del secolo successivo affinché si diffondano le primitive armi da fuoco portatili. In risposta a questa nuova minaccia, l’armatura si fa più resistente. Più spessa. Impenetrabile. Questa corsa alle armi (e alle armature!) prosegue per secoli: ancora nelle guerre napoleoniche i corazzieri indossano armature per proteggersi, ormai, principalmente dalle schegge, dai proiettili di striscio e di rimbalzo. Per secoli armi da fuoco e armature convivono una accanto all’altra, senza mai completamente surclassarsi reciprocamente: ma come funzionano queste tecnologie? Quali segreti nascondono la polvere da sparo e l’acciaio? Andiamo a scoprirlo assieme! POLVERE NERA In questo paragrafo si parla di combustioni. Per avere un’idea più chiara di come esse funzionino, prossimamente pubblicheremo un articolo a riguardo. La polvere da sparo è un composto di diverse sostanze polverizzate e mescolate assieme, nello specifico Carbone, Zolfo e Nitrato di Potassio (KNO3), più noto come Salnitro. Lo scopo dello Zolfo è quello di facilitare la reazione di combustione. Infatti, lo zolfo fonde a temperature relativamente basse (114°C) ed è, in questa forma, in grado di stimolare la reazione degli altri componenti della polvere tra loro. Il Salnitro è una sostanza con una grande quantità di ossigeno disponibile per reagire con gli altri componenti: questa sua capacità permette di rendere più rapida e vivace la combustione. Esso rappresenta oltre il 70% della massa della polvere nera. Infine il Carbone è la fonte del carbonio della reazione: la polvere da sparo, infatti, esplode combinando il carbonio all’interno del carbone con l’ossigeno nell’aria e nel Salnitro. Questa reazione ha come prodotto, oltre al calore, una grande quantità di anidride carbonica che, essendo un gas (tra l’altro a temperature elevate), si espande: è questa espansione gassosa che, se canalizzata nella canna di un’arma da fuoco, è in grado di spingere via il proiettile. METODI DI ACCENSIONE Questo tipo di reazione richiede un innesco: storicamente le armi da fuoco hanno sfruttato vari metodi per accendere la polvere da sparo. Il più antico è sicuramente la miccia, una corda che brucia più o meno lentamente fino a portare la fiamma a contatto con l’esplosivo. Ne abbiamo tutti in mente una vivida immagine per quanto riguarda l’uso nei cannoni, ma forse non tutti sanno che anche le prime armi da fuoco portatili utilizzavano questo metodo per accendere la polvere da sparo, seppur con qualche accorgimento. Nei primi archibugi, gli antenati dei nostri fucili, vi era un foro, detto focone, che permetteva la comunicazione tra il cuore della canna (la culatta) e una sezione esterna, detta scodellino, nella quale era posta ulteriore polvere da sparo. Questa polvere poteva essere accesa tramite una miccia a combustione lenta attaccata a un uncino mobile, chiamato serpentina. Quando l’archibugiere premeva il grilletto, la serpentina si muoveva portando la miccia a contatto con la polvere dello scodellino che a sua volta, attraverso il focone, accendeva la polvere in canna. Ovviamente questo metodo non era necessariamente tra i più comodi ed efficaci, e ben presto, durante il XVI secolo, nuovi metodi di accensione furono inventati: tra di essi i più famosi sono l’acciarino a ruota e quello a pietra e martellina. Nel primo (Wheellock), una ruota metallica caricata a molla veniva liberata dal grilletto, andando a strofinare una pietra di pirite che, emettendo scintille, accendeva la polvere nello scodellino. Si tratta di un meccanismo raffinato e delicato, attribuito secondo alcune tradizioni a Leonardo da Vinci, che però fu inevitabilmente sostituito dai successivi, più affidabili e resistenti. Nell’acciarino a pietra e martellina (in inglese Flintlock) o acciarino a focile, invece, un dispositivo metallico mobile detto martellina fungeva da copertura per lo scodellino: un altro pezzo metallico detto cane, caricato con una molla, terminava con una morsa nella quale era trattenuta saldamente una pietra focaia. Quando il grilletto veniva premuto, la molla scatta, il cane colpiva violentemente la martellina e, mentre la spostava scoprendo lo scodellino, l’urto della pietra focaia produceva scintille che andavano ad accendere la polvere. L’evoluzione nel tipo di acciarino, nel caricamento e l’introduzione delle cartucce (inizialmente contenitori di carta, da cui il nome, contenenti pallottola e polvere da sparo assieme) permise un netto miglioramento della cadenza di tiro da parte di queste armi nel corso dei secoli, ma inizialmente i primi archibugi e moschetti potevano sparare circa 40 colpi… all’ora! Questo perché il caricamento era lungo e complesso, richiedeva la pulizia della canna, la pressione del proiettile assieme alla polvere da sparo all’interno dell’arma, la preparazione del sistema di accensione e ovviamente il tempo necessario per impugnare l’arma, mirare e sparare. ENERGIE IMPONENTI Ma allora, con tale bassa frequenza di fuoco, come mai queste armi riuscirono a dominare i campi di battaglia? La risposta si cela nelle enormi energie con le quali i proiettili potevano essere scagliati. Per comprendere meglio come funziona l’energia, vi invito a leggere questo articolo sui vari tipi di colpi delle armi bianche e su un modo per stimarne l’energia. L’appendice del meraviglioso The Knight and the Blast Furnace di Alan Williams, che vi consiglio vivamente, fa uno studio approfondito delle energie approssimative a disposizione di varie armi (calcolate al momento del lancio del proiettile, e che dunque si riducono con la distanza del bersaglio). Un archibugio del XVI secolo imprime su un proiettile circa 1300 Joule (J) di energia, mentre una pistola dello stesso periodo può svilupparne oltre 900. Ricordiamo che il Joule è l’unità di misura dell’Energia nel sistema internazionale: per fare un paragone, un Joule è pari all’energia necessaria per sollevare da terra di 10 cm un oggetto di 1kg di peso. In confronto, l’energia di una freccia scagliata da un arco lungo ammonta a circa 150 J: da questo esempio, vediamo che tali energie sono molto elevate. Tali quantitativi di energia saranno ulteriormente ampliati da due grosse migliorie. In primo luogo, la scoperta della polvere da sparo granulare: si tratta di una polvere preparata con gli stessi ingredienti, ma mescolati in ambiente umido e poi ridotti a un mezzo granulare omogeneo prima dell’uso. Questa polvere permette un’efficienza molto maggiore, portando le energie disponibili a oltre 1700 J. Ma le migliori armature in circolazione del 1500, secondo i resoconto storici, erano ancora in grado di rispondere a queste fenomenali energie, soprattutto sulle lunghe distanze: per questo si cominciarono a costruire armi da fuoco di dimensioni maggiori, che richiedevano una forcella d’appoggio al terreno per essere correttamente utilizzate: nacque dunque il Moschetto (termine che andrà poi a indicare semplicemente l’antesignano del fucile moderno), in grado di imprimere fino a 3000 J di Energia ai proiettili. Si tratta comunque di energie calcolate “a bruciapelo”: un colpo poteva perdere anche metà della sua energia cinetica nei primi 100 metri di percorso. Ma queste energie sono “tante” o sono “poche” rispetto a quelle necessarie per perforare un’armatura dello stesso periodo? State pronti, lo scopriremo la prossima settimana… BONUS – Cosa giocare? Se la sfida tra armi da fuoco rinascimentali e armature vi appassiona e volete provare l’ebbrezza di metterle a confronto, se vi piacciono i giochi di ruolo (e se non vi piacciono è probabilmente perché non li avete provati), non posso che consigliarvi ampiamente Historia! Historia è un’ambientazione tutta italiana per Dungeons & Dragons (quinta edizione) che vi cala in un rinascimento popolato da… animali antropomorfi! Lungi dall’essere un mondo “carino”, Historia vi porrà in mezzo a intrighi, lotte politiche, battaglie campali, dilemmi etici, un mondo dove Alchimia, Magia e Religione si sfidano ogni giorno dove Spade, Armature e Pistole vivono fianco a fianco. VAI AL KICKSTARTER! Oltre a ciò, in ambito videoludico, abbiamo recentissimo Greedfall, ambientato in una versione fantasy dell’età delle esplorazioni, dove le armi da fuoco si incontrano ogni giorno con le corazze dell’acciaio migliore… con un pizzico di magia! Inoltre, ha decisamente fatto scuola Mount & Blade: With Fire and Sword, l’espansione standalone del mitico Warband, passata purtroppo in sordina, che ci pone nel complesso panorama dell’europa orientale di metà ‘600, durante la rivolta cosacca contro il commonwealth Polacco-Lituano (per inciso, è grazie a questo titolo che so dell’esistenza di suddetto commonwealth…). Come non citare poi la saga di Ezio di Assassin’s Creed, dove le armi da fuoco, appena accennate in Assassin’s Creed 2, si fanno sempre più presenti nei seguenti Brotherhood e Revelations, come a mostrare la lenta ma inesorabile diffusione di queste armi nel rinascimento. E già che citiamo Ezio, non possiamo non guardare le produzioni italiane: se vi piacciono i librogame e i giochi di ruolo non posso che consigliarvi la saga di Ultima Forsan, ambientata in un macabro rinascimento assediato dai non morti dove solo le nuove tecnologie del ‘500 potranno tenere i nostri eroi in salvo dagli abomini! Uno degli autori, Mauro Longo, famoso autore di librogame italiano nonché gestore del blog Caponata Meccanica e di una pagina su libri da tavolo per bambini (Bambini e Draghi), ha scritto numerosi libri game di Ultima Forsan e inoltre alcuni romanzi ambientati sempre in questo periodo come Guiscardi senza Gloria e il fabbricante di spettri. Se l’argomento vi è piaciuto, vi invito a leggere The Knight and the Blast Furnace di Alan Williams. Se invece cercaste una lettura (lievemente) più leggera, questo stesso argomento è stato affrontato e approfondito nel 2008 sul blog Baionette Librarie del mitico Duca, alias Marco Carra, con una serie di articoli sulle armi e gli acciai, più tecnici, che potete trovare quì. Articolo originale: http://www.profmarrelli.it/2019/09/25/armi-da-fuoco-rinascimento-1/ Se questo articolo ti è piaciuto, segui il prof. Marrelli su facebook e su ludomedia. Visualizza articolo completo
-
L’arrivo delle Armi da Fuoco – Historia
Anno 1326: in un periodo in cui la spada lunga è l’arma nobiliare d’eccellenza e la corazza a piastre deve ancora riuscire a ricoprire totalmente il cavaliere, si hanno le prime testimonianze di cannoni in occidente (in questo arrivato molto tardi rispetto all’oriente). Ci vorrà l’inizio del secolo successivo affinché si diffondano le primitive armi da fuoco portatili. In risposta a questa nuova minaccia, l’armatura si fa più resistente. Più spessa. Impenetrabile. Questa corsa alle armi (e alle armature!) prosegue per secoli: ancora nelle guerre napoleoniche i corazzieri indossano armature per proteggersi, ormai, principalmente dalle schegge, dai proiettili di striscio e di rimbalzo. Per secoli armi da fuoco e armature convivono una accanto all’altra, senza mai completamente surclassarsi reciprocamente: ma come funzionano queste tecnologie? Quali segreti nascondono la polvere da sparo e l’acciaio? Andiamo a scoprirlo assieme! POLVERE NERA In questo paragrafo si parla di combustioni. Per avere un’idea più chiara di come esse funzionino, prossimamente pubblicheremo un articolo a riguardo. La polvere da sparo è un composto di diverse sostanze polverizzate e mescolate assieme, nello specifico Carbone, Zolfo e Nitrato di Potassio (KNO3), più noto come Salnitro. Lo scopo dello Zolfo è quello di facilitare la reazione di combustione. Infatti, lo zolfo fonde a temperature relativamente basse (114°C) ed è, in questa forma, in grado di stimolare la reazione degli altri componenti della polvere tra loro. Il Salnitro è una sostanza con una grande quantità di ossigeno disponibile per reagire con gli altri componenti: questa sua capacità permette di rendere più rapida e vivace la combustione. Esso rappresenta oltre il 70% della massa della polvere nera. Infine il Carbone è la fonte del carbonio della reazione: la polvere da sparo, infatti, esplode combinando il carbonio all’interno del carbone con l’ossigeno nell’aria e nel Salnitro. Questa reazione ha come prodotto, oltre al calore, una grande quantità di anidride carbonica che, essendo un gas (tra l’altro a temperature elevate), si espande: è questa espansione gassosa che, se canalizzata nella canna di un’arma da fuoco, è in grado di spingere via il proiettile. METODI DI ACCENSIONE Questo tipo di reazione richiede un innesco: storicamente le armi da fuoco hanno sfruttato vari metodi per accendere la polvere da sparo. Il più antico è sicuramente la miccia, una corda che brucia più o meno lentamente fino a portare la fiamma a contatto con l’esplosivo. Ne abbiamo tutti in mente una vivida immagine per quanto riguarda l’uso nei cannoni, ma forse non tutti sanno che anche le prime armi da fuoco portatili utilizzavano questo metodo per accendere la polvere da sparo, seppur con qualche accorgimento. Nei primi archibugi, gli antenati dei nostri fucili, vi era un foro, detto focone, che permetteva la comunicazione tra il cuore della canna (la culatta) e una sezione esterna, detta scodellino, nella quale era posta ulteriore polvere da sparo. Questa polvere poteva essere accesa tramite una miccia a combustione lenta attaccata a un uncino mobile, chiamato serpentina. Quando l’archibugiere premeva il grilletto, la serpentina si muoveva portando la miccia a contatto con la polvere dello scodellino che a sua volta, attraverso il focone, accendeva la polvere in canna. Ovviamente questo metodo non era necessariamente tra i più comodi ed efficaci, e ben presto, durante il XVI secolo, nuovi metodi di accensione furono inventati: tra di essi i più famosi sono l’acciarino a ruota e quello a pietra e martellina. Nel primo (Wheellock), una ruota metallica caricata a molla veniva liberata dal grilletto, andando a strofinare una pietra di pirite che, emettendo scintille, accendeva la polvere nello scodellino. Si tratta di un meccanismo raffinato e delicato, attribuito secondo alcune tradizioni a Leonardo da Vinci, che però fu inevitabilmente sostituito dai successivi, più affidabili e resistenti. Nell’acciarino a pietra e martellina (in inglese Flintlock) o acciarino a focile, invece, un dispositivo metallico mobile detto martellina fungeva da copertura per lo scodellino: un altro pezzo metallico detto cane, caricato con una molla, terminava con una morsa nella quale era trattenuta saldamente una pietra focaia. Quando il grilletto veniva premuto, la molla scatta, il cane colpiva violentemente la martellina e, mentre la spostava scoprendo lo scodellino, l’urto della pietra focaia produceva scintille che andavano ad accendere la polvere. L’evoluzione nel tipo di acciarino, nel caricamento e l’introduzione delle cartucce (inizialmente contenitori di carta, da cui il nome, contenenti pallottola e polvere da sparo assieme) permise un netto miglioramento della cadenza di tiro da parte di queste armi nel corso dei secoli, ma inizialmente i primi archibugi e moschetti potevano sparare circa 40 colpi… all’ora! Questo perché il caricamento era lungo e complesso, richiedeva la pulizia della canna, la pressione del proiettile assieme alla polvere da sparo all’interno dell’arma, la preparazione del sistema di accensione e ovviamente il tempo necessario per impugnare l’arma, mirare e sparare. ENERGIE IMPONENTI Ma allora, con tale bassa frequenza di fuoco, come mai queste armi riuscirono a dominare i campi di battaglia? La risposta si cela nelle enormi energie con le quali i proiettili potevano essere scagliati. Per comprendere meglio come funziona l’energia, vi invito a leggere questo articolo sui vari tipi di colpi delle armi bianche e su un modo per stimarne l’energia. L’appendice del meraviglioso The Knight and the Blast Furnace di Alan Williams, che vi consiglio vivamente, fa uno studio approfondito delle energie approssimative a disposizione di varie armi (calcolate al momento del lancio del proiettile, e che dunque si riducono con la distanza del bersaglio). Un archibugio del XVI secolo imprime su un proiettile circa 1300 Joule (J) di energia, mentre una pistola dello stesso periodo può svilupparne oltre 900. Ricordiamo che il Joule è l’unità di misura dell’Energia nel sistema internazionale: per fare un paragone, un Joule è pari all’energia necessaria per sollevare da terra di 10 cm un oggetto di 1kg di peso. In confronto, l’energia di una freccia scagliata da un arco lungo ammonta a circa 150 J: da questo esempio, vediamo che tali energie sono molto elevate. Tali quantitativi di energia saranno ulteriormente ampliati da due grosse migliorie. In primo luogo, la scoperta della polvere da sparo granulare: si tratta di una polvere preparata con gli stessi ingredienti, ma mescolati in ambiente umido e poi ridotti a un mezzo granulare omogeneo prima dell’uso. Questa polvere permette un’efficienza molto maggiore, portando le energie disponibili a oltre 1700 J. Ma le migliori armature in circolazione del 1500, secondo i resoconto storici, erano ancora in grado di rispondere a queste fenomenali energie, soprattutto sulle lunghe distanze: per questo si cominciarono a costruire armi da fuoco di dimensioni maggiori, che richiedevano una forcella d’appoggio al terreno per essere correttamente utilizzate: nacque dunque il Moschetto (termine che andrà poi a indicare semplicemente l’antesignano del fucile moderno), in grado di imprimere fino a 3000 J di Energia ai proiettili. Si tratta comunque di energie calcolate “a bruciapelo”: un colpo poteva perdere anche metà della sua energia cinetica nei primi 100 metri di percorso. Ma queste energie sono “tante” o sono “poche” rispetto a quelle necessarie per perforare un’armatura dello stesso periodo? State pronti, lo scopriremo la prossima settimana… BONUS – Cosa giocare? Se la sfida tra armi da fuoco rinascimentali e armature vi appassiona e volete provare l’ebbrezza di metterle a confronto, se vi piacciono i giochi di ruolo (e se non vi piacciono è probabilmente perché non li avete provati), non posso che consigliarvi ampiamente Historia! Historia è un’ambientazione tutta italiana per Dungeons & Dragons (quinta edizione) che vi cala in un rinascimento popolato da… animali antropomorfi! Lungi dall’essere un mondo “carino”, Historia vi porrà in mezzo a intrighi, lotte politiche, battaglie campali, dilemmi etici, un mondo dove Alchimia, Magia e Religione si sfidano ogni giorno dove Spade, Armature e Pistole vivono fianco a fianco. VAI AL KICKSTARTER! Oltre a ciò, in ambito videoludico, abbiamo recentissimo Greedfall, ambientato in una versione fantasy dell’età delle esplorazioni, dove le armi da fuoco si incontrano ogni giorno con le corazze dell’acciaio migliore… con un pizzico di magia! Inoltre, ha decisamente fatto scuola Mount & Blade: With Fire and Sword, l’espansione standalone del mitico Warband, passata purtroppo in sordina, che ci pone nel complesso panorama dell’europa orientale di metà ‘600, durante la rivolta cosacca contro il commonwealth Polacco-Lituano (per inciso, è grazie a questo titolo che so dell’esistenza di suddetto commonwealth…). Come non citare poi la saga di Ezio di Assassin’s Creed, dove le armi da fuoco, appena accennate in Assassin’s Creed 2, si fanno sempre più presenti nei seguenti Brotherhood e Revelations, come a mostrare la lenta ma inesorabile diffusione di queste armi nel rinascimento. E già che citiamo Ezio, non possiamo non guardare le produzioni italiane: se vi piacciono i librogame e i giochi di ruolo non posso che consigliarvi la saga di Ultima Forsan, ambientata in un macabro rinascimento assediato dai non morti dove solo le nuove tecnologie del ‘500 potranno tenere i nostri eroi in salvo dagli abomini! Uno degli autori, Mauro Longo, famoso autore di librogame italiano nonché gestore del blog Caponata Meccanica e di una pagina su libri da tavolo per bambini (Bambini e Draghi), ha scritto numerosi libri game di Ultima Forsan e inoltre alcuni romanzi ambientati sempre in questo periodo come Guiscardi senza Gloria e il fabbricante di spettri. Se l’argomento vi è piaciuto, vi invito a leggere The Knight and the Blast Furnace di Alan Williams. Se invece cercaste una lettura (lievemente) più leggera, questo stesso argomento è stato affrontato e approfondito nel 2008 sul blog Baionette Librarie del mitico Duca, alias Marco Carra, con una serie di articoli sulle armi e gli acciai, più tecnici, che potete trovare quì. Articolo originale: http://www.profmarrelli.it/2019/09/25/armi-da-fuoco-rinascimento-1/ Se questo articolo ti è piaciuto, segui il prof. Marrelli su facebook e su ludomedia.
-
Myth & Magic: AD&D clone
@Aranar Probabilmente quei due sono gli unici retrocloni di AD&D 2e. Ti segnalo comunque che il PDF di entrambi è gratuito: https://www.drivethrurpg.com/product/156530/For-Gold--Glory https://www.drivethrurpg.com/product/100492/Myth--Magic-Players-Starter-Guide
-
7 Segreti alchemici di The Witcher e di D&D
Oggi il prof. Marrelli, nella sua rubrica, ci parla di quale scienza si nasconde tra i misteriosi alambicchi di Kaer Morhen? Andiamo a scoprirlo assieme! Tra le armi formidabili di uno Strigo vi è, senza alcun dubbio, l’Alchimia. Il suo stesso corpo, tramite la prova delle erbe, viene mutato irreversibilmente per farne un perfetto uccisore di mostri. Tuttavia, un Witcher continua per il resto della sua vita a preparare e usare pozioni per potenziare ulteriormente questi tratti: di volta in volta, differenti intrugli alchemici gli forniscono quel vantaggio in più del quale ha bisogno, sfruttando basi alcooliche assieme a ingredienti ottenuti dalle piante e da pezzi di mostro. Ma quanto sono realistiche queste pozioni? Grazie a quali fenomeni potrebbero funzionare? Quale scienza si nasconde tra i misteriosi alambicchi di Kaer Morhen? Andiamo a scoprirlo assieme! 7 – Pozione di Sangue Nero Questa pozione fa sì che il sangue del Witcher diventi dannoso per i mostri che ne vengono a contatto. Nel primo capitolo della saga, il suo ingrediente principale è il Vetriolo, uno degli elementi alchemici con i quali vengono prodotte le pozioni nella saga. Vetriolo viene dal latino Vitriol, sigla che significa Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem, in italiano Visita l’interno della terra, operando con rettitudine troverai la pietra nascosta. Al fine di scavare l’interno della terra, il Vetriolo doveva essere una sostanza molto acida: per questo tale termine viene storicamente usato, nell’ambito alchemico, per indicare composti dello Zolfo, in particolare acido solforico o solfuri metallici (i sali ottenuti dall’acido solforico assieme ai metalli). Tuttavia, inserire acido solforico nel sangue risulterebbe letale probabilmente anche per un Witcher: la consistenza bluastra del Vetriolo della saga può, invece, farci pensare ad altre sostanze come il Solfato di Zinco. Si tratta di un composto cristallino con svariati usi medici, un rinforzante del sistema immunitario che, se la vecchia dicotomia vita/non-morte fosse valida, potrebbe danneggiare i non-morti esattamente come aiuta i viventi. Inoltre, è presente nelle ossa e potrebbe giustificare la possibilità di ricavarne, nel primo capitolo della saga videoludica, dalle zanne di animali. 6 – Pozione Bufera di Neve Il nome inglese di questa pozione, “Blizzard”, ricorda a tutti la celebre casa produttrice di videogiochi, sebbene anch’essa prenda in prestito questo nome dal gelido vento del nord. In questo caso, però, la pozione ha poco a che fare con il freddo: infatti, permette di rallentare il tempo percepito dal personaggio, fornendogli un vantaggio in battaglia in termini di riflessi e tempi di reazione. Oltre al già citato Vetriolo, questa pozione contiene un quantitativo altrettanto importante di Rebis, un termine alchemico utilizzato per indicare l’unione di due elementi opposti. Essendo una definizione estremamente vaga, è difficile trovare un suo equivalente chimico: basandoci allora sui suoi effetti, potrebbe trattarsi di una sostanza psicotropa in grado di provocare tachipsichia, un fenomeno di alterazione della percezione temporale proprio, in alcune persone, del momento di allerta del quale parleremo in un articolo su Cyberpunk 2077. 5 – Pozione del Gatto Questa pozione migliora ulteriormente le capacità del Witcher di vedere al buio. Il suo elemento principale è il Quebrith, nome con il quale Paracelso, famoso alchimista tedesco del rinascimento, si riferiva allo Zolfo, elemento presente in alcune sostanze della retina. Sappiamo che i witcher possono vedere già bene al buio grazie ai loro occhi da gatto: ma come fa un gatto a vedere al buio? La retina ha due tipi di recettori: i Coni, che rappresentano circa il 20% dei recettori nell’occhio umano, permettono il riconoscimento del colori e sono più lenti a reagire ai cambiamenti di luce, mentre i Bastoncelli, che reagiscono alla luminosità, sono più rapidi e costituiscono il restante 80% dei recettori. Tuttavia, nei gatti, i bastoncelli sono il 96% concedendo una visione più rapida ed efficace anche in situazioni di scarsa illuminazione. Non solo, i felini (come altri mammiferi) hanno anche una membrana riflettente dietro la retina chiamata Tapetum Lucidum che permette alla luce di rimbalzare ulteriormente sui bastoncelli, amplificando il segnale: pare che anche i Witcher abbiano questa mutazione, visto come brillano i loro occhi! 4 – Pozione di rigogolo dorato Questa pozione fornisce a Geralt immunità dai veleni e neutralizza quelli già in circolo. Si tratta di una proprietà indubbiamente fantasiosa, visto che esistono innumerevoli veleni, ciascuno dei quali col proprio antidoto (se esiste!): tuttavia possiamo immaginare che le mutazioni del witcher possano in qualche modo vanificare in parte i veleni, così come le malattie. Una tecnica comunemente usata per combattere i veleni ingeriti è l’assunzione di carboni attivi, ottenuti trattando la torba con alcuni tipi di acidi. Questo metodo consiste nel far assorbire il veleno da parte dei carboni attivi e poi attendere che essi vengano… rilasciati! Dalla descrizione della pozione scopriamo che uno dei suoi ingredienti principali è l’etere: ma cos’è l’etere? Si tratta di una parola che si riferisce a due categorie molto diverse. L’Etere Dietilico è una sostanza chimica, composto di carbonio, idrogeno e ossigeno, storicamente utilizzata per le anestesie e tutt’ora come solvente. Tuttavia, l’etere è anche una sostanza immaginaria che si credeva permeasse l’universo: originariamente teorizzata dai filosofi greci come costituente base del mondo oltre la luna, per secoli si è pensato, in ambito fisico, che fosse il mezzo attraverso il quale si propaga la luce (per questo chiamato anche etere luminifero). Fu solo nel 1887 che l’esperimento di Michaelson e Morley dimostrò l’inesistenza di questo elemento, ponendo le basi per quella che sarebbe stata la teoria della relatività. Ma questa è un’altra storia… 3 – Pozioni curative e rinvigorenti Le pozioni che hanno effetti curativi o rigenerativi su salute e resistenza fisica sono molteplici: Decotto di Raffard il Bianco, Gufo Fulvo, Luna Piena, Rondine… Tutte queste pozioni potrebbero avere sostanzialmente due effetti: migliorare le capacità fisiche e ridurre il dolore. Nel primo caso abbiamo sostanze dopanti: si tratta di sostanze capaci di migliorare le performance atletiche, soprattutto riducendo il senso di fatica, largamente vietate nelle competizioni sportive. Un esempio noto sono le anfetamine, in grado di migliorare anche la concentrazione del soggetto, oppure le foglie di coca. Come ne parleremo in un articolo su cyberpunk, vi assicuro che non ne avete bisogno. Nel secondo caso abbiamo analgesisi e antidolorifici: si tratta di sostanze in grado di ridurre il dolore e in parte la fatica, anch’esse ampiamente bandite dalle gare sportive, come il metadone. A queste sostanze si potrebbe poi aggiungere i coagulanti e antiemorragici che aiutano la cicatrizzazione delle ferite, come ad esempio la vitamina K. 2 – Il Miele Bianco Tutte queste pozioni, in The Witcher, sono sostanzialmente tossiche: se bevute da una persona normale, possono essere fatali, e anche un witcher che abusi di esse avrà effetti nefasti, evidenti nella faccia di Geralt. Per questo i cacciatori di mostri hanno inventato una sostanza in grado di purificare il corpo dalle tossine: il Miele Bianco è preparato con alcuni dei componenti precedenti ed è in grado di azzerare tanto gli effetti delle pozioni ingerite quanto la loro tossicità sul corpo e l’effetto dell’alcool alla base delle pozioni. Per quanto riguarda lo smaltimento della sbornia i farmaci da banco più comuni contengono dosaggi di caffeina e acido acetilsalecilico, principio attivo dell’Aspirina e originariamente ottenuto dalla bollitura del salice. Le sostanza psicotrope citate prima richiedono invece richiedono, spesso, l’uso di antagonisti. Alcune delle sostanze che hanno effetto sull’organismo, infatti, vanno a interagire con il corpo umano legandosi a specifiche proteine dette recettori, che poi attivano l’effetto sul corpo. I recettori possono interagire con più sostanze diverse. Un antagonista è una molecola che può occupare lo stesso recettore di una sostanza psicotropa senta attivarlo. Un esempio pratico è il Naloxone, un farmaco antagonista di oppiacei come eroina e morfina usato, ad esempio, per bloccare le crisi respiratorie proprie dell’overdose da tali sostanze. 1 – Spada d’argento La Spada d’argento è l’arma più classica dei Witcher: la tradizione vuole che essi viaggino con due spade, una di acciaio per gli uomini e una d’argento per i mostri. Ovviamente, la spada d’argento non è fatta d’argento, o almeno non interamente. Secondo la tradizione, infatti, è composta di ferro meteorico: si tratta del metallo ottenibile da alcuni meteoriti ferrosi caduti sulla terra. Storicamente, questi meteoriti sono stati ampiamente usati dalle popolazioni locali (e per questo sono ormai rarissimi) a causa della eccellente qualità del metallo di cui erano composti, spesso una lega di ferro e nickel. L’efficacia della spada contro i mostri, tuttavia, non è dovuta a tale incredibile materiale, bensì al rivestimento di argento assieme alla presenza di rune magiche. Ma come mai l’argento è comunemente riconosciuto, nel mondo antico, come un potente alleato contro creature e incantesimi malvagi? Si da il caso che l’argento abbia delle lievi ma non per questo trascurabili proprietà antibatteriche e veniva usato nell’antichità come strumento, ad esempio, per la purificazione dell’acqua. BONUS: Nella vostra campagna di Dungeons & Dragons 5e Dopo aver creato e condiviso delle regole per le pozioni di The Witcher con il web, ho scoperto la community locale di D&D 5e Homebrew Italia creata da Simone, che ringrazio per il supporto e che, casualmente, stava già lavorando a una versione ben più approfondita dell’intera classe dello Strigo per D&D quinta edizione. Ho così deciso di condividere con voi la sua versione, che potete trovare quì. Scarica “Lo Strigo” per D&D quinta edizione Articolo originale: http://www.profmarrelli.it/2019/09/11/witcher/ Se questo articolo ti è piaciuto, segui il prof. Marrelli su facebook e su ludomedia. Visualizza articolo completo
-
7 Segreti alchemici di The Witcher e di D&D
Tra le armi formidabili di uno Strigo vi è, senza alcun dubbio, l’Alchimia. Il suo stesso corpo, tramite la prova delle erbe, viene mutato irreversibilmente per farne un perfetto uccisore di mostri. Tuttavia, un Witcher continua per il resto della sua vita a preparare e usare pozioni per potenziare ulteriormente questi tratti: di volta in volta, differenti intrugli alchemici gli forniscono quel vantaggio in più del quale ha bisogno, sfruttando basi alcooliche assieme a ingredienti ottenuti dalle piante e da pezzi di mostro. Ma quanto sono realistiche queste pozioni? Grazie a quali fenomeni potrebbero funzionare? Quale scienza si nasconde tra i misteriosi alambicchi di Kaer Morhen? Andiamo a scoprirlo assieme! 7 – Pozione di Sangue Nero Questa pozione fa sì che il sangue del Witcher diventi dannoso per i mostri che ne vengono a contatto. Nel primo capitolo della saga, il suo ingrediente principale è il Vetriolo, uno degli elementi alchemici con i quali vengono prodotte le pozioni nella saga. Vetriolo viene dal latino Vitriol, sigla che significa Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem, in italiano Visita l’interno della terra, operando con rettitudine troverai la pietra nascosta. Al fine di scavare l’interno della terra, il Vetriolo doveva essere una sostanza molto acida: per questo tale termine viene storicamente usato, nell’ambito alchemico, per indicare composti dello Zolfo, in particolare acido solforico o solfuri metallici (i sali ottenuti dall’acido solforico assieme ai metalli). Tuttavia, inserire acido solforico nel sangue risulterebbe letale probabilmente anche per un Witcher: la consistenza bluastra del Vetriolo della saga può, invece, farci pensare ad altre sostanze come il Solfato di Zinco. Si tratta di un composto cristallino con svariati usi medici, un rinforzante del sistema immunitario che, se la vecchia dicotomia vita/non-morte fosse valida, potrebbe danneggiare i non-morti esattamente come aiuta i viventi. Inoltre, è presente nelle ossa e potrebbe giustificare la possibilità di ricavarne, nel primo capitolo della saga videoludica, dalle zanne di animali. 6 – Pozione Bufera di Neve Il nome inglese di questa pozione, “Blizzard”, ricorda a tutti la celebre casa produttrice di videogiochi, sebbene anch’essa prenda in prestito questo nome dal gelido vento del nord. In questo caso, però, la pozione ha poco a che fare con il freddo: infatti, permette di rallentare il tempo percepito dal personaggio, fornendogli un vantaggio in battaglia in termini di riflessi e tempi di reazione. Oltre al già citato Vetriolo, questa pozione contiene un quantitativo altrettanto importante di Rebis, un termine alchemico utilizzato per indicare l’unione di due elementi opposti. Essendo una definizione estremamente vaga, è difficile trovare un suo equivalente chimico: basandoci allora sui suoi effetti, potrebbe trattarsi di una sostanza psicotropa in grado di provocare tachipsichia, un fenomeno di alterazione della percezione temporale proprio, in alcune persone, del momento di allerta del quale parleremo in un articolo su Cyberpunk 2077. 5 – Pozione del Gatto Questa pozione migliora ulteriormente le capacità del Witcher di vedere al buio. Il suo elemento principale è il Quebrith, nome con il quale Paracelso, famoso alchimista tedesco del rinascimento, si riferiva allo Zolfo, elemento presente in alcune sostanze della retina. Sappiamo che i witcher possono vedere già bene al buio grazie ai loro occhi da gatto: ma come fa un gatto a vedere al buio? La retina ha due tipi di recettori: i Coni, che rappresentano circa il 20% dei recettori nell’occhio umano, permettono il riconoscimento del colori e sono più lenti a reagire ai cambiamenti di luce, mentre i Bastoncelli, che reagiscono alla luminosità, sono più rapidi e costituiscono il restante 80% dei recettori. Tuttavia, nei gatti, i bastoncelli sono il 96% concedendo una visione più rapida ed efficace anche in situazioni di scarsa illuminazione. Non solo, i felini (come altri mammiferi) hanno anche una membrana riflettente dietro la retina chiamata Tapetum Lucidum che permette alla luce di rimbalzare ulteriormente sui bastoncelli, amplificando il segnale: pare che anche i Witcher abbiano questa mutazione, visto come brillano i loro occhi! 4 – Pozione di rigogolo dorato Questa pozione fornisce a Geralt immunità dai veleni e neutralizza quelli già in circolo. Si tratta di una proprietà indubbiamente fantasiosa, visto che esistono innumerevoli veleni, ciascuno dei quali col proprio antidoto (se esiste!): tuttavia possiamo immaginare che le mutazioni del witcher possano in qualche modo vanificare in parte i veleni, così come le malattie. Una tecnica comunemente usata per combattere i veleni ingeriti è l’assunzione di carboni attivi, ottenuti trattando la torba con alcuni tipi di acidi. Questo metodo consiste nel far assorbire il veleno da parte dei carboni attivi e poi attendere che essi vengano… rilasciati! Dalla descrizione della pozione scopriamo che uno dei suoi ingredienti principali è l’etere: ma cos’è l’etere? Si tratta di una parola che si riferisce a due categorie molto diverse. L’Etere Dietilico è una sostanza chimica, composto di carbonio, idrogeno e ossigeno, storicamente utilizzata per le anestesie e tutt’ora come solvente. Tuttavia, l’etere è anche una sostanza immaginaria che si credeva permeasse l’universo: originariamente teorizzata dai filosofi greci come costituente base del mondo oltre la luna, per secoli si è pensato, in ambito fisico, che fosse il mezzo attraverso il quale si propaga la luce (per questo chiamato anche etere luminifero). Fu solo nel 1887 che l’esperimento di Michaelson e Morley dimostrò l’inesistenza di questo elemento, ponendo le basi per quella che sarebbe stata la teoria della relatività. Ma questa è un’altra storia… 3 – Pozioni curative e rinvigorenti Le pozioni che hanno effetti curativi o rigenerativi su salute e resistenza fisica sono molteplici: Decotto di Raffard il Bianco, Gufo Fulvo, Luna Piena, Rondine… Tutte queste pozioni potrebbero avere sostanzialmente due effetti: migliorare le capacità fisiche e ridurre il dolore. Nel primo caso abbiamo sostanze dopanti: si tratta di sostanze capaci di migliorare le performance atletiche, soprattutto riducendo il senso di fatica, largamente vietate nelle competizioni sportive. Un esempio noto sono le anfetamine, in grado di migliorare anche la concentrazione del soggetto, oppure le foglie di coca. Come ne parleremo in un articolo su cyberpunk, vi assicuro che non ne avete bisogno. Nel secondo caso abbiamo analgesisi e antidolorifici: si tratta di sostanze in grado di ridurre il dolore e in parte la fatica, anch’esse ampiamente bandite dalle gare sportive, come il metadone. A queste sostanze si potrebbe poi aggiungere i coagulanti e antiemorragici che aiutano la cicatrizzazione delle ferite, come ad esempio la vitamina K. 2 – Il Miele Bianco Tutte queste pozioni, in The Witcher, sono sostanzialmente tossiche: se bevute da una persona normale, possono essere fatali, e anche un witcher che abusi di esse avrà effetti nefasti, evidenti nella faccia di Geralt. Per questo i cacciatori di mostri hanno inventato una sostanza in grado di purificare il corpo dalle tossine: il Miele Bianco è preparato con alcuni dei componenti precedenti ed è in grado di azzerare tanto gli effetti delle pozioni ingerite quanto la loro tossicità sul corpo e l’effetto dell’alcool alla base delle pozioni. Per quanto riguarda lo smaltimento della sbornia i farmaci da banco più comuni contengono dosaggi di caffeina e acido acetilsalecilico, principio attivo dell’Aspirina e originariamente ottenuto dalla bollitura del salice. Le sostanza psicotrope citate prima richiedono invece richiedono, spesso, l’uso di antagonisti. Alcune delle sostanze che hanno effetto sull’organismo, infatti, vanno a interagire con il corpo umano legandosi a specifiche proteine dette recettori, che poi attivano l’effetto sul corpo. I recettori possono interagire con più sostanze diverse. Un antagonista è una molecola che può occupare lo stesso recettore di una sostanza psicotropa senta attivarlo. Un esempio pratico è il Naloxone, un farmaco antagonista di oppiacei come eroina e morfina usato, ad esempio, per bloccare le crisi respiratorie proprie dell’overdose da tali sostanze. 1 – Spada d’argento La Spada d’argento è l’arma più classica dei Witcher: la tradizione vuole che essi viaggino con due spade, una di acciaio per gli uomini e una d’argento per i mostri. Ovviamente, la spada d’argento non è fatta d’argento, o almeno non interamente. Secondo la tradizione, infatti, è composta di ferro meteorico: si tratta del metallo ottenibile da alcuni meteoriti ferrosi caduti sulla terra. Storicamente, questi meteoriti sono stati ampiamente usati dalle popolazioni locali (e per questo sono ormai rarissimi) a causa della eccellente qualità del metallo di cui erano composti, spesso una lega di ferro e nickel. L’efficacia della spada contro i mostri, tuttavia, non è dovuta a tale incredibile materiale, bensì al rivestimento di argento assieme alla presenza di rune magiche. Ma come mai l’argento è comunemente riconosciuto, nel mondo antico, come un potente alleato contro creature e incantesimi malvagi? Si da il caso che l’argento abbia delle lievi ma non per questo trascurabili proprietà antibatteriche e veniva usato nell’antichità come strumento, ad esempio, per la purificazione dell’acqua. BONUS: Nella vostra campagna di Dungeons & Dragons 5e Dopo aver creato e condiviso delle regole per le pozioni di The Witcher con il web, ho scoperto la community locale di D&D 5e Homebrew Italia creata da Simone, che ringrazio per il supporto e che, casualmente, stava già lavorando a una versione ben più approfondita dell’intera classe dello Strigo per D&D quinta edizione. Ho così deciso di condividere con voi la sua versione, che potete trovare quì. Scarica “Lo Strigo” per D&D quinta edizione Articolo originale: http://www.profmarrelli.it/2019/09/11/witcher/ Se questo articolo ti è piaciuto, segui il prof. Marrelli su facebook e su ludomedia.
-
Ray Winninger è il nuovo capo del Team D&D
SI. Va detto che il sig. Ray Winninger è il capo del team (Executive Producer), ma il posto di Mearls come Lead Designer è di Jeremy Crawford. Quest'ulitimo e Mearls hanno lavorato fianco a fianco dalla 4a edizione (2007 per l'esattezza). Quello che sta emergendo quindi è lo stile di Jeremy... vedremo in futuro come evolveranno le cose.
-
Che fine ha fatto il famiglio in D&D?
Dai ragazzi, siamo un po' intellettualmente onesti. Non venite a dirmi che i vostri giocatori non usano il famiglio come "cosa". Certo può essere che qualcuno lo accudisce, ci parla e lo coccola anche, ma quella è un'eccezione. Quando non serve lo spedisco nella sua sfera poké e li rimane finché non mi serve di nuovo. E' evidente che l'incantesimo "spinge" a usarlo in un certo modo. E' la versione nemmeno tanto ridotta di Occhio Arcano.
-
Che fine ha fatto il famiglio in D&D?
@Drimos si ok, ma tra muore il famiglio e lo richiamo dopo 30 secondi e muore il famiglio e muoio anche io, penso ci siano delle scale intermedie. Da come è scritto l'incantesimo torna sempre quello.
-
Che fine ha fatto il famiglio in D&D?
Questa è un'asserzione che vale per ogni cosa non tiene conto delle meccaniche. Le meccaniche indirizzano un certo tipo di gioco. Il giocatore sa benissimo che non c'è motivo per non usare il famiglio in ogni situazione e pertanto lo usa sempre.
-
Che fine ha fatto il famiglio in D&D?
Il mio titolo per l'articolo era "Il pokemon come famiglio", perchè di quello si tratta. Con una piccola differenza: da quello che io so, non sono un esperto, i pokemon possono morire! Ovviamente nel 2008 venne massacrato come tutta la 4a edizione, ma oggi siamo in periodo di revisione storica. Non entro nel merito delle meccaniche, tranne per una certa: il famiglio è IMMORTALE. Perché questo concetto di famiglio non piace nemmeno a me? Perchè, uno degli scopi principali del famiglio, è quello di scout. Ovviamente, questo comporta un certo "rischio" per il famiglio. Ne consegue, che il padrone li usa con parsimonia. In 4e, e in 5e, questo non accade. DM: "Sei sicuro di mandare il famiglio a vedere? E' pericoloso" Giocatore: "Si, tanto se lo uccidono, lo richiamo di nuovo" Adesso non tiratemi fuori narrazione, interpretazione o cose simili. Quello è ciò che fanno col famiglio il 90% dei giocatori. Quell'idea di famiglio va contro ogni tipo di letteratura fantasy!