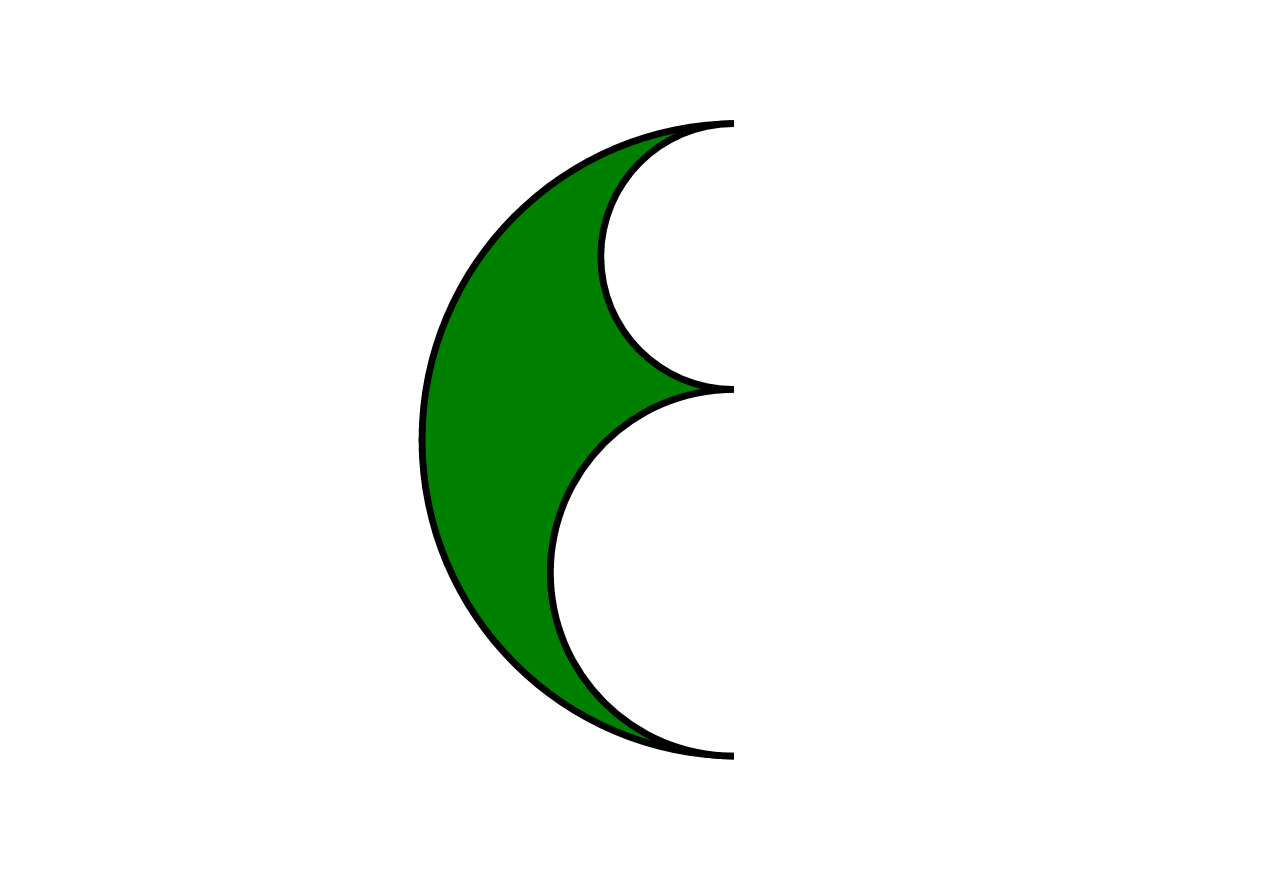
Tutti i contenuti pubblicati da Bille Boo
-
Ability Score Increases
Direi di no, non lo implica per niente. E, se il racconto riportato è vero, quelle persone dovrebbero essere solo contente che quell'argomento abbia dato loro l'occasione di sbarazzarsi subito di un soggetto del genere. Quando una persona è tossica, il problema è che è tossica, non l'argomentazione di cui si serve per intossicare. Attenzione a non cadere nell'errore (così comune, in effetti, proprio tra i censori della pubblica moralità) di attribuire alle aziende, alle letture, ai comunicati il potere di rendere cattiva la gente.
- Secondo voi, come si può rappresentare [...]
-
Secondo voi, come si può rappresentare [...]
Ciao, è davvero difficile risponderti perché non è chiaro quali sono i due concept che hai, in particolare il secondo (sul primo hai specificato "furiosa macchina assassina" che è già un indizio). Ti va di aggiungere qualcosa? Per come la vedo, con le informazioni che ho adesso, la risposta sarebbe: qualsiasi. Intendo qualsiasi combinazione di classe e sottoclasse. Perché i concetti che hai espresso mi sembrano (magari sbaglio) più che altro incentrati sul comportamento, i valori, la morale e la posizione sociale, che sono indipendenti dalla classe.
-
Sei Culture del Gioco di Ruolo
Ahahah! Spero di no... in realtà non amo le etichette, ma se proprio devo sceglierne una propenderei più per la Classica. 🙂
-
Sei Culture del Gioco di Ruolo
Il mondo dei GdR è vario, e non sono una novità i tentativi di classificare le differenze di cultura e stile che lo pervadono. Questa analisi, però, presenta un punto di vista per certi versi originale. Articolo di John B. del 06 Aprile 2021, dal blog The Retired Adventurer In questo post presenterò la tassonomia delle sei principali culture di gioco, insieme a qualche nota sulle loro origini storiche. Lo faccio sia per aiutare le persone appartenenti a queste diverse culture di gioco a comprendere meglio i valori della propria, sia per incoraggiare una discussione interculturale più densa e produttiva. Sono almeno sei le culture di gioco principali che sono emerse nella storia dell’hobby del GdR. Potrebbero essercene di più: la mia analisi si concentra essenzialmente su quelle di lingua inglese, benché almeno tre di loro abbiano una presenza non anglofona significativa. In aggiunta, esiste una proto-cultura che è esistita tra il 1970 e il 1976 prima che la suddivisione delle diverse culture iniziasse. Una cultura di gioco è un set di norme condivise (obiettivi, valori, tabù, etc.), considerazioni e tecniche che accomunano un gruppo di persone abbastanza vasto da far sì che non tutte siano in contatto diretto tra loro (chiamiamolo community). Le culture di gioco sono trasmesse attraverso una varietà di canali: dai libri alle avventure, passando per l’insegnamento di un individuo ad un altro, fino agli articoli sulle riviste e agli spettacoli in streaming. Una cultura di gioco è vagamente simile a un network of practice, se il termine vi è familiare. Gli individui che hanno appreso una o più di queste culture sviluppano poi stili di gioco personali. Voglio precisare che, secondo me, parlare di giochi specifici come intrinsecamente associati a specifiche culture è fuorviante: i giochi possono essere giocati con vari stili diversi, anche in linea con i valori di culture differenti. È vero, tuttavia, che molti giochi contengono un testo che raccomanda di giocarli in un certo modo, in linea con una cultura particolare, o contengono elementi che esprimono l’adesione del creatore ai valori di quella cultura. Le Sei Culture 1 - Classica Il gioco Classico ruota attorno allo sviluppo progressivo del potere dei PG e delle sfide che essi affrontano, con regole che aiutano a mantenere le due cose grossomodo in proporzione tra loro, e a risolvere in modo “equo” le loro interazioni. Questo è esplicitato nei consigli ai dungeon master della Guida del DM di AD&D 1E, ma si ripresenta in diverse altre fonti; le più ovvie, probabilmente, sono i moduli da torneo, soprattutto quelli della Serie R distribuiti dalla RPGA nei suoi primi tre anni di attività, che evidenziano dei “reset” periodici tra le sezioni dell’avventura per assicurare un’esperienza “equa” ai giocatori, mentre passano da un tavolo da torneo all’altro a giocare tali sezioni. L’accento sul gioco come sfida porta a un sacco di avventure tra terre selvagge e labirinti tentacolari, e ricicla la medesima notazione anche per descrivere le città, a loro volta trattate come scenario di sfide. A un certo punto i PG diventano abbastanza potenti da comandare una signoria, e questo allarga ulteriormente la gamma delle sfide, permettendo di ingaggiare scontri di massa in stile wargame. Il punto del giocare, nella cultura Classica, non è il raccontare una storia (benché non sia un problema se ciò avviene), bensì affrontare sfide e minacce che gradualmente aumentano di importanza e di potenza, man mano che i PG salgono di livello. Una lunga campagna con una lenta progressione di potere dei PG, interrotta solo dall’occasionale morte, è una giocata ideale per la cultura Classica. Tutto questo nasce più o meno tra il 1976 e il 1977, quando Gygax passa, dalla sua idea iniziale di OD&D come un non-gioco (“non-game”), al tentare di stabilizzare l’esperienza di gioco. Inizia con la sua invettiva contro “Dungeons and Beavers” e altre deviazioni dal suo proprio stile in Strategic Review dell’Aprile 1976, quindi diventa un più ampio riassetto delle pubblicazioni della TSR dal 1977 in poi. Nello specifico, esse iniziano a fornire al pubblico esempi concreti di gioco (tra cui esempi di dungeon e scenari, inclusi interi moduli) e consigli specifici sulle procedure e i valori più appropriati per il gioco. Il riassetto ha inizio con la pubblicazione del Holmes Basic (1977) e di Lost Caverns of Tsojcanth (1977), per poi culminare in AD&D (1977-1979) e la serie BECMI scritta da Mentzer (1983-1986). La Judges Guild, la RPGA, Dragon Magazine e anche altri editori (ad esempio Mayfair Games) si allineano a questo approccio e diffondono i princìpi Classici, prima che Gygax e Mentzer abbandonino la TSR tra fine 1985 e inizio 1986. La Judges Guild perde la sua licenza di stampa per il materiale di D&D nel 1985, e i tornei RPGA si allontanano dal gioco Classico intorno al 1983. La maggioranza degli altri autori alla TSR si converte al Trad (vedi sotto) entro la metà degli anni ’80, perciò il supporto ufficiale per lo stile Classico inizia a prosciugarsi, benché diverse persone continuino ad adottarlo nel loro gioco. Il Classico resuscita nei primi anni 2000 quando gli irriducibili che hanno continuato a giocare in questa maniera usano Internet per ritrovarsi su forum come Dragonsfoot, Knights and Knaves Alehouse, e altri. Questo revival è parte delle ragioni che portano al rilascio di OSRIC (2006). NB: “Classico” è l’unica denominazione, in questa trattazione, a non essere un autonimo usato dai suoi stessi praticanti, sebbene Gus L. di All Dead Generations abbia molto in comune con le loro idee e definisca effettivamente il proprio stile con questa parola. Una stranezza della storia è che le persone che nei primi anni 2000 tentavano di revitalizzare il Classico sono spesso confluite nell’OSR, malgrado i due gruppi abbiano norme e valori distinti. Ha portato a un po’ di confusione il fatto che alcuni soggetti importanti (come Matt Finch) siano effettivamente passati dall’essere revivalisti del Classico all’essere tra i fondatori dell’OSR. Dato che entrambi i gruppi sono interessati al gioco incentrato sulla sfida, anche se hanno punti di vista diversi sul significato di tale termine, ci sono state fasi di intersezione e interazione produttiva tra loro (e anche un sacco di sciocchi litigi e derisioni: questa è la vita). Questa mescolanza di persone che hanno diverse culture di gioco, e che sembrano inizialmente far parte dello stesso movimento ma poi si rivelano interessate a cose diverse, è abbastanza comune: gli Story Game e il Nordic Larp sono passati attraverso un processo simile (lo vedremo tra breve). 2 - Trad (abbreviazione di Tradizionale) Anche se i suoi aderenti lo chiamano Trad, non dobbiamo pensare che sia il modo più vecchio di giocare di ruolo (non lo è). Il Trad non è ciò che facevano Gary e compagni: quello è il Classico. Piuttosto, è la reazione a quello che stavano facendo. Il Trad si basa sul concetto che l’obiettivo primario del giocare sia il narrare una storia emozionalmente soddisfacente, e che il DM è l’agente creativo primario che lo fa avvenire: costruendo il mondo, stabilendo tutti i dettagli della storia, interpretando gli antagonisti, il tutto principalmente seguendo i propri gusti e la propria visione personale. I PG possono contribuire, ma i loro contributi sono secondari come valore e autorità rispetto a quelli del DM. Se mai avete sentito qualcuno lamentarsi (o entusiasmarsi!) per giocate che erano come scorrere un romanzo fantasy, quello era Trad. Il Trad esalta un modo di giocare che produce esperienze comparabili ad altri mezzi di intrattenimento, come film, romanzi, televisione, mitologia eccetera, e i suoi valori spesso incoraggiano ad adottare tecniche derivanti da quei mezzi. Il Trad emerge nei tardi anni ’70, con un primo embrione concettuale nel gruppo di Dungeons and Beavers al Caletch, ma anche nel circolo di gioco di Tracy e Laura Hickman nello Utah. L’avvenimento fondante, per Tracy, a quanto pare è stato imbattersi in un vampiro in un dungeon e pensare che aveva davvero bisogno di una storia che spiegasse cosa ci facesse a vagare laggiù. Hickman ha scritto una serie di avventure nel 1980 (la serie del Night Verse) che tentava di introdurre più elementi narrativi, ma l’azienda che avrebbe dovuto pubblicarla è fallita. Quindi ha deciso di venderla alla TSR, che però disse che l’avrebbe acquistata solo se Hickman fosse andato a lavorare per loro. Perciò, nel 1982, lo ha fatto e nel giro di pochi anni le sue idee si sono diffuse nella compagnia fino a diventare la visione dominante del concetto di gioco di ruolo. La prima importante pubblicazione, al di fuori del circuito TSR, che articola la visione Trad è Call of Cthulhu di Sandy Petersen (1981), il quale spiega ai lettori che lo scopo del giocare è creare un’esperienza simile a una storia horror, e fornisce consigli specifici per farlo (come il “modello a cipolla”). I valori Trad si cristallizzano come una rilevante e distinta cultura di gioco in D&D con i moduli di Ravenloft (1983) e Dragonlance (1984) scritti da Hickman. La TSR pubblica Ravenloft in risposta al successo commerciale e di critica di Call of Cthulhu, e in tal modo vince dei premi e vende un sacco di copie. In pochi anni l’idea di “roleplaying, not rollplaying”, e l’importanza del Dungeon Master come creatore di una narrativa elaborata ed emozionalmente gratificante, prevalsero. Penso che la capacità di importare termini e idee da altre forme d’arte abbia probabilmente aiutato molto, perché rende il Trad accessibile a chiunque abbia frequentato qualche lezione di scienze umane all’Università. Il Trad fu la cultura di gioco dominante almeno dalla metà degli anni ’80 sino ai primi anni 2000, ed è tuttora uno stile molto comune. Per un esempio abbastanza ben strutturato nell’ambito dello stile Trad, da parte di qualcuno che è stato un autore autorevole per gli ultimi 15 anni circa, date un’occhiata al S. John Ross’s RPG Lexicon. Entrambi i prossimi due stili emergono in seguito a problemi con il Trad, soprattutto con l’esperienza di giocare Vampiri (che nell’aspirazione dei suoi autori voleva essere “il più Trad dei Trad”), ma scendere nei dettagli sarebbe troppo per questo articolo, quindi mi limito a menzionarlo e ci tornerò un’altra volta. 3 - Nordic Larp Anche questo è un autonimo. “Nordic” si riferisce all’origine e alla massa principale della base giocante, non a una vera limitazione geografica di qualche genere. “Larp” [acronimo di Live Action Role Playing, “gioco di ruolo dal vivo”, NdT] fa parte della designazione per ragioni che non mi sono chiare, visto che le sue idee sono nate nel gioco di ruolo da tavolo, e la sua filosofia e le sue aspirazioni sono realizzabili tanto nei GdR da tavolo quanto in quelli in costume. (Scriverlo come se non fosse un acronimo, quindi con solo l’iniziale in maiuscolo anziché tutte le lettere, è un’usanza del Nordic Larp, quindi in conformità con il principio di autonimia seguirò la stessa convenzione quando parlerò della cultura di gioco, anche se scriverò LARP quando mi riferirò all’attività del ruolare dal vivo.) Il Nordic Larp ruota attorno all’idea che lo scopo principale di un gioco di ruolo sia l’immersione in un’esperienza; in genere quella di un personaggio specifico, ma a volte in un’esperienza di altro tipo in cui giocatore e personaggio non sono nettamente distinti: il gruppo sperimentale Jeep spesso usa giochi astratti per influenzare direttamente il giocatore. Maggiore è il “bleed” che si riesce a creare tra un giocatore e il ruolo che ha nel gioco, e meglio è. Spesso il Nordic Larp comprende delle lunghe “sessioni” (simili a escursioni di un fine settimana) seguite da lunghi debrief in cui ognuno processa l’esperienza che ha avuto attraverso il suo personaggio. Inserire il personaggio all’interno di una storia più grande può essere un modo di produrre esperienze vivide e coinvolgenti, ma non è necessario e potrebbe perfino essere d’intralcio (specialmente se fatto male). I giocatori del Nordic Larp enfatizzano gli aspetti collaborativi, ma guardando più in profondità si vede che si tratta di un rifiuto dell’idea Trad di un singolo DM-autore che crea l’esperienza, e la collaborazione serve a migliorare l’immersione unificando maggiormente l’agency del giocatore e del personaggio. Penso che il termine LARP faccia venire in mente immagini di gente che fa cosplay fantasy, e a volte ci sono elementi del genere in certi giochi di Nordic Larp, ma in realtà credo che la tendenza sia stata quella di allontanarsi dai giochi del fantastico in favore di scenari e situazioni più vicini alla vita reale, dato che ciò permette di incorporare l’architettura moderna, la tecnologia e altri dettagli per facilitare l’immersione. La prima pubblicazione importante riguardo il Nordic Larp di cui sono a conoscenza è il molto timido Manifesto of the Turku School di Mike Pohjola nel 2000, e credo che la comunità originaria abbia dialogato con quella di The Forge, benché avessero ideali di gioco molto differenti. Da lì al 2005 si sono avuti gruppi come Jeep che hanno sviluppato queste idee, e nel 2010 la pubblicazione del libro Nordic Larp. Oggi c’è anche una wiki e un sito web ufficiale. Il Nordic Larp è la parte del gioco di ruolo che sembra beneficiare della quota maggiore di fondi per lo studio accademico. Non so bene perché, ma sospetto che abbia qualcosa a che fare con l’interesse a mercificare i concetti del LARP per creare esperienze immersive di intrattenimento per turisti nei mega-resort delle nazioni del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Non linkerò qui nessun individuo specifico connesso al Nordic Larp che lavora laggiù, per non rischiare di infangarlo, ma esistono (per favore, non attaccate nessuno nemmeno nei commenti). 4 - Story Game Di nuovo un autonimo. La maggior parte di coloro a cui non piacciono li chiama con termini come “giochi forgiti” o “giochi indie post-Forgia”, riferendosi al forum di GdR indie the Forge. Anche “GdR Indie” è stata una denominazione utilizzata, a un certo punto, ma non credo che fosse particolarmente azzeccata o edificante, ed evidentemente non lo credevano neanche gli aderenti a questa cultura, visto che l’hanno perlopiù abbandonata. Ecco un post di Across the Table che discute l’origine del termine “story game”. Il Big Model è notoriamente ostico da comprendere e la teoria post-forgita contiene un sacco di idee con cui sono in forte disaccordo, ma credo che un’onesta descrizione della loro posizione, che non usi la loro stessa terminologia, sia che l’esperienza di gioco ideale è quella che minimizza la dissonanza ludonarrativa. Un buon gioco ha una forte consonanza tra i desideri di chi lo gioca, le regole, e le dinamiche derivanti dalla loro interazione. Insieme, queste cose permettono alle persone di realizzare i loro desideri, quali che siano. Va evitata l’incoerenza (“incoherence”) perché da luogo a “zilch play” o “brain damage”, come lo ha chiamato Ron Edwards una volta. La comunità degli Story Game, va detto in suo favore, è disposta a essere molto radicale in termini di tecniche che realizzano questo scopo: sia le meccaniche che lo sviluppo di impostazioni (gli story gamers le chiamano spesso “Intenti Creativi” ovvero “Creative Agendas”) come il “narrativismo” hanno lo scopo di produrre consonanza ed evitare dissonanza su tutti i livelli che si possono prefigurare. Gli Story Game nascono con Ron Edwards nel 1999, quando scrive Il Sistema Conta e crea The Forge. Da lì al 2004 si hanno il Provisional Glossary e il Big Model, e un milione di discussioni su Internet in merito a cosa è o non è “narrativista”, a quanto brain damage stanno causando i GdR, eccetera. I forum veri e propri degli Story Game sono fondati nel 2006 come successori di The Forge. Nell’ultimo decennio il grosso dello sviluppo degli Story Game tende a orientarsi intorno ai sistemi Powered by the Apocalypse, basati su Apocalypse World di Vincent Baker. Se volete un grande esempio di qualcuno che applica le norme culturali degli Story Game ad un gioco che è stato scritto per essere giocato nel modo Trad, The Sacrament of Death di Eero Tuovien descrive le sue esperienze nel fare esattamente questo. 5 - OSR (“Old School Renaissance / Revival”) Sì, appare così tardi, nell’ordine cronologico. E sì, l’OSR non è il gioco Classico: è una reinvenzione romantica, non una catena di tradizione ininterrotta. L’OSR attinge al gioco basato sulla sfida, tipico della proto-cultura di D&D, e lo combina con un interesse all’agency dei PG, in particolare nella forma della capacità decisionale. L’obiettivo è un gioco dove le decisioni dei PG, specialmente quelle diegetiche, fanno da traino. Penso che lo possiate vedere in forma molto chiara nei consigli che ha dato Chris McDowall, sul suo blog, su come condurre Into the Odd ed Electric Bastionland. Un’osservazione importante che vorrei fare è la distinzione tra la sfida progressiva della cultura Classica e la sfida più variabile dell’OSR. L’OSR perlopiù non bada a cose come l’“equità” nel contesto dell’“equilibrio di gioco” (mentre Gygax lo faceva). La variabilità dell’agency dei giocatori attraverso una serie di decisioni è molto più interessante, per la maggior parte degli aderenti all’OSR, di quanto non lo sia per gli aderenti al Classico. L’OSR rifiuta espressamente la mediazione di autorità svolta da una struttura di regole preesistente, incoraggiando invece le interazioni diegetiche attraverso ciò che S. John Ross chiamerebbe “ephemeral resources” e “invisible rulebooks”, e che l’OSR chiama rispettivamente “giocare il mondo” (“playing the world”) e “abilità del giocatore” (“player skill”). Essenzialmente, se non si è vincolati dalle regole si può giocare con uno spazio di risorse più ampio, che può contribuire a inquadrare le sfumature dell’agency dei PG in modi potenzialmente molto precisi e dotati di grande finezza; questo permette di far fronteggiare ai giocatori una maggiore varietà di sfide da superare. Potrei scrivere un intero post solo sulle funzioni delle tabelle casuali, comunque si legano al punto della variabilità dell’agency: introducono sorprese e imprevedibilità, assicurando che l’agency cambi nel tempo. Tendo a far risalire l’inizio dell’OSR a poco dopo la pubblicazione di OSRIC (2006), che ha spalancato le porte alla possibilità di usare l’OGL per ripubblicare le meccaniche del vecchio D&D pre-3.x. Con questa nuova opzione, ci sono state persone che hanno solo voluto far rivivere AD&D 1e, e altre che invece hanno voluto usare i vecchi set di regole come piattaforma di lancio per le loro nuove creazioni. Nel 2007 c’è stato Labyrinth Lord, e la valanga è seguita in breve tempo. Gli esordi dell’OSR hanno avuto da Grognardia una visione ricostruita del passato rispetto a cui posizionarsi come eredi. Ci sono stati anche notevoli sviluppi intellettuali come i “diagrammi di Melan” per i dungeon e i pointcrawl di Chris Kutalik. Direi che tra il 2006 e, più o meno, il 2012 l’OSR ha organizzato le sue norme in un corpo di idee relativamente coerente sul modo di giocare considerato appropriato. 6 - OC / Neo-trad Questo è l’unico termine che non è pienamente autonimo, sebbene sia possibile aggiungere “OC” ad un post di ricerca per giocare online e reclutare così in modo ripetibile persone di questa cultura, quindi ci siamo abbastanza vicini. La chiamo anche Neo-trad, innanzitutto perché condivide molte delle norme della cultura Trad, e in secondo luogo perché penso che chi appartiene a questa cultura si creda parte del Trad. Talvolta potrete veder chiamare questo stile anche “moderno” (“the modern style”), in contrapposizione all’OSR. Ecco un esempio di qualcuno che lo chiama Neo-trad ed elabora una visione pura di questi stile (benché io non sia d’accordo con la lista di giochi che fornisce come esempi di Neo-trad alla fine dell’articolo). Su Reddit, l’OC è spesso chiamato “moderno”, in espressioni come “il modo moderno di giocare” o “i giochi moderni”. L’OC, di base, concorda con il Trad che lo scopo del gioco sia di raccontare una storia, ma riduce l’autorità del DM come creatore di quella storia ed esalta il ruolo dei giocatori come contributori e creatori. Il DM diventa un curatore e facilitatore che lavora principalmente con materiale fatto da altri: in pratica, gli autori/editori e i giocatori. La cultura OC ha un concetto diverso di cosa sia una “storia”: si focalizza sulle aspirazioni e gli interessi dei giocatori, e nella loro realizzazione come miglior modo di farli “divertire”. Il focus sul realizzare le aspirazioni dei giocatori è ciò che permette al mago di 20° livello, che lancia sciame di meteore per annichilire un nemico, e alla gente che usa D&D 5e per giocare a gestire il proprio ristorante, di coesistere nella stessa cultura comune. Questa cultura è chiamata talvolta, in modo dispregiativo, “Tirannia del Divertimento” (“Tyranny of Fun”, un termine coniato dall’OSR) a causa del suo concentrarsi sulla gratificazione immediata, rispetto ad altri stili di gioco. Il termine “OC” sta per “Personaggio Originale” (“Original Character”) e viene dal gioco di ruolo fandom online in forma libera (“freeform”) che era popolare su piattaforme come Livejournal nei primi anni 2000. OC è quando inserisci un personaggio originale in un gioco di ruolo ambientato nell’universo di Harry Potter, invece che giocare come Harold the Cop in persona. Nonostante fossero in forma libera, ciò senza tiri di dado né Dungeon Master, questi giochi avevano spesso estesi complessi di regole in merito a quali affermazioni si potessero introdurre nella giocata, con giocatori che si appellavano a tali regole l’uno contro l’altro per risolvere le dispute. Per le generazioni più giovani di giocatori di ruolo, giochi di questo tipo sono stati spesso il canale che li ha introdotti all’hobby. Penso che il GdR OC sia emerso durante l’era 3.x (2000-2008), probabilmente con la crescita di Living Greyhawk Core Adventures, e dell’apparato del gioco organizzato e più in generale del gioco online con estranei. Il gioco organizzato ha finito per ridurre il potere del DM in favore dell’autorità dei testi di regole, degli editori, degli amministratori e, assolutamente, dei giocatori. Dal momento che i DM possono cambiare da un’avventura all’altra mentre i personaggi giocanti rimangono, questi ultimi diventano più importanti, con le regole standard che garantiscono la compatibilità attraverso le diverse giocate. La discrezionalità e inventiva del DM diventano un ostacolo a questa intercompatibilità, quindi vengono svalutate. È da qui che proviene l’enfasi su “RAW” e sull’usare solo materiale ufficiale (ma anche l’idea che se qualcosa è pubblicato dovrebbe essere disponibile al tavolo): sono cose che erodono il potere del DM e trasferiscono quel potere nelle mani dei PG. Queste norme sono state rinforzate e diffuse dai forum di “ottimizzazione del personaggio”, che si affidavano solamente al testo e criticavano formalmente il “DM fiat”, e dai character builder ufficiali di D&D e di altri giochi. I moduli, che limitano in modo importante la discrezione del DM per fornire un set costante di condizioni ai giocatori, sono un altro importante elemento a sostegno di questo stile. Lo stile OC è reso, inoltre, particolarmente popolare dai giochi in streaming online come Critical Role, dato che, se fatto bene, tende a produrre giocate abbastanza facili da guardare come se fossero show televisivi. I personaggi di queste serie diventano figure di ispirazione con cui la fanbase sviluppa un rapporto para-sociale ("parasocial interaction"), e al cui fianco esulta quando realizzano il proprio “arco”. Niente quiz né etichette Quando ho presentato per la prima volta queste categorie su un forum, qualcuno scherzando ha detto che avrei dovuto creare un quiz che permettesse alle persone di determinare a quale cultura tra queste appartengono, ma preferisco di no. Sinceramente, penso che la maggior parte dei singoli giocatori o gruppi siano un amalgama di culture, che si realizza in uno stile individuale. Le culture di gioco sono più simili a paradigmi: hanno il loro punto di coesione nei valori e nell’idea di cosa potrebbe costituire un “gioco ideale” (più formalmente, condividono teloi di gioco). Essere parte di una cultura di gioco è, in un certo senso, la capacità di riconoscere quando qualcun altro sta giocando in accordo con un set di valori che avete in comune. Il mio scopo principale nella tassonomia qui esposta è aiutare le persone a capire meglio che esistono diversi paradigmi di gioco, che considerano positive cose diverse, benché possano essere combinati insieme (con una varietà di risultati divertenti) in situazioni concrete. Dubito che questa lista sia esaustiva, e probabimente ci sono culture che ho trascurato, nonché altre che devono ancora emergere. Lo scopo della lista è soprattutto di illustrare brevemente che ci sono molti diversi valori di gioco, e di discutere la logica che anima alcuni tra i più conosciuti. L’intento originario di questa trattazione era parlare del gioco di ruolo OC, perché penso che sia quello meno analizzato in genere, e che molte analisi siano relativamente dispregiative (tra cui la “tirannia del divertimento”, vedi sopra). Inoltre tende ad esserci un sacco di confusione tra persone che operano nel paradigma OC e in quello Trad, dato che spesso usano gli stessi termini per riferirsi a cosa molto diverse. In aggiunta, senza voler essere antipatico, il gioco di ruolo OC tende ad essere il paradigma di default dei nuovi giocatori che si avvicinano all’hobby attraverso lo streaming, di conseguenza contiene la più ampia quota di persone inesperte e inconsapevoli della storia del GdR. Spero che articolare i loro valori mettendoli in relazione con il quadro più grande li incoraggi a sviluppare la cultura OC in modi interessanti e robusti, allontanandosi al contempo da un’arrogante pretesa di universalità della loro visione. Spero anche che questa tassonomia aiuti le persone a valutare le differenze tra le culture e gli stili e ad orientarsi tra di esse, anziché mettersi ripetutamente in vicoli ciechi ogni volta che salta fuori che le assunzioni di base sul gioco che uno sta utilizzando semplicemente non sono condivise dai suoi interlocutori. Sfortunatamente non posso rispondere ai commenti sul blog direttamente, quindi se qualcuno lascerà commenti o domande su questa tassonomia le collezionerò e risponderò con un altro post. Link all'articolo originale: https://retiredadventurer.blogspot.com/2021/04/six-cultures-of-play.html Visualizza tutto articolo
-
Sei Culture del Gioco di Ruolo
Articolo di John B. del 06 Aprile 2021, dal blog The Retired Adventurer In questo post presenterò la tassonomia delle sei principali culture di gioco, insieme a qualche nota sulle loro origini storiche. Lo faccio sia per aiutare le persone appartenenti a queste diverse culture di gioco a comprendere meglio i valori della propria, sia per incoraggiare una discussione interculturale più densa e produttiva. Sono almeno sei le culture di gioco principali che sono emerse nella storia dell’hobby del GdR. Potrebbero essercene di più: la mia analisi si concentra essenzialmente su quelle di lingua inglese, benché almeno tre di loro abbiano una presenza non anglofona significativa. In aggiunta, esiste una proto-cultura che è esistita tra il 1970 e il 1976 prima che la suddivisione delle diverse culture iniziasse. Una cultura di gioco è un set di norme condivise (obiettivi, valori, tabù, etc.), considerazioni e tecniche che accomunano un gruppo di persone abbastanza vasto da far sì che non tutte siano in contatto diretto tra loro (chiamiamolo community). Le culture di gioco sono trasmesse attraverso una varietà di canali: dai libri alle avventure, passando per l’insegnamento di un individuo ad un altro, fino agli articoli sulle riviste e agli spettacoli in streaming. Una cultura di gioco è vagamente simile a un network of practice, se il termine vi è familiare. Gli individui che hanno appreso una o più di queste culture sviluppano poi stili di gioco personali. Voglio precisare che, secondo me, parlare di giochi specifici come intrinsecamente associati a specifiche culture è fuorviante: i giochi possono essere giocati con vari stili diversi, anche in linea con i valori di culture differenti. È vero, tuttavia, che molti giochi contengono un testo che raccomanda di giocarli in un certo modo, in linea con una cultura particolare, o contengono elementi che esprimono l’adesione del creatore ai valori di quella cultura. Le Sei Culture 1 - Classica Il gioco Classico ruota attorno allo sviluppo progressivo del potere dei PG e delle sfide che essi affrontano, con regole che aiutano a mantenere le due cose grossomodo in proporzione tra loro, e a risolvere in modo “equo” le loro interazioni. Questo è esplicitato nei consigli ai dungeon master della Guida del DM di AD&D 1E, ma si ripresenta in diverse altre fonti; le più ovvie, probabilmente, sono i moduli da torneo, soprattutto quelli della Serie R distribuiti dalla RPGA nei suoi primi tre anni di attività, che evidenziano dei “reset” periodici tra le sezioni dell’avventura per assicurare un’esperienza “equa” ai giocatori, mentre passano da un tavolo da torneo all’altro a giocare tali sezioni. L’accento sul gioco come sfida porta a un sacco di avventure tra terre selvagge e labirinti tentacolari, e ricicla la medesima notazione anche per descrivere le città, a loro volta trattate come scenario di sfide. A un certo punto i PG diventano abbastanza potenti da comandare una signoria, e questo allarga ulteriormente la gamma delle sfide, permettendo di ingaggiare scontri di massa in stile wargame. Il punto del giocare, nella cultura Classica, non è il raccontare una storia (benché non sia un problema se ciò avviene), bensì affrontare sfide e minacce che gradualmente aumentano di importanza e di potenza, man mano che i PG salgono di livello. Una lunga campagna con una lenta progressione di potere dei PG, interrotta solo dall’occasionale morte, è una giocata ideale per la cultura Classica. Tutto questo nasce più o meno tra il 1976 e il 1977, quando Gygax passa, dalla sua idea iniziale di OD&D come un non-gioco (“non-game”), al tentare di stabilizzare l’esperienza di gioco. Inizia con la sua invettiva contro “Dungeons and Beavers” e altre deviazioni dal suo proprio stile in Strategic Review dell’Aprile 1976, quindi diventa un più ampio riassetto delle pubblicazioni della TSR dal 1977 in poi. Nello specifico, esse iniziano a fornire al pubblico esempi concreti di gioco (tra cui esempi di dungeon e scenari, inclusi interi moduli) e consigli specifici sulle procedure e i valori più appropriati per il gioco. Il riassetto ha inizio con la pubblicazione del Holmes Basic (1977) e di Lost Caverns of Tsojcanth (1977), per poi culminare in AD&D (1977-1979) e la serie BECMI scritta da Mentzer (1983-1986). La Judges Guild, la RPGA, Dragon Magazine e anche altri editori (ad esempio Mayfair Games) si allineano a questo approccio e diffondono i princìpi Classici, prima che Gygax e Mentzer abbandonino la TSR tra fine 1985 e inizio 1986. La Judges Guild perde la sua licenza di stampa per il materiale di D&D nel 1985, e i tornei RPGA si allontanano dal gioco Classico intorno al 1983. La maggioranza degli altri autori alla TSR si converte al Trad (vedi sotto) entro la metà degli anni ’80, perciò il supporto ufficiale per lo stile Classico inizia a prosciugarsi, benché diverse persone continuino ad adottarlo nel loro gioco. Il Classico resuscita nei primi anni 2000 quando gli irriducibili che hanno continuato a giocare in questa maniera usano Internet per ritrovarsi su forum come Dragonsfoot, Knights and Knaves Alehouse, e altri. Questo revival è parte delle ragioni che portano al rilascio di OSRIC (2006). NB: “Classico” è l’unica denominazione, in questa trattazione, a non essere un autonimo usato dai suoi stessi praticanti, sebbene Gus L. di All Dead Generations abbia molto in comune con le loro idee e definisca effettivamente il proprio stile con questa parola. Una stranezza della storia è che le persone che nei primi anni 2000 tentavano di revitalizzare il Classico sono spesso confluite nell’OSR, malgrado i due gruppi abbiano norme e valori distinti. Ha portato a un po’ di confusione il fatto che alcuni soggetti importanti (come Matt Finch) siano effettivamente passati dall’essere revivalisti del Classico all’essere tra i fondatori dell’OSR. Dato che entrambi i gruppi sono interessati al gioco incentrato sulla sfida, anche se hanno punti di vista diversi sul significato di tale termine, ci sono state fasi di intersezione e interazione produttiva tra loro (e anche un sacco di sciocchi litigi e derisioni: questa è la vita). Questa mescolanza di persone che hanno diverse culture di gioco, e che sembrano inizialmente far parte dello stesso movimento ma poi si rivelano interessate a cose diverse, è abbastanza comune: gli Story Game e il Nordic Larp sono passati attraverso un processo simile (lo vedremo tra breve). 2 - Trad (abbreviazione di Tradizionale) Anche se i suoi aderenti lo chiamano Trad, non dobbiamo pensare che sia il modo più vecchio di giocare di ruolo (non lo è). Il Trad non è ciò che facevano Gary e compagni: quello è il Classico. Piuttosto, è la reazione a quello che stavano facendo. Il Trad si basa sul concetto che l’obiettivo primario del giocare sia il narrare una storia emozionalmente soddisfacente, e che il DM è l’agente creativo primario che lo fa avvenire: costruendo il mondo, stabilendo tutti i dettagli della storia, interpretando gli antagonisti, il tutto principalmente seguendo i propri gusti e la propria visione personale. I PG possono contribuire, ma i loro contributi sono secondari come valore e autorità rispetto a quelli del DM. Se mai avete sentito qualcuno lamentarsi (o entusiasmarsi!) per giocate che erano come scorrere un romanzo fantasy, quello era Trad. Il Trad esalta un modo di giocare che produce esperienze comparabili ad altri mezzi di intrattenimento, come film, romanzi, televisione, mitologia eccetera, e i suoi valori spesso incoraggiano ad adottare tecniche derivanti da quei mezzi. Il Trad emerge nei tardi anni ’70, con un primo embrione concettuale nel gruppo di Dungeons and Beavers al Caletch, ma anche nel circolo di gioco di Tracy e Laura Hickman nello Utah. L’avvenimento fondante, per Tracy, a quanto pare è stato imbattersi in un vampiro in un dungeon e pensare che aveva davvero bisogno di una storia che spiegasse cosa ci facesse a vagare laggiù. Hickman ha scritto una serie di avventure nel 1980 (la serie del Night Verse) che tentava di introdurre più elementi narrativi, ma l’azienda che avrebbe dovuto pubblicarla è fallita. Quindi ha deciso di venderla alla TSR, che però disse che l’avrebbe acquistata solo se Hickman fosse andato a lavorare per loro. Perciò, nel 1982, lo ha fatto e nel giro di pochi anni le sue idee si sono diffuse nella compagnia fino a diventare la visione dominante del concetto di gioco di ruolo. La prima importante pubblicazione, al di fuori del circuito TSR, che articola la visione Trad è Call of Cthulhu di Sandy Petersen (1981), il quale spiega ai lettori che lo scopo del giocare è creare un’esperienza simile a una storia horror, e fornisce consigli specifici per farlo (come il “modello a cipolla”). I valori Trad si cristallizzano come una rilevante e distinta cultura di gioco in D&D con i moduli di Ravenloft (1983) e Dragonlance (1984) scritti da Hickman. La TSR pubblica Ravenloft in risposta al successo commerciale e di critica di Call of Cthulhu, e in tal modo vince dei premi e vende un sacco di copie. In pochi anni l’idea di “roleplaying, not rollplaying”, e l’importanza del Dungeon Master come creatore di una narrativa elaborata ed emozionalmente gratificante, prevalsero. Penso che la capacità di importare termini e idee da altre forme d’arte abbia probabilmente aiutato molto, perché rende il Trad accessibile a chiunque abbia frequentato qualche lezione di scienze umane all’Università. Il Trad fu la cultura di gioco dominante almeno dalla metà degli anni ’80 sino ai primi anni 2000, ed è tuttora uno stile molto comune. Per un esempio abbastanza ben strutturato nell’ambito dello stile Trad, da parte di qualcuno che è stato un autore autorevole per gli ultimi 15 anni circa, date un’occhiata al S. John Ross’s RPG Lexicon. Entrambi i prossimi due stili emergono in seguito a problemi con il Trad, soprattutto con l’esperienza di giocare Vampiri (che nell’aspirazione dei suoi autori voleva essere “il più Trad dei Trad”), ma scendere nei dettagli sarebbe troppo per questo articolo, quindi mi limito a menzionarlo e ci tornerò un’altra volta. 3 - Nordic Larp Anche questo è un autonimo. “Nordic” si riferisce all’origine e alla massa principale della base giocante, non a una vera limitazione geografica di qualche genere. “Larp” [acronimo di Live Action Role Playing, “gioco di ruolo dal vivo”, NdT] fa parte della designazione per ragioni che non mi sono chiare, visto che le sue idee sono nate nel gioco di ruolo da tavolo, e la sua filosofia e le sue aspirazioni sono realizzabili tanto nei GdR da tavolo quanto in quelli in costume. (Scriverlo come se non fosse un acronimo, quindi con solo l’iniziale in maiuscolo anziché tutte le lettere, è un’usanza del Nordic Larp, quindi in conformità con il principio di autonimia seguirò la stessa convenzione quando parlerò della cultura di gioco, anche se scriverò LARP quando mi riferirò all’attività del ruolare dal vivo.) Il Nordic Larp ruota attorno all’idea che lo scopo principale di un gioco di ruolo sia l’immersione in un’esperienza; in genere quella di un personaggio specifico, ma a volte in un’esperienza di altro tipo in cui giocatore e personaggio non sono nettamente distinti: il gruppo sperimentale Jeep spesso usa giochi astratti per influenzare direttamente il giocatore. Maggiore è il “bleed” che si riesce a creare tra un giocatore e il ruolo che ha nel gioco, e meglio è. Spesso il Nordic Larp comprende delle lunghe “sessioni” (simili a escursioni di un fine settimana) seguite da lunghi debrief in cui ognuno processa l’esperienza che ha avuto attraverso il suo personaggio. Inserire il personaggio all’interno di una storia più grande può essere un modo di produrre esperienze vivide e coinvolgenti, ma non è necessario e potrebbe perfino essere d’intralcio (specialmente se fatto male). I giocatori del Nordic Larp enfatizzano gli aspetti collaborativi, ma guardando più in profondità si vede che si tratta di un rifiuto dell’idea Trad di un singolo DM-autore che crea l’esperienza, e la collaborazione serve a migliorare l’immersione unificando maggiormente l’agency del giocatore e del personaggio. Penso che il termine LARP faccia venire in mente immagini di gente che fa cosplay fantasy, e a volte ci sono elementi del genere in certi giochi di Nordic Larp, ma in realtà credo che la tendenza sia stata quella di allontanarsi dai giochi del fantastico in favore di scenari e situazioni più vicini alla vita reale, dato che ciò permette di incorporare l’architettura moderna, la tecnologia e altri dettagli per facilitare l’immersione. La prima pubblicazione importante riguardo il Nordic Larp di cui sono a conoscenza è il molto timido Manifesto of the Turku School di Mike Pohjola nel 2000, e credo che la comunità originaria abbia dialogato con quella di The Forge, benché avessero ideali di gioco molto differenti. Da lì al 2005 si sono avuti gruppi come Jeep che hanno sviluppato queste idee, e nel 2010 la pubblicazione del libro Nordic Larp. Oggi c’è anche una wiki e un sito web ufficiale. Il Nordic Larp è la parte del gioco di ruolo che sembra beneficiare della quota maggiore di fondi per lo studio accademico. Non so bene perché, ma sospetto che abbia qualcosa a che fare con l’interesse a mercificare i concetti del LARP per creare esperienze immersive di intrattenimento per turisti nei mega-resort delle nazioni del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Non linkerò qui nessun individuo specifico connesso al Nordic Larp che lavora laggiù, per non rischiare di infangarlo, ma esistono (per favore, non attaccate nessuno nemmeno nei commenti). 4 - Story Game Di nuovo un autonimo. La maggior parte di coloro a cui non piacciono li chiama con termini come “giochi forgiti” o “giochi indie post-Forgia”, riferendosi al forum di GdR indie the Forge. Anche “GdR Indie” è stata una denominazione utilizzata, a un certo punto, ma non credo che fosse particolarmente azzeccata o edificante, ed evidentemente non lo credevano neanche gli aderenti a questa cultura, visto che l’hanno perlopiù abbandonata. Ecco un post di Across the Table che discute l’origine del termine “story game”. Il Big Model è notoriamente ostico da comprendere e la teoria post-forgita contiene un sacco di idee con cui sono in forte disaccordo, ma credo che un’onesta descrizione della loro posizione, che non usi la loro stessa terminologia, sia che l’esperienza di gioco ideale è quella che minimizza la dissonanza ludonarrativa. Un buon gioco ha una forte consonanza tra i desideri di chi lo gioca, le regole, e le dinamiche derivanti dalla loro interazione. Insieme, queste cose permettono alle persone di realizzare i loro desideri, quali che siano. Va evitata l’incoerenza (“incoherence”) perché da luogo a “zilch play” o “brain damage”, come lo ha chiamato Ron Edwards una volta. La comunità degli Story Game, va detto in suo favore, è disposta a essere molto radicale in termini di tecniche che realizzano questo scopo: sia le meccaniche che lo sviluppo di impostazioni (gli story gamers le chiamano spesso “Intenti Creativi” ovvero “Creative Agendas”) come il “narrativismo” hanno lo scopo di produrre consonanza ed evitare dissonanza su tutti i livelli che si possono prefigurare. Gli Story Game nascono con Ron Edwards nel 1999, quando scrive Il Sistema Conta e crea The Forge. Da lì al 2004 si hanno il Provisional Glossary e il Big Model, e un milione di discussioni su Internet in merito a cosa è o non è “narrativista”, a quanto brain damage stanno causando i GdR, eccetera. I forum veri e propri degli Story Game sono fondati nel 2006 come successori di The Forge. Nell’ultimo decennio il grosso dello sviluppo degli Story Game tende a orientarsi intorno ai sistemi Powered by the Apocalypse, basati su Apocalypse World di Vincent Baker. Se volete un grande esempio di qualcuno che applica le norme culturali degli Story Game ad un gioco che è stato scritto per essere giocato nel modo Trad, The Sacrament of Death di Eero Tuovien descrive le sue esperienze nel fare esattamente questo. 5 - OSR (“Old School Renaissance / Revival”) Sì, appare così tardi, nell’ordine cronologico. E sì, l’OSR non è il gioco Classico: è una reinvenzione romantica, non una catena di tradizione ininterrotta. L’OSR attinge al gioco basato sulla sfida, tipico della proto-cultura di D&D, e lo combina con un interesse all’agency dei PG, in particolare nella forma della capacità decisionale. L’obiettivo è un gioco dove le decisioni dei PG, specialmente quelle diegetiche, fanno da traino. Penso che lo possiate vedere in forma molto chiara nei consigli che ha dato Chris McDowall, sul suo blog, su come condurre Into the Odd ed Electric Bastionland. Un’osservazione importante che vorrei fare è la distinzione tra la sfida progressiva della cultura Classica e la sfida più variabile dell’OSR. L’OSR perlopiù non bada a cose come l’“equità” nel contesto dell’“equilibrio di gioco” (mentre Gygax lo faceva). La variabilità dell’agency dei giocatori attraverso una serie di decisioni è molto più interessante, per la maggior parte degli aderenti all’OSR, di quanto non lo sia per gli aderenti al Classico. L’OSR rifiuta espressamente la mediazione di autorità svolta da una struttura di regole preesistente, incoraggiando invece le interazioni diegetiche attraverso ciò che S. John Ross chiamerebbe “ephemeral resources” e “invisible rulebooks”, e che l’OSR chiama rispettivamente “giocare il mondo” (“playing the world”) e “abilità del giocatore” (“player skill”). Essenzialmente, se non si è vincolati dalle regole si può giocare con uno spazio di risorse più ampio, che può contribuire a inquadrare le sfumature dell’agency dei PG in modi potenzialmente molto precisi e dotati di grande finezza; questo permette di far fronteggiare ai giocatori una maggiore varietà di sfide da superare. Potrei scrivere un intero post solo sulle funzioni delle tabelle casuali, comunque si legano al punto della variabilità dell’agency: introducono sorprese e imprevedibilità, assicurando che l’agency cambi nel tempo. Tendo a far risalire l’inizio dell’OSR a poco dopo la pubblicazione di OSRIC (2006), che ha spalancato le porte alla possibilità di usare l’OGL per ripubblicare le meccaniche del vecchio D&D pre-3.x. Con questa nuova opzione, ci sono state persone che hanno solo voluto far rivivere AD&D 1e, e altre che invece hanno voluto usare i vecchi set di regole come piattaforma di lancio per le loro nuove creazioni. Nel 2007 c’è stato Labyrinth Lord, e la valanga è seguita in breve tempo. Gli esordi dell’OSR hanno avuto da Grognardia una visione ricostruita del passato rispetto a cui posizionarsi come eredi. Ci sono stati anche notevoli sviluppi intellettuali come i “diagrammi di Melan” per i dungeon e i pointcrawl di Chris Kutalik. Direi che tra il 2006 e, più o meno, il 2012 l’OSR ha organizzato le sue norme in un corpo di idee relativamente coerente sul modo di giocare considerato appropriato. 6 - OC / Neo-trad Questo è l’unico termine che non è pienamente autonimo, sebbene sia possibile aggiungere “OC” ad un post di ricerca per giocare online e reclutare così in modo ripetibile persone di questa cultura, quindi ci siamo abbastanza vicini. La chiamo anche Neo-trad, innanzitutto perché condivide molte delle norme della cultura Trad, e in secondo luogo perché penso che chi appartiene a questa cultura si creda parte del Trad. Talvolta potrete veder chiamare questo stile anche “moderno” (“the modern style”), in contrapposizione all’OSR. Ecco un esempio di qualcuno che lo chiama Neo-trad ed elabora una visione pura di questi stile (benché io non sia d’accordo con la lista di giochi che fornisce come esempi di Neo-trad alla fine dell’articolo). Su Reddit, l’OC è spesso chiamato “moderno”, in espressioni come “il modo moderno di giocare” o “i giochi moderni”. L’OC, di base, concorda con il Trad che lo scopo del gioco sia di raccontare una storia, ma riduce l’autorità del DM come creatore di quella storia ed esalta il ruolo dei giocatori come contributori e creatori. Il DM diventa un curatore e facilitatore che lavora principalmente con materiale fatto da altri: in pratica, gli autori/editori e i giocatori. La cultura OC ha un concetto diverso di cosa sia una “storia”: si focalizza sulle aspirazioni e gli interessi dei giocatori, e nella loro realizzazione come miglior modo di farli “divertire”. Il focus sul realizzare le aspirazioni dei giocatori è ciò che permette al mago di 20° livello, che lancia sciame di meteore per annichilire un nemico, e alla gente che usa D&D 5e per giocare a gestire il proprio ristorante, di coesistere nella stessa cultura comune. Questa cultura è chiamata talvolta, in modo dispregiativo, “Tirannia del Divertimento” (“Tyranny of Fun”, un termine coniato dall’OSR) a causa del suo concentrarsi sulla gratificazione immediata, rispetto ad altri stili di gioco. Il termine “OC” sta per “Personaggio Originale” (“Original Character”) e viene dal gioco di ruolo fandom online in forma libera (“freeform”) che era popolare su piattaforme come Livejournal nei primi anni 2000. OC è quando inserisci un personaggio originale in un gioco di ruolo ambientato nell’universo di Harry Potter, invece che giocare come Harold the Cop in persona. Nonostante fossero in forma libera, ciò senza tiri di dado né Dungeon Master, questi giochi avevano spesso estesi complessi di regole in merito a quali affermazioni si potessero introdurre nella giocata, con giocatori che si appellavano a tali regole l’uno contro l’altro per risolvere le dispute. Per le generazioni più giovani di giocatori di ruolo, giochi di questo tipo sono stati spesso il canale che li ha introdotti all’hobby. Penso che il GdR OC sia emerso durante l’era 3.x (2000-2008), probabilmente con la crescita di Living Greyhawk Core Adventures, e dell’apparato del gioco organizzato e più in generale del gioco online con estranei. Il gioco organizzato ha finito per ridurre il potere del DM in favore dell’autorità dei testi di regole, degli editori, degli amministratori e, assolutamente, dei giocatori. Dal momento che i DM possono cambiare da un’avventura all’altra mentre i personaggi giocanti rimangono, questi ultimi diventano più importanti, con le regole standard che garantiscono la compatibilità attraverso le diverse giocate. La discrezionalità e inventiva del DM diventano un ostacolo a questa intercompatibilità, quindi vengono svalutate. È da qui che proviene l’enfasi su “RAW” e sull’usare solo materiale ufficiale (ma anche l’idea che se qualcosa è pubblicato dovrebbe essere disponibile al tavolo): sono cose che erodono il potere del DM e trasferiscono quel potere nelle mani dei PG. Queste norme sono state rinforzate e diffuse dai forum di “ottimizzazione del personaggio”, che si affidavano solamente al testo e criticavano formalmente il “DM fiat”, e dai character builder ufficiali di D&D e di altri giochi. I moduli, che limitano in modo importante la discrezione del DM per fornire un set costante di condizioni ai giocatori, sono un altro importante elemento a sostegno di questo stile. Lo stile OC è reso, inoltre, particolarmente popolare dai giochi in streaming online come Critical Role, dato che, se fatto bene, tende a produrre giocate abbastanza facili da guardare come se fossero show televisivi. I personaggi di queste serie diventano figure di ispirazione con cui la fanbase sviluppa un rapporto para-sociale ("parasocial interaction"), e al cui fianco esulta quando realizzano il proprio “arco”. Niente quiz né etichette Quando ho presentato per la prima volta queste categorie su un forum, qualcuno scherzando ha detto che avrei dovuto creare un quiz che permettesse alle persone di determinare a quale cultura tra queste appartengono, ma preferisco di no. Sinceramente, penso che la maggior parte dei singoli giocatori o gruppi siano un amalgama di culture, che si realizza in uno stile individuale. Le culture di gioco sono più simili a paradigmi: hanno il loro punto di coesione nei valori e nell’idea di cosa potrebbe costituire un “gioco ideale” (più formalmente, condividono teloi di gioco). Essere parte di una cultura di gioco è, in un certo senso, la capacità di riconoscere quando qualcun altro sta giocando in accordo con un set di valori che avete in comune. Il mio scopo principale nella tassonomia qui esposta è aiutare le persone a capire meglio che esistono diversi paradigmi di gioco, che considerano positive cose diverse, benché possano essere combinati insieme (con una varietà di risultati divertenti) in situazioni concrete. Dubito che questa lista sia esaustiva, e probabimente ci sono culture che ho trascurato, nonché altre che devono ancora emergere. Lo scopo della lista è soprattutto di illustrare brevemente che ci sono molti diversi valori di gioco, e di discutere la logica che anima alcuni tra i più conosciuti. L’intento originario di questa trattazione era parlare del gioco di ruolo OC, perché penso che sia quello meno analizzato in genere, e che molte analisi siano relativamente dispregiative (tra cui la “tirannia del divertimento”, vedi sopra). Inoltre tende ad esserci un sacco di confusione tra persone che operano nel paradigma OC e in quello Trad, dato che spesso usano gli stessi termini per riferirsi a cosa molto diverse. In aggiunta, senza voler essere antipatico, il gioco di ruolo OC tende ad essere il paradigma di default dei nuovi giocatori che si avvicinano all’hobby attraverso lo streaming, di conseguenza contiene la più ampia quota di persone inesperte e inconsapevoli della storia del GdR. Spero che articolare i loro valori mettendoli in relazione con il quadro più grande li incoraggi a sviluppare la cultura OC in modi interessanti e robusti, allontanandosi al contempo da un’arrogante pretesa di universalità della loro visione. Spero anche che questa tassonomia aiuti le persone a valutare le differenze tra le culture e gli stili e ad orientarsi tra di esse, anziché mettersi ripetutamente in vicoli ciechi ogni volta che salta fuori che le assunzioni di base sul gioco che uno sta utilizzando semplicemente non sono condivise dai suoi interlocutori. Sfortunatamente non posso rispondere ai commenti sul blog direttamente, quindi se qualcuno lascerà commenti o domande su questa tassonomia le collezionerò e risponderò con un altro post. Link all'articolo originale: https://retiredadventurer.blogspot.com/2021/04/six-cultures-of-play.html
-
Un primo sguardo a Mordenkainen Presents: Monsters of the Multiverse
La cosa divertente è che, in altri contesti, sono i cultori del D&D Vecchia Scuola, il "vero" D&D delle origini, a esaltare come un valore il fatto che il gioco incentivi a trovare strade alternative al combattimento, e che questo rimanga perlopiù un'ultima risorsa. 🙂
-
Ambientazione "elementale"
Per fulmine sono d'accordo con quello che hanno detto tutti, la cosa più a tema sarebbe una civiltà basata su tecnologia, innovazione, costrutti, alchimia, magari armi da fuoco. Se questa roba vagamente "steampunk" ti stona troppo, considera invece una civiltà barbarica di stampo pseudo-vichingo: il "dio del fulmine" a capo del pantheon, le tempeste marittime, le scorrerie mordi-e-fuggi. Per ghiaccio quoto @Thaeris in toto: mi piace l'idea di una società molto tradizionalista e conservatrice. Magari potresti aggiungere che la cultura scoraggia qualsiasi espressione emotiva (insomma, incoraggia la... "freddezza"). Per tuono puoi usare la cultura pseudo-vichinga che dicevo sopra (in effetti ci sono molti punti di contatto ineludibili tra tuono e fulmine), ma ti faccio un'altra proposta: una cultura estremamente estroversa. Naturalmente va bene incorporare il suono in sé (grande diffusione della musica, tamburi, segnali sonori eccetera), ma mi è sembrato che per tutti gli altri elementi tu cercassi di interpretare il concetto in modo più filosofico che letterale. Direi che il suono richiama il farsi notare, la vivacità, il clamore. Immagino una società in cui c'è pochissima riservatezza, ogni cosa è esposta, gli abiti sono appariscenti, si dicono le cose apertamente senza freni, eccetera. Dal punto di vista politico può essere molto caotica, soggetta a continui rovesci e mutamenti; magari addirittura con grandi agorà popolari e discussioni pubbliche su ogni cosa.
-
Posti liberi in campagna lunga sperimentale, difficile
Ciao, secondo me, molto poco 5.0 😅... ma dipende da quali elementi si ritengono caratteristici dell'edizione potenzialmente Scrivimi pure in privato per saperne di più, così ti mando anche il contatto Discord. Grazie!
-
Reclutamento 'apprendisti' D&D
Ciao, qualche anno fa ho provato a fare esattamente questo: un'avventura di D&D con giocatori tutti assolutamente novizi. C'è da dire che era un'avventura di più sessioni (3 o 4, non ricordo), non una one-shot. Ma c'è anche da dire che usavo un regolamento mio personale, decisamente più complicato di D&D 5e da molti punti di vista. L'approccio che ho deciso di usare è stato questo: personaggi pregenerati da me (con qualche indicazione di massima da parte loro, se volevano), e assolutamente nessuna spiegazione sulle regole, abbiamo iniziato direttamente a giocare, dopo una breve chiacchierata conoscitiva per rompere il ghiaccio. Ho spiegato le regole piano piano, man mano che venivano usate, e sempre in modo molto essenziale. E' andata così bene che dopo quell'avventura hanno voluto andare avanti e ne è nata una campagna lunga che continua tuttora. Mi sento di raccomandare questo approccio con tutto il cuore. Seconda cosa. Mi è capitato di recente di partecipare, come giocatore, a un'avventura autoconclusiva (quella, sì, one-shot, di poche ore) con due giocatori totalmente novizi; mi hanno chiesto di fare da "tappabuchi" e ho accettato molto volentieri perché ero curioso di vedere come andava. Un giorno la racconterò sul mio blog, perché è stata molto istruttiva. In breve: i primi 40 - 45 minuti li abbiamo passati con il master che introduceva i nostri PG uno alla volta e ci faceva "ruolare" delle scenette tra di noi, che "giustificassero" la nostra collaborazione e presenza sulla scena. Nel seguito, a brevi scene in cui si agiva (tutte scene a senso unico, railroad molto deciso, ma questo è il male minore, in una one-shot introduttiva ci può anche stare) si sono alternate scene molto lunghe con il master che interpretava compiaciuto i vari PNG (dando prova di notevoli doti attoriali, questo gli va concesso) ed esortava anche noi a fare altrettanto. Morale: non sono ancora riuscito a parlare con i due nuovi che sono stati introdotti quella volta (mi piacerebbe molto, ma ho perso i contatti); ma penso che si siano fatti l'idea che l'essenza di D&D, il pilastro portante, sia tutto quell'intrattenersi a vicenda "recitando" in-character, facendo le voci, gesticolando, riscuotendo approvazione dagli altri per la propria performance teatrale. E poi ci siano anche dei dadi e dei numeri in qualche caso, quando proprio ci vuole, come aggiunta. Siccome io sono convinto che l'essenza e pilastro portante di D&D sia invece prendere delle decisioni significative e affrontarne le conseguenze, la mia raccomandazione fortissima sarebbe: non farti tentare da un'avventura piena di "trama" e di PNG interessanti e di relazioni sociali; usa un dungeon. Il dungeon è l'ambiente nativo di D&D, è il suo elemento, è pieno di decisioni da prendere, mette tutto nelle mani dei giocatori. E, per l'amor di Pelor, inizia con i PG che sono già insieme e già sulla porta del dungeon. Fai tre o quattro righe di discorso introduttivo per giustificare la loro presenza e dar loro un obiettivo da raggiungere (dentro il dungeon), quindi passa all'azione. In bocca al lupo!
-
Elezioni in Città - come coinvolgere i PG
Mi sembra un'ottima idea
-
Incantesimi oscuri
Allora forse potresti informarti in-game su quali magie sono temute, vietate o biasimate a Tulutia. Che è un modo gentile per chiedere al tuo DM di indicarti delle magie e di ricordarsi di far loro avere quell'effetto una volta che sarai là 😉
-
Elezioni in Città - come coinvolgere i PG
Ah, che bello! La 2 è un mio sogno nel cassetto da lungo tempo. Ancora non ho mai trovato l'occasione. Sì, raccomanderei decisamente la 2: nel senso, se c'è un'elezione, è verosimile che far eleggere qualcuno non sia automatico; quello che possono fare i PG è cercare di parlare/agire/brigare in favore dei candidati per aiutarli a raggiungere il traguardo. Il tempo da dedicare alla cosa dipende, ovviamente, dai gusti tuoi e dei giocatori: anzi, chiedere direttamente a loro quanto spazio vogliono dare, in gioco, a questo compito può essere l'opzione vincente. A seconda di quanto tempo scegliete di dedicarvi, puoi risolverla (in ordine crescente di tempo): con un singolo tiro di dado (diplomazia o simili, stabilendo una CD opportuna); con una cosiddetta skill challenge, come ti è stato suggerito da @Minsc (varie prove, anche diverse, con la necessità di ottenere almeno X successi prima che si verifichino Y fallimenti); come una vera e propria quest, con diverse personalità da convincere (o corrompere), ognuna con le sue particolarità, e varie gradazioni di successo a seconda di quante ne convincono (più ne convincono, più probabile sarà l'elezione dei loro prediletti).
-
Posti liberi in campagna lunga sperimentale, difficile
Ciao a tutti, ho un paio di posti da giocatore liberi in una (anzi, due: ma si somigliano molto) campagne che ho in corso. Ho messo d&d 5e perché era (forse) l'opzione più vicina ma in realtà si tratta di una versione di D&D sperimentale. Chi, quando e come Su Discord, bot per i dadi, occasionale condivisione dello schermo ma perlopiù interazione solo verbale. Solo audio, niente telecamera. La sera dopo cena, preferibilmente in giorni infrasettimanali. Circa 3 sessioni al mese di media. Sistema di gioco È casalingo e altamente sperimentale. Un alpha test. È D&D nella sostanza, usa il d20 system, e deriva alla lontana dalla 3.5, ma ha accumulato un sacco di "mutazioni genetiche" negli anni e le ultime sono piuttosto pesanti. Essendo un esperimento ha continuamente bug fix e revisioni (a cui il vostro contributo è benvenuto ma non obbligatorio). Per me le regole si imparano giocando. Non vi ammorberò con un lungo training pre-gioco e non vi obbligherò a leggere neanche una pagina di manuale. Ambientazione, campagna e stile di gioco L'ambientazione è post apocalittica ma con tecnologia medievale. Il mondo è desertificato, con scarse risorse e pochi insediamenti che lottano per la sopravvivenza, ancorati alle poche fonti d'acqua. Le razze disponibili sono umano, orco, mezzorco, nano e gnomo. C'è una forte prevalenza di dungeon crawl ed esplorazione. Tuttavia c'è anche un obiettivo comune del gruppo sul lungo termine, un obiettivo al quale vi chiederò di aderire anche voi. Aspettative Farò una "sessione zero a quattr'occhi" con chi si candida, per conoscerci meglio e parlare di gusti e aspettative sul gioco. Mi aspetto poche cose fondamentali: serietà (è una campagna lunga, un impegno almeno a medio termine), pazienza (è un alpha test, ci saranno molti cambiamenti in corsa e bug da risolvere), e collaborazione (con gli altri giocatori, per creare un gruppo sereno e divertirsi insieme senza prevaricarsi). Ho avuto più di una delusione da parte di giocatori reclutati online. Ma anche qualche sorpresa positiva, quindi... speriamo bene.
-
Incantesimi oscuri
L'associazione tra "oscurità" e "male" ovviamente dipende dall'ambientazione, nel nostro mondo è tipica di molte religioni ma non per tutte è così (in effetti due mie campagne si svolgono in un mondo in cui succede quasi il contrario 😅). Però, supponendo (come credo) che per magie "oscure" tu intenda "magie che ti fanno apparire cattivo, corrotto", ho una domanda: quello che ti preme è che (a causa delle magie che ha) il personaggio sia percepito come "oscuro" dagli altri personaggi, dai PNG, oppure ti preme che sia percepito come "oscuro" da voi giocatori?
-
Cambiamenti alla Lore in D&D 5E
Capisco quello che dici ed è valido, @Lord Danarc, ma il punto è che "tutti gli elfi" / "tutto D&D" / "tutto il multiverso" sono espressioni molto ambigue che si fondano sulla precondizione (non vera, secondo me) che D&D non sia innanzitutto un sistema, bensì un sistema integrato indissolubilmente con un'ambientazione (mondo, universo o multiverso che sia). Lo so che rischio di diventare un vecchio rompitasche monotono, e infatti dopo questo commento la smetto di insistere sul punto, prometto. D&D è un motore di gioco che si può applicare a infinite ambientazioni. E con "infinite ambientazioni" non intendo "infiniti mondi paralleli dentro un singolo multiverso che è la Grande Ruota": intendo anche quello, certo, ma anche infiniti multiversi diversi dalla Grande Ruota, o infinite ambientazioni che non hanno nulla a che fare con la Grande Ruota, la quale è solo un'altra ambientazione, una delle tante possibili. Dal mio punto di vista, tutti i riferimenti di lore che si trovano nei manuali di D&D e che vanno al di là del puro e semplice motore di gioco sono da intendersi semplicemente come esempi di applicazione di quel motore, in specifiche ambientazioni. Vale, ad esempio, per la razza degli elfi. È bene che ci siano, perché il sistema "disincarnato", nel vuoto, senza alcun esempio concreto e senza alcun materiale pronto da giocare, sarebbe un prodotto molto più scadente. Non esiste e non esisterà mai una lore comune che riguarda tutti gli elfi di qualsiasi ambientazione giocabile con D&D. In una giocata ambientata nella Terra di Mezzo (di cui esistono adattamenti a varie edizioni di D&D) spero concorderemo che per gli elfi locali non ci sarà mai stata nessuna Guerra delle Corone, a meno che non mi sia sfuggita tra una pagina e l'altra del Silmarillion. In una giocata ambientata in Brancalonia gli elfi magari neppure esistono. Nel mio Grande Nulla sono ritenuti estinti. A Westeros ci sono solo gli umani. Ovviamente nessuno mi può impedire di giocare, al mio tavolo, un multiverso che connette la Terra di Mezzo e i Forgotten Realms, con i drow seguaci di Lolth che attraverso portali dimensionali invadono in massa Gran Burrone. Se lo faccio, sto definendo una nuova ambientazione, specifica, nella quale c'è un multiverso in cui quei due mondi sono connessi. È possibile, non è vietato. Ma è un'ambientazione tra le tante. Greyhawk è un'ambientazione tra le tante. I FR sono un'ambientazione tra le tante. Un multiverso che comprenda Greyhawk e FR è a sua volta, esso stesso, un'ambientazione tra le tante. Una possibilità. Un'ipotesi. Un esempio. Al di fuori del gioco organizzato di fatto ogni tavolo, ogni giocata, si svolge in un'ambientazione tutta sua. Insomma, l'editore di D&D pubblica due cose diverse: il motore di gioco, e una grande varietà di esempi di "messa in pratica" di quel motore in vari mondi fantasy (compresi esempi, tipo la Grande Ruota, di come si potrebbero combinare quei vari mondi fantasy tra loro se si vuole). E come il motore è cambiato molto da un'edizione all'altra, anche quegli esempi cambiano di continuo, in un modo che non sempre è consistente. Basta dare un'occhiata ai mille cambiamenti che hanno avuto, negli anni, mostri iconici come il tarrasque, i demoni, i diavoli, i giganti, gli stessi draghi. Il tomo che descrive la storia degli elfi e la Guerra delle Corone non fa altro che descrivere un esempio di possibili elfi, e di possibili guerre e scismi tra gli elfi, in una varietà di possibili mondi fantasy. È un esempio. Se oggi vengono pubblicati esempi diversi da quello, anche in contraddizione con quello, non ci vedo niente di male. Siccome incontro sempre più spesso (soprattutto tra i giovani, nelle chat eccetera) persone che trattano D&D come un'ambientazione monolitica (in genere coincidente con i FR), che parlano della "lore di D&D" come se fosse unica, e che mi fanno domande alle quali nel 90% dei casi la risposta corretta è un bel "dipende dall'ambientazione", troverei molto salutare, lo dico a titolo personale, se la community facesse uno sforzo per abbandonare questa concezione monolitica, facendo pace col fatto che le ambientazioni e le lore di D&D sono infinite e ogni gruppo se le aggiusta come vuole, usando ciò che trova nei manuali semplicemente come uno spunto, una linea-guida esemplificativa non vincolante.
-
Le dimensioni contano?
Come hanno detto altri, non credo che faccia differenza. Cioè, è un diverso modo di gestire le cose, ma dal punto di vista quantitativo è equivalente: fintanto che quello che prepari viene effettivamente usato nelle tue avventure, la preparazione richiesta da N avventure sarà grossomodo la stessa, sia se sono sparse su un continente sia se sono concentrate in un unico luogo; si tratterà solo di preparare cose diverse. Ben altro, ovviamente, è il caso di chi prepara ambientazioni ricchissime di vastissimi territori, quando poi la maggior parte di essi non sarà affatto toccata dalle giocate: a quel punto le cose cambiano.
-
Combattimento senza griglia
Se ho capito bene, vuoi un sistema con un riferimento oggettivo (non, cioè, affidato alla mente del master e alla mera immaginazione dei partecipanti, perché temi che porterebbe a discussioni), ma più semplice della tradizionale griglia a caselle di 1 metro e mezzo. In tal caso la mia proposta sarebbe: Usa una griglia grossolana con "caselloni" molto grossi (da 6 o 9 metri di lato), e delle pedine (non necessariamente miniature elaborate, eh, vanno bene anche bottoni o tappi di bottiglia, purché ognuno riconosca il suo). La posizione precisa delle pedine in un "casellone" non è rilevante, si presume che possano essere ovunque al suo interno. Se due pedine sono "ingaggiate" tra loro, cioè proprio a distanza tale da stare in mischia, mettetele a contatto l'una con l'altra, cioè in modo che si tocchino. Altrimenti, no. Se A ingaggia B e C ingaggia B, anche A e C sono considerati ingaggiati tra loro. Le pedine nello stesso "casellone" che non si toccano sono "vicine" tra loro. Quelle dei caselloni adiacenti sono invece "lontane". Con 1 movimento puoi fare una delle seguenti cose: andare a ingaggiare un'altra pedina del "casellone" in cui ti trovi disingaggiarti, rimanendo nello stesso "casellone" ma non più ingaggiato entrambe le precedenti (disingaggiarti da uno per ingaggiare un altro) solo se non sei ingaggiato, spostarti da un "casellone" a un altro adiacente, senza ingaggiare nessuno nel nuovo "casellone" Le armi a distanza a corta gittata (come pugnali e simili) sono efficaci su bersagli "vicini", hanno svantaggio su quelli "lontani". Le armi a distanza più efficaci, come archi o balestre, avranno invece una gittata corta di 1 o più "caselloni" e una gittata lunga del doppio. La portata degli incantesimi viene ridefinita esprimendola in "caselloni" anziché in metri, con un minimo di 0 che indica: "nello stesso casellone". Ovviamente, gli incantesimi a contatto sono ancora a contatto, e in tal caso richiedono di essere ingaggiati.
-
Combattimento senza griglia
È interessante osservare che qualunque insieme di regole che tenga conto, in modo formale, della posizione reciproca delle varie cose e creature di fatto è una griglia. Si può, questo sì, modificare la risoluzione della griglia, per esempio procedendo a multipli di (circa) 9 metri anziché a multipli di 1,5 metri. Ci può stare: ognuno ha la risoluzione con cui si trova meglio, un eccesso di precisione può causare problemi tanto quanto un eccesso di approssimazione, a seconda dello stile di gioco. E si può evitare di ricorrere a un ausilio visivo schematico sul tavolo, oppure ricorrere a qualcosa (che so, dei post-it) di sostanzialmente diverso dalle tradizionali miniature. Ma si sta comunque formalizzando la posizione specifica delle cose sul campo di battaglia, con delle regole e delle "unità di misura" dedicate. È una griglia diversa dal solito, ma sempre una griglia 🙂
-
Cambiamenti alla Lore in D&D 5E
Non ho bisogno di "farmene una ragione" perché sono pienamente d'accordo, stavo dicendo esattamente la stessa cosa. Chiedo venia se sono andato troppo off-topic, ma la discussione era iniziata da discorsi che suggerivano che, siccome tutti i mondi di tutti gli utenti di D&D sono collegati (non "se vogliamo così limitatamente al nostro tavolo": lo sono di fatto), lo scisma tra gli elfi oscuri e i non-oscuri è avvenuto nello stesso modo in tutti i mondi e ogni cambio della lore che lo riguarda impatta automaticamente tutti i mondi. Mentre, siccome ognuno al proprio tavolo fa il cavolo che gli pare, qualunque cosa scritta sugli elfi oscuri di una certa ambientazione impatta solo quell'ambientazione lì, come stavo dicendo.
-
Cambiamenti alla Lore in D&D 5E
Non ho mai detto che stesse su un manuale legato a una specifica ambientazione. Ho detto che di fatto è una specifica ambientazione perché qualunque mondo di fantasia, o insieme di mondi di fantasia, o insieme di insiemi di mondi di fantasia, è una specifica ambientazione. E' velleitario pretendere che ne esista una superiore a tutte le altre e che comprende tutte le altre, anche quelle che non vogliono essere incluse, anche la mia. Non è questione di copyright, è semplicemente ragionevolezza.
-
Cambiamenti alla Lore in D&D 5E
La "nostra" Terra raggiungibile dai FR con un portale è comunque un mondo di fantasia di una specifica ambientazione di fantasia. Ci sono un sacco di opere di fantasia (fumetti, ad esempio) ambientate sulla "nostra" Terra, e questo non implica che sia lo stesso mondo e che i personaggi possano incontrarsi. Anche quello postato da @Nyxator non è altro che lo schema costitutivo di una specifica ambientazione. Un'ambientazione di fantasia che prevede l'esistenza di molti mondi collegati, alcuni imprecisati e potenzialmente da definire, magari infiniti. Ma rimane, tutta insieme, una specifica ambientazione di fantasia, una tra le tante. Si può benissimo immaginare un'infinità di altre ambientazioni di fantasia che non hanno nulla a che fare con quella struttura planare, non la rispettano, e non vi sono incluse. Io stesso, nel mio piccolo, ne ho scritte e usate diverse.
-
Combattimento senza griglia
Oltre all'articolo che ti ha già linkato @Grimorio, aggiungo anche questo di The Angry GM (è il primo di una serie): https://theangrygm.com/fighting-with-your-voice-1/
-
Cambiamenti alla Lore in D&D 5E
Questa è un'altra comune fonte di confusione. Per alcune persone, il termine "Multiverso" si riferisce a "l'insieme di ogni possibile mondo e ogni possibile ambientazione di gioco", come se ci fosse una macro-ambientazione che sovrasta e comprende, e collega tra loro, tutte le ambientazioni singole Credo anch'io che non vada inteso così: qualunque Multiverso di D&D sarà sempre e comunque "un" Multiverso, e costituirà a sua volta un'ambientazione, che non comprende necessariamente qualsiasi altra. Anche se gli autori decidono che esiste un unico macro-spazio, chiamato "Multiverso", in cui "si trovano" sia Greyhawk che i Forgotten Realms, per esempio, significa solo che si stanno inventando un collegamento tra quelle due specifiche ambientazioni; ma può tranquillamente esistere un altro Multiverso (tipo: il "mio" Multiverso) che non ha assolutamente alcun legame né con Greyhawk né con i Forgotten Realms, e in cui le razze funzionano in modo completamente diverso. Per esempio, se gioco una campagna ambientata nella Terra di Mezzo di Tolkien, o nel Westeros di Martin così caro a @bobon123 (😉), credo sia chiaro a tutti che non sto "aggiungendo" la Terra di Mezzo, o Westeros, al singolo "Multiverso di D&D" per cui un bel giorno potrebbe arrivarmi Elminster o Mordenkainen a bussare alla porta di Bilbo. Lo stesso vale per molte ambientazioni casalinghe. Purtroppo il concetto di Multiverso come "il" (solo e unico e unificante) Multiverso di D&D perpetua la concezione, che io trovo negativa, di D&D come di un mondo, uno scenario, con un'unica e specifica "lore", anziché quella, per me più apprezzabile, di D&D come di un motore di gioco che ognuno può adattare all'ambientazione fantasy che ritiene più adeguata (ovviamente entro certi limiti).
-
Cambiamenti alla Lore in D&D 5E
Il punto da non dimenticare è che con 5e i FR sono diventati l'ambientazione di default dei manuali base di D&D, a differenza di quanto accadeva nelle edizioni precedenti. Non è più un'ambientazione come le altre, seppur famosa: è l'ambientazione in cui si suppone, nei manuali, che D&D venga giocato salvo indicazione contraria; ci si aspetta che diventi il punto di partenza per tutti i giocatori e gruppi nuovi. Questo è uno dei motivi (secondo me, il principale motivo) dietro la gran quantità di cambiamenti e revisioni che vanno nella direzione di espanderla e, secondo qualcuno, "annacquarla" (io non ne ho idea perché non ho mai amato i FR e non li ho mai giocati). Fintanto che un'ambientazione è una delle tante, quindi presentata esplicitamente come un'opzione da adottare, può essere anche molto particolare e molto specifica, con molti vincoli rigidi. Ma l'ambientazione "zero", quella di default, deve giocoforza essere "un mischione" estremamente variegato, perché deve poter accogliere, potenzialmente, le giocate di (quasi) qualunque gruppo.








