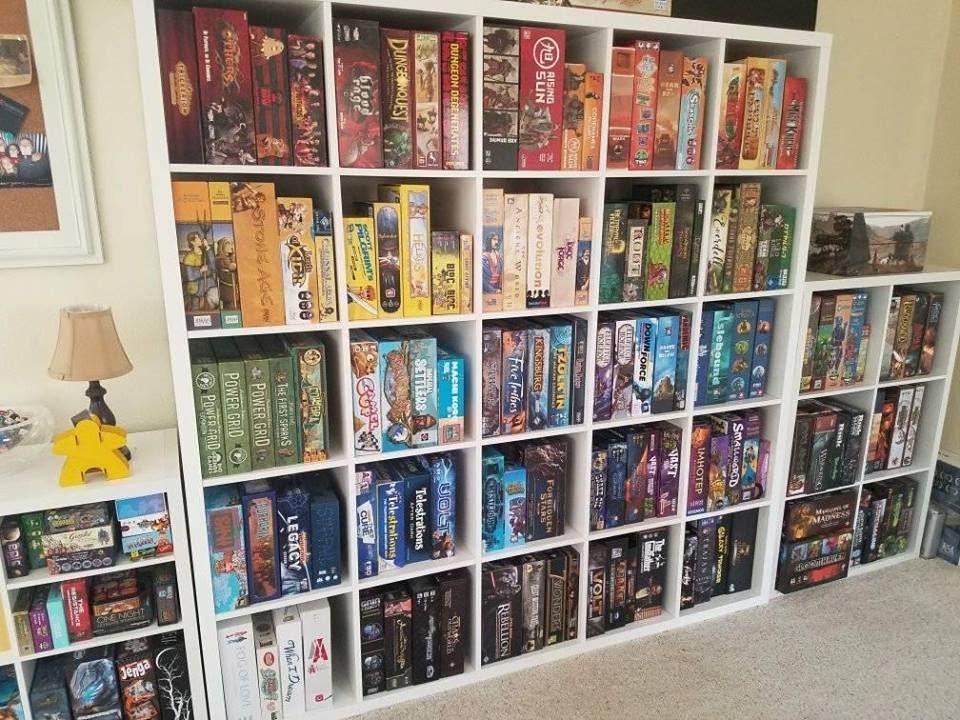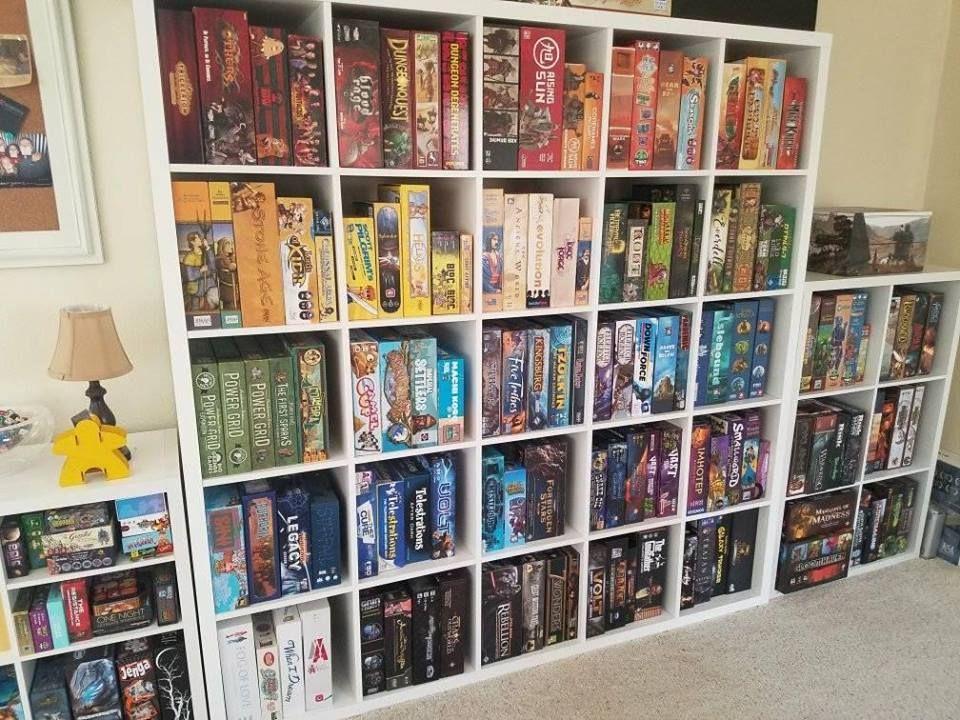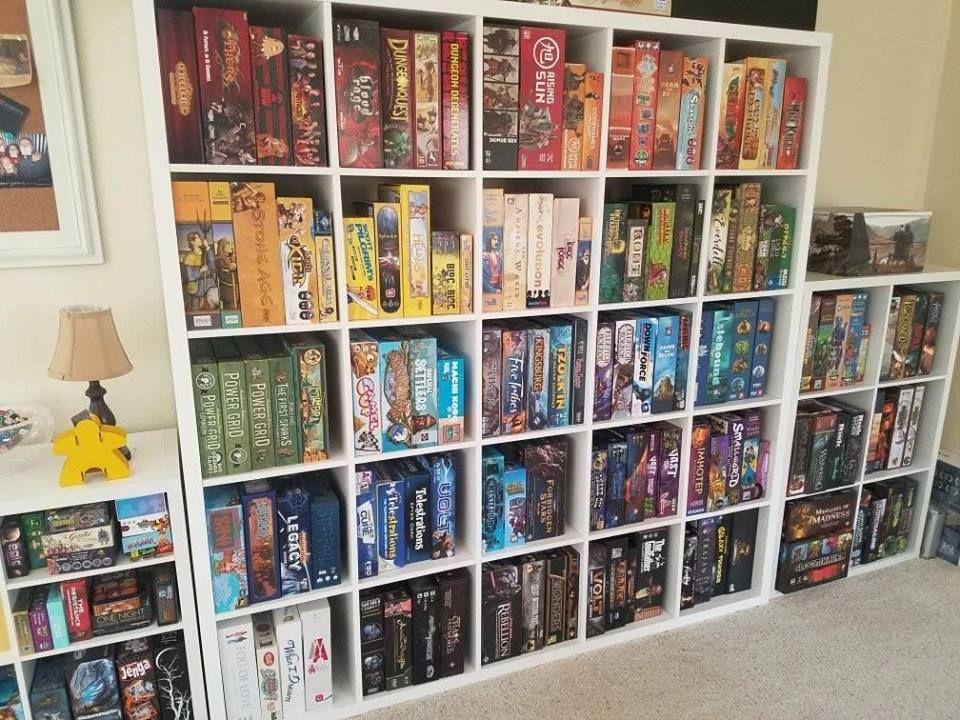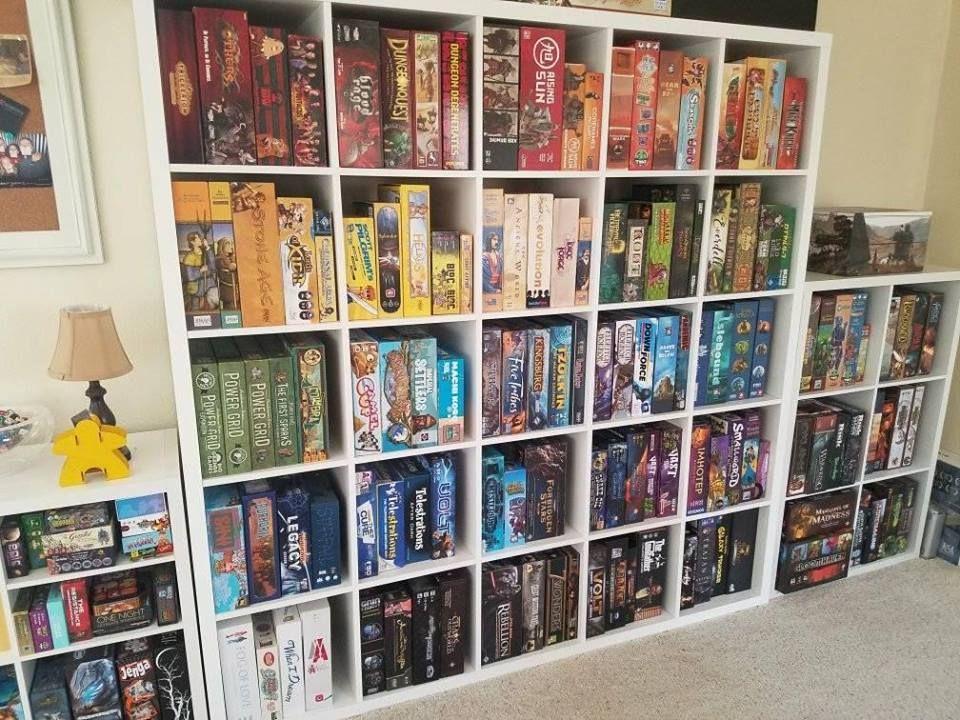Tutti i contenuti pubblicati da NicoRobs
-
Le strutture dei giochi - Parte 4: Il combattimento
Articolo di The Alexandrian del 09 Aprile 2012 Le Strutture dei Giochi - Parte 1 Le Strutture dei Giochi - Parte 2 Le Strutture dei Giochi - Parte 3 Il successo del dungeoncrawl è strettamente collegato a quello del sistema di combattimento tradizionale nei giochi di ruolo. Nonostante le meccaniche individuali possano variare, praticamente ogni gioco di ruolo utilizza una struttura di gioco base per i combattimenti che deriva da D&D: il combattimento è diviso in turni in cui ognuno ha la possibilità di fare un'azione (o più azioni). Di solito il combattimento è reso più definito da un qualche tipo di sistema di iniziativa, così da riuscire facilmente a rispondere alla domanda: “Chi è il prossimo?” Se tutto ciò suona come la rigida struttura di un gioco da tavolo o di carte, è perché effettivamente è così: il sistema di combattimento del GdR medio, derivando da quello dei giochi da tavolo di simulazione di guerra, risponde in modo preciso e diretto alle domande “Cosa devo fare?” e “Come lo faccio?” O, per “spezzare” la questione in blocchi più piccoli come nel dungeoncrawl: Obiettivo Predefinito: Uccidere (o rendere inoffensivi) i nemici. Azione Predefinita: Colpirli. Facile da Preparare: Prendete una manciata di mostri dal Manuale dei Mostri. Facile da Gestire: Il sistema di combattimento divide le azioni in una sequenza specifica e di solito fornisce un metodo abbastanza esauriente per arbitrare ogni azione. Questa è una delle ragioni per cui così tanti giochi di ruolo si concentrano da un punto di vista meccanico sul combattimento: non importa quanto i giocatori possano essere spaesati, tutto quello che dovete fare è lanciare loro addosso un paio di brutti ceffi e improvvisamente tutti quanti al tavolo sanno cosa fare. È comodo e semplice come punto di partenza. Non dovrebbe nemmeno essere difficile vedere l'unione quasi perfetta tra la struttura del dungeoncrawl sul macro-livello e la struttura del combattimento sul micro-livello: quando esplorate il dungeon, scegliete un'uscita e trovate una stanza piena di mostri, passate immediatamente al combattimento. Quando il combattimento è concluso (e la stanza è stata svuotata), tornate senza pensarci allo scenario dell'esplorazione del dungeon e scegliete un'altra uscita. E così via, e così via, e così via. Le ricompense Il combattimento ci mostra anche come D&D unisca direttamente il sistema delle ricompense alle strutture base del gioco: l'esplorazione del dungeon vi porta dai mostri, il combattimento vi fa sconfiggere i mostri, e i mostri sconfitti vi ricompensano con PE e tesori. Credo che questa cosa in generale sia stata trascurata in altri sistemi di ricompense: molti giochi hanno scisso i PE dalle ricompense dei combattimenti, ma non hanno unito il premio in PE ad un'altra struttura di gioco concreta. Che sia o meno una cosa auspicabile è tutto un altro discorso; un discorso che parla del condizionamento di Skinner, della psicologia del sistema di ricompensa, delle tecniche di supporto alle meccaniche, e di un sacco di altre cose. Ma penso che questo aspetto di progettazione sia un territorio inesplorato su cui sarebbe interessante concentrarsi un attimo. Soprattutto se considerate che per vent'anni in (A)D&D ci sono state ricompense esterne ai combattimenti, eppure la gente si lamenta ancora del fatto che tutta l'esperienza in D&D derivi dall'uccisione dei mostri. Link all'articolo originale: https://thealexandrian.net/wordpress/15147/roleplaying-games/game-structures-part-4-combat
-
Le strutture dei giochi - Parte 4: Il combattimento
Ecco a voi il quarto di una serie di 16 articoli che vanno ad analizzare la struttura presente nei giochi di ruolo e come questa sia fondamentale per dare una direzione ad uno specifico GdR. Articolo di The Alexandrian del 09 Aprile 2012 Le Strutture dei Giochi - Parte 1 Le Strutture dei Giochi - Parte 2 Le Strutture dei Giochi - Parte 3 Il successo del dungeoncrawl è strettamente collegato a quello del sistema di combattimento tradizionale nei giochi di ruolo. Nonostante le meccaniche individuali possano variare, praticamente ogni gioco di ruolo utilizza una struttura di gioco base per i combattimenti che deriva da D&D: il combattimento è diviso in turni in cui ognuno ha la possibilità di fare un'azione (o più azioni). Di solito il combattimento è reso più definito da un qualche tipo di sistema di iniziativa, così da riuscire facilmente a rispondere alla domanda: “Chi è il prossimo?” Se tutto ciò suona come la rigida struttura di un gioco da tavolo o di carte, è perché effettivamente è così: il sistema di combattimento del GdR medio, derivando da quello dei giochi da tavolo di simulazione di guerra, risponde in modo preciso e diretto alle domande “Cosa devo fare?” e “Come lo faccio?” O, per “spezzare” la questione in blocchi più piccoli come nel dungeoncrawl: Obiettivo Predefinito: Uccidere (o rendere inoffensivi) i nemici. Azione Predefinita: Colpirli. Facile da Preparare: Prendete una manciata di mostri dal Manuale dei Mostri. Facile da Gestire: Il sistema di combattimento divide le azioni in una sequenza specifica e di solito fornisce un metodo abbastanza esauriente per arbitrare ogni azione. Questa è una delle ragioni per cui così tanti giochi di ruolo si concentrano da un punto di vista meccanico sul combattimento: non importa quanto i giocatori possano essere spaesati, tutto quello che dovete fare è lanciare loro addosso un paio di brutti ceffi e improvvisamente tutti quanti al tavolo sanno cosa fare. È comodo e semplice come punto di partenza. Non dovrebbe nemmeno essere difficile vedere l'unione quasi perfetta tra la struttura del dungeoncrawl sul macro-livello e la struttura del combattimento sul micro-livello: quando esplorate il dungeon, scegliete un'uscita e trovate una stanza piena di mostri, passate immediatamente al combattimento. Quando il combattimento è concluso (e la stanza è stata svuotata), tornate senza pensarci allo scenario dell'esplorazione del dungeon e scegliete un'altra uscita. E così via, e così via, e così via. Le ricompense Il combattimento ci mostra anche come D&D unisca direttamente il sistema delle ricompense alle strutture base del gioco: l'esplorazione del dungeon vi porta dai mostri, il combattimento vi fa sconfiggere i mostri, e i mostri sconfitti vi ricompensano con PE e tesori. Credo che questa cosa in generale sia stata trascurata in altri sistemi di ricompense: molti giochi hanno scisso i PE dalle ricompense dei combattimenti, ma non hanno unito il premio in PE ad un'altra struttura di gioco concreta. Che sia o meno una cosa auspicabile è tutto un altro discorso; un discorso che parla del condizionamento di Skinner, della psicologia del sistema di ricompensa, delle tecniche di supporto alle meccaniche, e di un sacco di altre cose. Ma penso che questo aspetto di progettazione sia un territorio inesplorato su cui sarebbe interessante concentrarsi un attimo. Soprattutto se considerate che per vent'anni in (A)D&D ci sono state ricompense esterne ai combattimenti, eppure la gente si lamenta ancora del fatto che tutta l'esperienza in D&D derivi dall'uccisione dei mostri. Link all'articolo originale: https://thealexandrian.net/wordpress/15147/roleplaying-games/game-structures-part-4-combat Visualizza articolo completo
-
Le strutture dei giochi - Parte 3: Il Dungeoncrawl
Ecco a voi il terzo di una serie di 16 articoli che vanno ad analizzare la struttura presente nei giochi di ruolo e come questa sia fondamentale per dare una direzione ad uno specifico GdR. Articolo di The Alexandrian del 06 Aprile 2012 Le Strutture dei Giochi -Parte 1 Le Strutture dei Giochi - Parte 2 La struttura di scenario che ha avuto maggior successo nella storia dei giochi di ruolo è il dungeoncrawl tradizionale. Anzi, credo che gran parte del successo di D&D risieda proprio nella forza del dungeoncrawl tradizionale come struttura di scenario. (In particolare come struttura si è rivelata estremamente efficace anche quando è stata tradotta in altri media e messa in atto con meccaniche completamente diverse). Cosa fa sì che funzioni? In primo luogo, dal punto di vista del giocatore, fornisce: Un obiettivo di base. Più precisamente, “trova l'intero tesoro”, “uccidi tutti i mostri” o altre varianti di “ripulisci il dungeon”. In altre parole, la struttura fornisce spontaneamente un motivo per cui il giocatore interagisca con lo scenario. Un'azione di base. Se un giocatore si trova in una stanza e non c'è nulla di interessante da fare in essa, allora dovrebbe scegliere un'uscita e andare nella stanza successiva. Presi insieme, questi elementi significano che il giocatore ha sempre una risposta alla domanda “E ora che faccio?” In secondo luogo, per il DM, il dungeoncrawl è: Facile da preparare. Effettivamente, è praticamente impossibile anche per un master neofita fare casini con la progettazione di un dungeocrawl. Cosa potrebbe fare? Dimenticarsi di disegnare un’uscita dalla stanza? Facile da gestire. Qui si va oltre la macro-struttura del dungeoncrawl e si comincia a dipendere dalle stesse regole di D&D, ma, in generale, ogni azione proposta dai giocatori nel dungeon solitamente avrà un metodo di risoluzione evidente. Inoltre il dungeoncrawl crea delle barriere nell’avventura, segmentandola in pezzi separati (ognuna delle stanze) che si possono gestire come piccoli e pratici pacchetti. Presi insieme, questi elementi permettono anche ai DM alle prime armi di progettare e gestire un dungeoncrawl senza intoppi e senza che i giocatori si ritrovino (a) coi bastoni tra le ruote o (b) confusi. Questo è qualcosa di incredibilmente importante. Grazie a questo approccio di esplorazione dei dungeon, D&D può dare vita senza particolari problemi a nuovi DM, con una facilità che alla maggior parte degli altri GDR risulta impensabile ed impossibile. Ma il dungeoncrawl ha anche un altro paio di caratteristiche chiave: Fornisce una struttura, ma non una camicia di forza. Quando i giocatori si domandano “Cosa faccio adesso?” la struttura del dungeoncrawl dà loro una risposta predefinita (“prendi un'uscita”), ma non proibisce loro di creare da soli ogni sorta di risposte: Combattere i goblin. Indagare sulle antiche rune. Fare un orto di funghi. Controllare che non ci siano trappole. Tradurre i geroglifici. Decodificare la costruzione di golem nanici. Negoziare col necromante. Eccetera eccetera. (Non impedisce nemmeno di lasciare completamente la struttura: le regole di D&D includono un gran numero di opzioni per bypassare la struttura del dungeon stesso). Flessibilità nella forma. Il DM può mettere davvero qualunque cosa nella struttura. Ogni stanza del dungeon – ogni parte del contenuto che la struttura dello scenario porta con sé – è un foglio bianco. Grazie a queste strutture di scenario facili da capire, facili da progettare e facili da usare, D&D è accessibile a tutti in un modo che, per esempio, Transhuman Space non possiede. Ora, passiamo dal macro-livello al micro-livello. Link all'articolo originale: https://thealexandrian.net/wordpress/15140/roleplaying-games/game-structures-part-3-dungeoncrawl Visualizza articolo completo
-
Le strutture dei giochi - Parte 3: Il Dungeoncrawl
Articolo di The Alexandrian del 06 Aprile 2012 Le Strutture dei Giochi -Parte 1 Le Strutture dei Giochi - Parte 2 La struttura di scenario che ha avuto maggior successo nella storia dei giochi di ruolo è il dungeoncrawl tradizionale. Anzi, credo che gran parte del successo di D&D risieda proprio nella forza del dungeoncrawl tradizionale come struttura di scenario. (In particolare come struttura si è rivelata estremamente efficace anche quando è stata tradotta in altri media e messa in atto con meccaniche completamente diverse). Cosa fa sì che funzioni? In primo luogo, dal punto di vista del giocatore, fornisce: Un obiettivo di base. Più precisamente, “trova l'intero tesoro”, “uccidi tutti i mostri” o altre varianti di “ripulisci il dungeon”. In altre parole, la struttura fornisce spontaneamente un motivo per cui il giocatore interagisca con lo scenario. Un'azione di base. Se un giocatore si trova in una stanza e non c'è nulla di interessante da fare in essa, allora dovrebbe scegliere un'uscita e andare nella stanza successiva. Presi insieme, questi elementi significano che il giocatore ha sempre una risposta alla domanda “E ora che faccio?” In secondo luogo, per il DM, il dungeoncrawl è: Facile da preparare. Effettivamente, è praticamente impossibile anche per un master neofita fare casini con la progettazione di un dungeocrawl. Cosa potrebbe fare? Dimenticarsi di disegnare un’uscita dalla stanza? Facile da gestire. Qui si va oltre la macro-struttura del dungeoncrawl e si comincia a dipendere dalle stesse regole di D&D, ma, in generale, ogni azione proposta dai giocatori nel dungeon solitamente avrà un metodo di risoluzione evidente. Inoltre il dungeoncrawl crea delle barriere nell’avventura, segmentandola in pezzi separati (ognuna delle stanze) che si possono gestire come piccoli e pratici pacchetti. Presi insieme, questi elementi permettono anche ai DM alle prime armi di progettare e gestire un dungeoncrawl senza intoppi e senza che i giocatori si ritrovino (a) coi bastoni tra le ruote o (b) confusi. Questo è qualcosa di incredibilmente importante. Grazie a questo approccio di esplorazione dei dungeon, D&D può dare vita senza particolari problemi a nuovi DM, con una facilità che alla maggior parte degli altri GDR risulta impensabile ed impossibile. Ma il dungeoncrawl ha anche un altro paio di caratteristiche chiave: Fornisce una struttura, ma non una camicia di forza. Quando i giocatori si domandano “Cosa faccio adesso?” la struttura del dungeoncrawl dà loro una risposta predefinita (“prendi un'uscita”), ma non proibisce loro di creare da soli ogni sorta di risposte: Combattere i goblin. Indagare sulle antiche rune. Fare un orto di funghi. Controllare che non ci siano trappole. Tradurre i geroglifici. Decodificare la costruzione di golem nanici. Negoziare col necromante. Eccetera eccetera. (Non impedisce nemmeno di lasciare completamente la struttura: le regole di D&D includono un gran numero di opzioni per bypassare la struttura del dungeon stesso). Flessibilità nella forma. Il DM può mettere davvero qualunque cosa nella struttura. Ogni stanza del dungeon – ogni parte del contenuto che la struttura dello scenario porta con sé – è un foglio bianco. Grazie a queste strutture di scenario facili da capire, facili da progettare e facili da usare, D&D è accessibile a tutti in un modo che, per esempio, Transhuman Space non possiede. Ora, passiamo dal macro-livello al micro-livello. Link all'articolo originale: https://thealexandrian.net/wordpress/15140/roleplaying-games/game-structures-part-3-dungeoncrawl
-
Le strutture dei giochi - Parte 2: Concetti di Base
Continuiamo con la seconda parte (di 16) di questa rubrica che tratta delle strutture basilari dietro i nostri giochi preferiti Articolo di The Alexandrian del 04 Aprile 2012 Le Strutture dei Giochi Parte 1 Un discorso del genere può risultare alquanto difficile da trattare perché queste strutture dei giochi sono diventate dei compagni invisibili nei nostri giochi. Di solito non se ne parla. Non ci pensiamo neanche, in realtà. In The Elfish Gene, Mark Barrowcliffe scrive: “Quando si gioca a D&D il tutto suona come una serie di domande e risposte”. In modo del tutto analogo, in Apocalypse World, D. Vincent Baker dice: “Il gioco di ruolo è una conversazione. Voi e gli altri giocatori vi alternate nel dialogo, parlando di questi personaggi fittizi nelle loro situazioni fittizie facendo qualunque cosa sia ciò che fanno. Come in ogni conversazione, si parla a turno, ma non è come fare a turno, giusto?” Così, nel momento in cui cominciamo a dare un'occhiata alle strutture di gioco nei classici giochi di ruolo, quello che facciamo in realtà è sviscerare questa conversazione per capirne i meccanismi e i funzionamenti interni. Ci mettiamo anche alla ricerca del modo in cui imponiamo delle regole a quel tipo di conversazione e di che effetto tali regole hanno, proprio come succede in una discussione normale. (Alcune di queste regole sono le reali meccaniche del gioco, ma la maggior parte in realtà sono più vaghe e applicabili in modo più universale). Tenendo a mente ciò, cominciamo con l'immaginarci seduti ad un ipotetico tavolo a giocare. Vogliamo cominciare un gioco di ruolo tradizionale. Cosa deve succedere? Uno dei giocatori deve proporre un'azione da far fare al proprio personaggio. Il master deve arbitrare quell'azione e fornirne un esito. Una volta determinato l'esito, il ciclo si ripete. (Il giocatore propone una nuova azione per il proprio personaggio e allora il master arbitra quell'azione). Questa è la base fondamentale della conversazione che sta al centro di ogni gioco di ruolo. Ma, come abbiamo stabilito all'inizio di questa serie di articoli, ciò non è facile come sembra. Le cose si fanno difficili non appena prendiamo in considerazione due domande: Qual è esattamente l'azione arbitrata? Come si arbitra esattamente quell'azione? Si può pensare grosso modo alla prima domanda come fare concettualmente a pezzi le azioni o romperle. (“Esplorare il dungeon” è una singola azione o è formato da diverse azioni?) A volte il master dovrà spezzare un'azione proposta in azioni più piccole; a volte dovrà capire come far sì che il giocatore metta insieme i pezzi per creare qualcosa di complessivo che abbia senso. Ovviamente, l'ideale sarebbe che sia il giocatore che il master siano d'accordo sul tipo di “pezzo” da proporre ed arbitrare. (E questo, ovviamente, è dove entrano in gioco le strutture condivise dei giochi). Alla seconda domanda rispondono le stesse meccaniche del gioco nella maggior parte dei casi, ma non sempre. (E spesso queste meccaniche danno solo una risposta parziale). Per fare un esempio relativamente semplice ad un micro-livello, pensiamo ad una situazione in cui Elizabeth, Duchessa di Canterlocke, sta presentando formalmente il suo amico, il Duca di Donalberry. Ma, in realtà, il Duca di Donalberry è un impostore ed Elizabeth lo sa (sta cercando di farlo introdurre di nascosto ad un evento formale per ragioni che non ci interessano). Si decide con un tiro per Raggirare? Se è così, il tiro lo deve fare la duchessa o il duca? O entrambi? Oppure la duchessa dovrebbe fare un tiro per Raggirare e il duca un tiro di Camuffare? Se la duchessa fallisce il tiro per Raggirare, significa che l'inganno viene scoperto? Oppure fa sì che il loro bersaglio si renda conto che c'è qualcosa di strano in atto (e quindi dà una penalità al tiro di Camuffare del duca?) Non c'è una risposta “giusta” qui. Ma la struttura che scegliete avrà un impatto significativo sullo svolgimento di queste scene al tavolo. MACRO vs. MICRO Per comodità, spezzerò la mia discussione sulle strutture dei giochi in due tipi: Al micro-livello, le strutture dei giochi di solito prendono la forma di decisioni del master: riprendendo l'esempio della Duchessa di Canterlocke, i personaggi propongono un'azione e il master decide come risolvere l'azione. (In alcuni casi questa decisione è diretta – i giocatori vogliono fare X; c'è una regola per X; il master usa la regola – e in altri casi bisognerà essere più innovativi). Al macro-livello, le strutture del gioco diventano le strutture dello scenario. Queste impalcature più ampie determinano il modo in cui i giocatori si muovono in ambienti complessi (da un punto di vista fisico, sociale, astratto, o altro ancora). Per esempio, immaginate un'idea di scenario del genere: “I personaggi vanno al Castello Osterkark e indagano sulle voci di attività di cultisti.” Un master potrebbe scegliere di usare tutte le strutture di gioco che vuole per rendere più sostanziosa quest'idea: È un tipo di "crawl"* di stanza in stanza? C'è una rete di indizi che porterà i personaggi in vari luoghi in giro per il castello? I personaggi dovranno cercare NPC particolari e interrogarli? C'è una successione temporale di eventi? Una qualche combinazione di queste tecniche? Altre tecniche totalmente diverse? Sia al macro- che al micro-livello, le strutture dei giochi hanno un impatto significativo su quello che succede davvero al tavolo. Per aiutarci ad avere un'idea più precisa su come appaiano le strutture degli scenari nella pratica, diamo un'occhiata al loro antenato comune: il dungeoncrawl. *Nota del traduttore: il termine "crawl" (usato in termini di uso comune nel GdR come dungeoncrawl, hexcrawl e vari altri che incontreremo nei prossimi articoli) sta ad indicare un avanzamento lento e relativamente lineare attraverso una serie di luoghi ed elementi di gioco (ad esempio stanze in un dungeon) e porta con sé il significato di fatica, impegno e rischio. Link all'articolo originale: https://thealexandrian.net/wordpress/15134/roleplaying-games/game-structures-part-2-game-structure-basics Visualizza articolo completo
-
Le strutture dei giochi - Parte 2: Concetti di Base
Articolo di The Alexandrian del 04 Aprile 2012 Le Strutture dei Giochi Parte 1 Un discorso del genere può risultare alquanto difficile da trattare perché queste strutture dei giochi sono diventate dei compagni invisibili nei nostri giochi. Di solito non se ne parla. Non ci pensiamo neanche, in realtà. In The Elfish Gene, Mark Barrowcliffe scrive: “Quando si gioca a D&D il tutto suona come una serie di domande e risposte”. In modo del tutto analogo, in Apocalypse World, D. Vincent Baker dice: “Il gioco di ruolo è una conversazione. Voi e gli altri giocatori vi alternate nel dialogo, parlando di questi personaggi fittizi nelle loro situazioni fittizie facendo qualunque cosa sia ciò che fanno. Come in ogni conversazione, si parla a turno, ma non è come fare a turno, giusto?” Così, nel momento in cui cominciamo a dare un'occhiata alle strutture di gioco nei classici giochi di ruolo, quello che facciamo in realtà è sviscerare questa conversazione per capirne i meccanismi e i funzionamenti interni. Ci mettiamo anche alla ricerca del modo in cui imponiamo delle regole a quel tipo di conversazione e di che effetto tali regole hanno, proprio come succede in una discussione normale. (Alcune di queste regole sono le reali meccaniche del gioco, ma la maggior parte in realtà sono più vaghe e applicabili in modo più universale). Tenendo a mente ciò, cominciamo con l'immaginarci seduti ad un ipotetico tavolo a giocare. Vogliamo cominciare un gioco di ruolo tradizionale. Cosa deve succedere? Uno dei giocatori deve proporre un'azione da far fare al proprio personaggio. Il master deve arbitrare quell'azione e fornirne un esito. Una volta determinato l'esito, il ciclo si ripete. (Il giocatore propone una nuova azione per il proprio personaggio e allora il master arbitra quell'azione). Questa è la base fondamentale della conversazione che sta al centro di ogni gioco di ruolo. Ma, come abbiamo stabilito all'inizio di questa serie di articoli, ciò non è facile come sembra. Le cose si fanno difficili non appena prendiamo in considerazione due domande: Qual è esattamente l'azione arbitrata? Come si arbitra esattamente quell'azione? Si può pensare grosso modo alla prima domanda come fare concettualmente a pezzi le azioni o romperle. (“Esplorare il dungeon” è una singola azione o è formato da diverse azioni?) A volte il master dovrà spezzare un'azione proposta in azioni più piccole; a volte dovrà capire come far sì che il giocatore metta insieme i pezzi per creare qualcosa di complessivo che abbia senso. Ovviamente, l'ideale sarebbe che sia il giocatore che il master siano d'accordo sul tipo di “pezzo” da proporre ed arbitrare. (E questo, ovviamente, è dove entrano in gioco le strutture condivise dei giochi). Alla seconda domanda rispondono le stesse meccaniche del gioco nella maggior parte dei casi, ma non sempre. (E spesso queste meccaniche danno solo una risposta parziale). Per fare un esempio relativamente semplice ad un micro-livello, pensiamo ad una situazione in cui Elizabeth, Duchessa di Canterlocke, sta presentando formalmente il suo amico, il Duca di Donalberry. Ma, in realtà, il Duca di Donalberry è un impostore ed Elizabeth lo sa (sta cercando di farlo introdurre di nascosto ad un evento formale per ragioni che non ci interessano). Si decide con un tiro per Raggirare? Se è così, il tiro lo deve fare la duchessa o il duca? O entrambi? Oppure la duchessa dovrebbe fare un tiro per Raggirare e il duca un tiro di Camuffare? Se la duchessa fallisce il tiro per Raggirare, significa che l'inganno viene scoperto? Oppure fa sì che il loro bersaglio si renda conto che c'è qualcosa di strano in atto (e quindi dà una penalità al tiro di Camuffare del duca?) Non c'è una risposta “giusta” qui. Ma la struttura che scegliete avrà un impatto significativo sullo svolgimento di queste scene al tavolo. MACRO vs. MICRO Per comodità, spezzerò la mia discussione sulle strutture dei giochi in due tipi: Al micro-livello, le strutture dei giochi di solito prendono la forma di decisioni del master: riprendendo l'esempio della Duchessa di Canterlocke, i personaggi propongono un'azione e il master decide come risolvere l'azione. (In alcuni casi questa decisione è diretta – i giocatori vogliono fare X; c'è una regola per X; il master usa la regola – e in altri casi bisognerà essere più innovativi). Al macro-livello, le strutture del gioco diventano le strutture dello scenario. Queste impalcature più ampie determinano il modo in cui i giocatori si muovono in ambienti complessi (da un punto di vista fisico, sociale, astratto, o altro ancora). Per esempio, immaginate un'idea di scenario del genere: “I personaggi vanno al Castello Osterkark e indagano sulle voci di attività di cultisti.” Un master potrebbe scegliere di usare tutte le strutture di gioco che vuole per rendere più sostanziosa quest'idea: È un tipo di "crawl"* di stanza in stanza? C'è una rete di indizi che porterà i personaggi in vari luoghi in giro per il castello? I personaggi dovranno cercare NPC particolari e interrogarli? C'è una successione temporale di eventi? Una qualche combinazione di queste tecniche? Altre tecniche totalmente diverse? Sia al macro- che al micro-livello, le strutture dei giochi hanno un impatto significativo su quello che succede davvero al tavolo. Per aiutarci ad avere un'idea più precisa su come appaiano le strutture degli scenari nella pratica, diamo un'occhiata al loro antenato comune: il dungeoncrawl. *Nota del traduttore: il termine "crawl" (usato in termini di uso comune nel GdR come dungeoncrawl, hexcrawl e vari altri che incontreremo nei prossimi articoli) sta ad indicare un avanzamento lento e relativamente lineare attraverso una serie di luoghi ed elementi di gioco (ad esempio stanze in un dungeon) e porta con sé il significato di fatica, impegno e rischio. Link all'articolo originale: https://thealexandrian.net/wordpress/15134/roleplaying-games/game-structures-part-2-game-structure-basics
-
Le strutture dei giochi - Parte 1
Ecco a voi il primo di una serie di 16 articoli che vanno ad analizzare la struttura presente nei giochi di ruolo e come questa sia fondamentale per dare una direzione ad uno specifico GdR. Le Strutture dei Giochi Parte 1 Le Strutture dei Giochi Parte 2: Concetti di Base Le Strutture dei Giochi Parte 3: Il Dungeoncrawl Le Strutture dei Giochi Parte 4: Il Combattimento Le Strutture dei Giochi Parte 5: Gli Investigativi Le Strutture dei Giochi Parte 6: Gli Hexcrawl Le Strutture dei Giochi Parte 7: Giocare gli Hexcrawl Le Strutture dei Giochi Parte 8: L'Importanza delle Strutture Ordinate Le Strutture dei Giochi Parte 9: Le Strutture di Gioco Arcaiche Le Strutture dei Giochi Parte 10: Le Strutture di Gioco Incomplete Le Strutture dei Giochi Parte 11: Le Strutture di Gioco Complete Le Strutture dei Giochi Parte 12: Usare Strutture di Scenario Le Strutture dei Giochi Parte 13: Strutture Personalizzate Le Strutture dei Giochi Parte 14: Strutture Tra le Stelle Le Strutture dei Giochi Parte 15: Strutture di Scenario Generiche Le Strutture dei Giochi Parte 16: Strutture di Scenario Note e Sconosciute ai Giocatori Le Strutture dei Giochi Appendice I: Katane e Pastrani Le Strutture dei Giochi Appendice II: L'Importanza del Sistema Articolo di The Alexandrian del 02 Aprile 2012 Uno degli aspetti più trascurati quando si progettano e si giocano giochi di ruolo tradizionali è la loro struttura di base. O, per metterla in un altro modo, ci sono due domande che ogni master o sviluppatore di un gioco si deve fare: Cosa fanno i personaggi? Come fanno i giocatori a farglielo fare? Queste domande in apparenza così semplici nascondono risposte complesse. E dare le risposte corrette è assolutamente cruciale perché la sessione di gioco abbia successo. Alcuni di voi potrebbero già contestarmi: “E che problema c'è? I giocatori mi dicono cosa fanno i loro personaggi e poi lo arbitriamo. Che c'è di tanto difficile?” Per dimostrare l'errore di valutazione che ci sta sotto, lasciate che vi faccia un breve esempio di giocata: Giocatore: Voglio esplorare il dungeon Master: Ok, tira per esplorare il dungeon Giocatore: Il tiro ha successo Master: Ok, uccidi una tribù di goblin ed esci con 546 monete di tesoro C'è qualcosa di sbagliato in questo? Non necessariamente. Ma come struttura di gioco è sicuramente molto diversa rispetto al classico dungeoncrawl di D&D. E, ovviamente, in questo esempio si dà per scontato che i personaggi siano eroi fantasy che fanno cose come esplorare i dungeon. Con la stessa ambientazione e lo stesso sistema di gioco, potrebbero facilmente essere monarchi, draghi, contadini, studiosi di magia, avventurieri che fanno viaggi planari, divinità, geni militari, o una qualunque di altre cose per cui le strutture di questi giochi tipicamente esplorativi sono irrilevanti. GIOCHI DA TAVOLO E GIOCHI DI CARTE Il motivo per cui la struttura dei giochi è diventata un problema per noi è perché i giochi di ruolo sono, in termini funzionali, senza limiti: ci si aspetta (ed è giusto così) che i giocatori possano dire “Voglio che il mio personaggio faccia X” e che possiamo capire se (a) ce la faranno e (b) cosa succederà di conseguenza. I giochi da tavolo e di carte classici non hanno questo problema perché la loro struttura è definita in modo rigido e limitata dalle regole: ogni volta che arriva il vostro turno in Monopoli o negli scacchi o in Arkham Horror c'è una sequenza di azioni da eseguire, definita in modo preciso. La complessità di questa struttura può variare leggermente (in Candyland bisogna semplicemente seguire le istruzioni nel giusto ordine; in Twilight Imperium per pianificare le vostre decisioni avrete bisogno di un diagramma di flusso incredibilmente complesso), ma la struttura è fissa ed esauriente. O, per metterla in un altro modo, i giochi da tavolo e di carte hanno sempre una risposta alle domande “Cosa dovrei fare ora?” e “Ora che succede?” GIOCHI DI RUOLO Considerate uno scenario ipotetico in cui catapultate un gruppo di PG all'angolo di una strada a caso. Ora, prendete lo stesso gruppo di personaggi e catapultateli in una stanza a caso di un dungeon. Perché un gruppo dice “Vado verso la porta a nord” mentre l'altro dice “Vado a cercare la stazione di polizia più vicina”? Perché il tizio nel dungeon non dice “Vado a cercare il tesoro” e quello all'angolo della strada non dice “Vado nella via a sinistra”? In parte, ovviamente, dipende dal fatto che ogni gruppo di personaggi ha un diverso insieme di obiettivi immediati. Ma ha molto più a che fare con le abitudini che i giocatori inevitabilmente hanno assimilato in anni di GdR. Un altro esempio: considerate la differenza tra il giocare a D&D o al gioco da tavolo Wrath of Ashardalon. Entrambi hanno meccaniche simili, ambientazioni simili, e i personaggi hanno obiettivi simili. Perché il mio gruppo di D&D probabilmente passerà del tempo ad esaminare i muri e a fare ricerche su circoli arcani mentre il mio gruppo di Wrath of Ashardalon non lo fa? Perché la struttura dei due giochi è diversa. In più, come suggerisce il nostro esempio “scenario del dungeon vs scenario urbano”, i giochi di ruolo spesso passano da una struttura ad un'altra. Diversamente, i giochi per PC normalmente non passano da una struttura all'altra, ma invece tendono ad uniformare il flusso di gioco: in Elder Scrolls si usa la stessa interfaccia e gli stessi comandi che si esplori un dungeon, si viaggi per le lande selvagge o si facciano compere in città. D'altra parte, giochi come Final Fantasy VII hanno una mappa via terra attraverso la quale viaggiare. E Elder Scrolls V ha introdotto il sistema “fast travel” che cambia ulteriormente quella struttura. Allo stesso tempo, sull'altro piatto della bilancia, il motore di gioco del primo Bard's Tale era così limitato che la città di Skara Brae era una fiera dell'omicidio in cui i cittadini vi attaccavano come fossero mostri e lo stile di gioco era quasi del tutto indistinguibile da quello di un dungeon anche al micro-livello. In maniera analoga, quando avevo dodici anni, cercai di masterare le mie prime avventure nelle terre selvagge come se fossero dungeoncrawl: “Ok, vedete degli alberi. Cosa fate?” “Andiamo verso nord.” “Ok, andate avanti per una trentina di metri. Ci sono ancora alberi. Cosa fate ora?” Usate la struttura di gioco sbagliata e il vostro gioco potrebbe finire per essere un flop. Ci vediamo settimana prossima per la seconda parte Link all'originale:https://thealexandrian.net/wordpress/15126/roleplaying-games/game-structures Visualizza articolo completo
-
Le strutture dei giochi - Parte 1
Le Strutture dei Giochi Parte 1 Le Strutture dei Giochi Parte 2: Concetti di Base Le Strutture dei Giochi Parte 3: Il Dungeoncrawl Le Strutture dei Giochi Parte 4: Il Combattimento Le Strutture dei Giochi Parte 5: Gli Investigativi Le Strutture dei Giochi Parte 6: Gli Hexcrawl Le Strutture dei Giochi Parte 7: Giocare gli Hexcrawl Le Strutture dei Giochi Parte 8: L'Importanza delle Strutture Ordinate Le Strutture dei Giochi Parte 9: Le Strutture di Gioco Arcaiche Le Strutture dei Giochi Parte 10: Le Strutture di Gioco Incomplete Le Strutture dei Giochi Parte 11: Le Strutture di Gioco Complete Le Strutture dei Giochi Parte 12: Usare Strutture di Scenario Le Strutture dei Giochi Parte 13: Strutture Personalizzate Le Strutture dei Giochi Parte 14: Strutture Tra le Stelle Le Strutture dei Giochi Parte 15: Strutture di Scenario Generiche Le Strutture dei Giochi Parte 16: Strutture di Scenario Note e Sconosciute ai Giocatori Le Strutture dei Giochi Appendice I: Katane e Pastrani Le Strutture dei Giochi Appendice II: L'Importanza del Sistema Articolo di The Alexandrian del 02 Aprile 2012 Uno degli aspetti più trascurati quando si progettano e si giocano giochi di ruolo tradizionali è la loro struttura di base. O, per metterla in un altro modo, ci sono due domande che ogni master o sviluppatore di un gioco si deve fare: Cosa fanno i personaggi? Come fanno i giocatori a farglielo fare? Queste domande in apparenza così semplici nascondono risposte complesse. E dare le risposte corrette è assolutamente cruciale perché la sessione di gioco abbia successo. Alcuni di voi potrebbero già contestarmi: “E che problema c'è? I giocatori mi dicono cosa fanno i loro personaggi e poi lo arbitriamo. Che c'è di tanto difficile?” Per dimostrare l'errore di valutazione che ci sta sotto, lasciate che vi faccia un breve esempio di giocata: Giocatore: Voglio esplorare il dungeon Master: Ok, tira per esplorare il dungeon Giocatore: Il tiro ha successo Master: Ok, uccidi una tribù di goblin ed esci con 546 monete di tesoro C'è qualcosa di sbagliato in questo? Non necessariamente. Ma come struttura di gioco è sicuramente molto diversa rispetto al classico dungeoncrawl di D&D. E, ovviamente, in questo esempio si dà per scontato che i personaggi siano eroi fantasy che fanno cose come esplorare i dungeon. Con la stessa ambientazione e lo stesso sistema di gioco, potrebbero facilmente essere monarchi, draghi, contadini, studiosi di magia, avventurieri che fanno viaggi planari, divinità, geni militari, o una qualunque di altre cose per cui le strutture di questi giochi tipicamente esplorativi sono irrilevanti. GIOCHI DA TAVOLO E GIOCHI DI CARTE Il motivo per cui la struttura dei giochi è diventata un problema per noi è perché i giochi di ruolo sono, in termini funzionali, senza limiti: ci si aspetta (ed è giusto così) che i giocatori possano dire “Voglio che il mio personaggio faccia X” e che possiamo capire se (a) ce la faranno e (b) cosa succederà di conseguenza. I giochi da tavolo e di carte classici non hanno questo problema perché la loro struttura è definita in modo rigido e limitata dalle regole: ogni volta che arriva il vostro turno in Monopoli o negli scacchi o in Arkham Horror c'è una sequenza di azioni da eseguire, definita in modo preciso. La complessità di questa struttura può variare leggermente (in Candyland bisogna semplicemente seguire le istruzioni nel giusto ordine; in Twilight Imperium per pianificare le vostre decisioni avrete bisogno di un diagramma di flusso incredibilmente complesso), ma la struttura è fissa ed esauriente. O, per metterla in un altro modo, i giochi da tavolo e di carte hanno sempre una risposta alle domande “Cosa dovrei fare ora?” e “Ora che succede?” GIOCHI DI RUOLO Considerate uno scenario ipotetico in cui catapultate un gruppo di PG all'angolo di una strada a caso. Ora, prendete lo stesso gruppo di personaggi e catapultateli in una stanza a caso di un dungeon. Perché un gruppo dice “Vado verso la porta a nord” mentre l'altro dice “Vado a cercare la stazione di polizia più vicina”? Perché il tizio nel dungeon non dice “Vado a cercare il tesoro” e quello all'angolo della strada non dice “Vado nella via a sinistra”? In parte, ovviamente, dipende dal fatto che ogni gruppo di personaggi ha un diverso insieme di obiettivi immediati. Ma ha molto più a che fare con le abitudini che i giocatori inevitabilmente hanno assimilato in anni di GdR. Un altro esempio: considerate la differenza tra il giocare a D&D o al gioco da tavolo Wrath of Ashardalon. Entrambi hanno meccaniche simili, ambientazioni simili, e i personaggi hanno obiettivi simili. Perché il mio gruppo di D&D probabilmente passerà del tempo ad esaminare i muri e a fare ricerche su circoli arcani mentre il mio gruppo di Wrath of Ashardalon non lo fa? Perché la struttura dei due giochi è diversa. In più, come suggerisce il nostro esempio “scenario del dungeon vs scenario urbano”, i giochi di ruolo spesso passano da una struttura ad un'altra. Diversamente, i giochi per PC normalmente non passano da una struttura all'altra, ma invece tendono ad uniformare il flusso di gioco: in Elder Scrolls si usa la stessa interfaccia e gli stessi comandi che si esplori un dungeon, si viaggi per le lande selvagge o si facciano compere in città. D'altra parte, giochi come Final Fantasy VII hanno una mappa via terra attraverso la quale viaggiare. E Elder Scrolls V ha introdotto il sistema “fast travel” che cambia ulteriormente quella struttura. Allo stesso tempo, sull'altro piatto della bilancia, il motore di gioco del primo Bard's Tale era così limitato che la città di Skara Brae era una fiera dell'omicidio in cui i cittadini vi attaccavano come fossero mostri e lo stile di gioco era quasi del tutto indistinguibile da quello di un dungeon anche al micro-livello. In maniera analoga, quando avevo dodici anni, cercai di masterare le mie prime avventure nelle terre selvagge come se fossero dungeoncrawl: “Ok, vedete degli alberi. Cosa fate?” “Andiamo verso nord.” “Ok, andate avanti per una trentina di metri. Ci sono ancora alberi. Cosa fate ora?” Usate la struttura di gioco sbagliata e il vostro gioco potrebbe finire per essere un flop. Ci vediamo settimana prossima per la seconda parte Link all'originale:https://thealexandrian.net/wordpress/15126/roleplaying-games/game-structures
-
La Regola dei Tre Indizi
Gli indizi sono spesso fondamentali in una partita, che sia puramente investigativa o meno, ma è necessario fare in modo che ce ne siano molti e variegati, per dare più possibilità ai vostri giocatori di raggiungere le giuste conclusioni. Articolo di The Alexandrian del 08 Maggio 2008 Gli scenari investigativi nei giochi di ruolo hanno la reputazione di finire spesso in disastro. I PG finiscono quasi sempre per prendere totalmente un'altra strada o non riuscire a trovare un dato indizio e l'intera situazione si inchioda o si incaglia sul primo scoglio che trova. I giocatori finiscono per non essere sicuri di cosa dovrebbero fare. Il DM finisce per avere la sensazione di aver fatto qualcosa di sbagliato. E l'intera serata finisce per essere noiosa o frustrante o entrambe le cose. Un tipico esempio può essere questo: quando il gruppo si trova su una scena del crimine, nessuno cerca fuori dalla casa, perciò non trovano mai le orme di un lupo che si trasformano in quelle di un essere umano. Falliscono il tiro di Cercare e non trovano le lettere d'amore nascoste, così non si renderanno mai conto che entrambe le donne erano corteggiate dallo stesso uomo. Trovano la cassa distrutta con la scritta CARNI DI DANNER, ma, anziché tornare indietro dal macellaio del posto con cui hanno parlato prima, decidono invece di tenere d'occhio il vicino impianto di trasformazione delle carni. Di fronte a problemi come questi, molti raggiungono una conclusione affrettata: che inserire degli scenari investigativi nei giochi di ruolo sia una pessima idea. Nel tipico giallo su un omicidio, per esempio, il protagonista è un brillante detective. I giocatori probabilmente non sono dei brillanti detective. Perciò inserire uno scenario investigativo è impossibile. O, come mi è stato detto una volta: “I giocatori non sono Sherlock Holmes.” Nonostante questa conclusione non sia corretta, c'è un po' di verità. Per esempio, in Uno Studio in Rosso Sherlock Holmes investiga su una scena del crimine. Scopre un mucchietto di cenere in un angolo della stanza. Lo studia con attenzione e arriva alla conclusione che la cenere viene da un sigaro Trichinipoli. Ora, vediamo come potremmo tradurre questo esempio apparentemente banale di deduzione sherlockiana sul tavolo: I giocatori dovrebbero riuscire a cercare per bene nella stanza. Dovrebbero interessarsi alla cenere abbastanza da esaminarla. Dovrebbero passare il tiro abilità Ricerca per analizzarla. Dovrebbero usare quelle informazioni per raggiungere la conclusione corretta. Sono quattro possibilità di fallimento. I giocatori potrebbero non riuscire a cercare per la stanza (o perché non ci pensano o perché fanno tiri bassi). Potrebbero non esaminare la cenere (perché non pensano sia importante). Potrebbero fallire il tiro per analizzarla. Potrebbero non riuscire a fare la deduzione corretta. Se riconoscere correttamente questo indizio è essenziale per proseguire nell'avventura (se, per esempio, il gruppo deve andare nel vicino negozio di sigari particolari e cominciare a fare domande), allora l'indizio diventa un collo di bottiglia: o il gruppo coglie l'indizio o va a finire contro un muro. I colli di bottiglia sono sempre un grosso problema nella creazione di un'avventura e devono essere evitati, ma quando ci troviamo in una situazione di tipo investigativo il problema è ancora peggiore: ogni indizio non è un solo collo di bottiglia, ma in realtà più colli di bottiglia. Perciò qui la soluzione è semplice: eliminare i colli di bottiglia. IL SENTIERO DI MOLLICHE DI PANE Nel GUMSHOE system di Robin D. Laws (utilizzato in Esoterroristi, Di cosa hai paura, e Sulle tracce di Cthuhlu), trovare gli indizi non è necessario. In ogni “scena” di una situazione investigativa, c'è un “indizio”. Si presume automaticamente che gli investigatori lo troveranno. Ciò elimina tre delle nostre quattro strettoie, e rimane solo la necessità di usare l'indizio per fare la deduzione corretta (cioè, la deduzione che ti porta alla “scena” seguente dove potrà venir rivelato l'indizio successivo). E, nel caso del GUMSHOE system, anche questo passaggio può avvenire in modo meccanico (coi giocatori che spendono i punti delle abilità investigative dei propri personaggi per ricevere dal master “deduzioni” sempre più precise). È una soluzione meccanica al problema. Ma se utilizzata in una sessione che segue in modo superficiale la struttura di una storia investigativa, credo che fallisca nel suo intento perché non sembra di stare giocando una storia di investigazione. L'errore fondamentale di Law, secondo me, sta nel partire dal presupposto che una storia investigativa equivalga a seguire un “sentiero di molliche di pane” (o meglio, di indizi). Ecco la citazione di un suo saggio a tal proposito: Ma, nella realtà dei fatti, questo tipo di trama ridotta semplicisticamente a “Da A si va a B e da lì a C e da lì a D” non è tipica del genere investigativo. Per dare un contro-esempio relativamente semplice, torniamo a Sherlock Homes in Uno Studio in Rosso: Questa è solo una piccola deduzione in un mistero molto più fitto, ma noterete che Holmes in realtà ha raccolto diversi indizi, li ha studiati, e poi da essi ha tratto una conclusione. Ed è questa, per l'appunto, la struttura tipica del genere investigativo: il detective raccoglie piano piano le prove fino a che non arriva una conclusione. Nelle note parole dello stesso Holmes, “Quando si elimina l'impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità.” In realtà, in molti casi la verità è che c'è bisogno di tante piccole deduzioni per raccogliere tutte le prove necessarie a risolvere il mistero. In ogni caso, come dimostra l'esempio di Uno studio in rosso, anche queste deduzioni più marginali possono emergere da un insieme di prove e non da un solo indizio isolato. Questa osservazione ci porta inesorabilmente alla soluzione che stavamo cercando: LA REGOLA DEI TRE INDIZI Ogni qualvolta realizzate uno scenario investigativo, dovreste inevitabilmente seguire la Regola dei Tre Indizi: Per ogni conclusione a cui volete che giungano i giocatori, includete almeno tre indizi. Perché tre? Perché probabilmente i giocatori si perderanno il primo; ignoreranno il secondo; e interpreteranno male il terzo prima di fare un incredibile volo pindarico che li farà arrivare dove volevate fin dall'inizio. Scherzo, ovviamente. Ma se pensate ad ogni indizio come un piano (il gruppo troverà X, arriverà alla conclusione Y e andrà a Z), allora quando avete tre indizi vi ritrovate non solo con un piano, ma con addirittura un piano B e uno C. E quando vi renderete conto che i vostri piani non sopravviveranno mai al confronto coi giocatori, capirete perché vi servono un piano B e uno C. Nella migliore delle ipotesi, ovviamente, il gruppo troverà tutti e tre gli indizi. Non c'è nulla di sbagliato. Potranno usare gli indizi per dare conferma ai loro sospetti e rafforzare le loro conclusioni (proprio come Sherlock Holmes). Nella peggiore delle ipotesi, dovrebbero essere in grado di usare almeno uno di questi indizi per raggiungere la conclusione corretta e proseguire nell'avventura. Ed ecco un suggerimento importante: la Regola dei Tre Indizi non ha eccezioni. “Ma Justin!” mi direte. “Questo indizio è davvero lampante. Non è possibile che il gruppo non ci arrivi.” Secondo la mia esperienza, probabilmente vi sbagliate. Da un lato, considerate che siete voi a creare la situazione. Sapete già qual è la soluzione del giallo. Questo vi rende difficile il giudicare in maniera obiettiva se una cosa è ovvia oppure no. E anche aveste ragione, che problema c'è? Avere indizi in più non darà alcun problema. Perché non prevenire anziché curare? ESTENDERE LA REGOLA DEI TRE INDIZI In realtà, sarebbe un'ottima idea tenere a mente il concetto base della Regola dei Tre Indizi, in senso lato, nella realizzazione di qualsiasi tipo di situazione. Richard Garriot, il designer dei videogiochi della serie Ultima e Tabula Rasa, una volta ha detto che il suo lavoro come game designer era assicurarsi che fosse possibile avere almeno una soluzione ad un problema senza impedire al giocatore di trovare altre soluzioni per conto proprio. Per esempio, se trovate una porta chiusa in uno degli Ultima, da qualche parte ci sarà anche una chiave. Ma potreste anche farvi strada con la forza; o scassinare la serratura; o puntarci contro un cannone e farla saltare. Warren Spector, che cominciò col lavorare con Garriott ad Ultima VI, in seguito divenne designer di Deus Ex. Segue la stessa filosofia di design e parla entusiasta dell'emozione che provava nel guardare qualcuno giocare al proprio videogioco e pensare, “Aspetta... funzionerà?” In realtà, quando progetto un'avventura cerco di portare questa filosofia di design al livello successivo: per ogni problema che si pone davanti al gruppo, mi assicuro che ci sia almeno una soluzione e poi rimango totalmente aperto a qualsiasi idea venga in mente ai giocatori. Ma per ogni problema a collo di bottiglia, mi assicuro che ci siano almeno tre soluzioni. Con problema a collo di bottiglia intendo ogni problema che necessita di essere risolto perché l'avventura possa procedere. Per esempio, mettiamo caso che ci sia una porta segreta dietro la quale c'è un tesoro a caso, ma sostanzialmente trascurabile. Trovare la porta segreta è un problema, ma non è un collo di bottiglia, perciò devo trovare un'unica soluzione. In D&D questa soluzione è semplice perché è scritta direttamente nelle regole: la porta segreta può essere trovata con un tiro di Cercare ben riuscito. Ma poniamo caso che, invece che un tesoro a caso, dietro quella porta ci sia qualcosa di vitale importanza. Perché l'avventura possa procedere, il gruppo deve trovare la porta segreta. Ora la porta segreta è un problema a collo di bottiglia e quindi cercherò di assicurarmi che ci siano almeno tre soluzioni. La prima soluzione è sempre la stessa: passare la prova di abilità di Cercare. A questo potremmo aggiungere un appunto in un altro scenario in cui si danno istruzioni ad un cultista perché “nasconda l'artefatto dietro la statua di Ra” (dove si trova la porta segreta); un diario consunto scritto dall'ideatore del complesso che fa riferimento alla porta; una seconda porta segreta che porta allo stesso luogo (questa conta come una soluzione separata perché introduce immediatamente un secondo tiro di Cercare come possibilità); una probabile situazione in cui il cattivo principale cercherà di scappare attraverso la porta segreta; la possibilità di interrogare i cultisti catturati; e così via. In realtà, una volta identificato un collo di bottiglia del genere, diventa abbastanza banale cominciare ad aggiungere soluzioni in questo modo. Ho visto alcuni master dire che questo rende le cose “troppo facili”. Ma in realtà soluzioni alternative così tendono a rendere lo scenario più interessante, non meno. Pensate alla nostra porta segreta, per esempio. Prima che cominciassimo ad aggiungere soluzioni alternative, era solo un tiro di dadi. Ora è stata pensata da una persona specifica; usata dai cultisti; e potenzialmente può rivelarsi una via di fuga. Quando inizierete ad usare più spesso queste tecniche della Regola dei Tre Indizi, scoprirete che i vostri scenari diventano ancora più solidi. Per esempio, prendiamo uno scenario investigativo su un omicidio in cui l'assassino è un lupo mannaro che cerca le sue ex amanti. Ci vengono in mente tre modi per identificare l'assassino: Pattugliare le strade della cittadina in una notte di luna piena. Rendersi conto che le vittime sono tutte ex amanti dello stesso uomo. Andare nella macelleria del posto, in cui lavora l'assassino, e trovare le confessioni dei suoi incubi e dei suoi peccati scritte col sangue sui muri del retro. Per ognuna di queste conclusioni (è un lupo mannaro; è un ex amante; dovremmo controllare la macelleria) avremo bisogno di tre indizi. È UN LUPO MANNARO: Orme che da quelle di un lupo si trasformano in quelle di un essere umano. Segni di artigli giganti sulle vittime. Una delle vittime aveva una pistola caricata con proiettili d'argento. È UN EX AMANTE: Lettere d'amore scritte dallo stesso uomo. Il diario di una delle vittime in cui si racconta di come lui la tradisse con un'altra delle vittime. Il ritratto dello stesso tizio o sul corpo delle vittime o custodito da qualche parte nelle loro case. CONTROLLARE LA MACELLERIA: Una cassa rotta su cui si legge CARNI DI DANNER, su una delle scene del crimine. Un biglietto su cui c'è scritto “incontriamoci alla macelleria” accartocciato e gettato in un cestino. Una nota che dice “incontrare P in macelleria” nell'agenda di una delle vittime. E in un attimo avete creato uno scenario con nove diverse opzioni di riuscita. E se rimanete aperti all'idea di “più indizi, meglio è” mentre progettate l'avventura, troverete ancora più possibilità. Per esempio, non sarebbe cosa facile lasciare un riferimento alla macelleria in una di quelle lettere d'amore? O riempire quel diario di irrequieti schizzi a carboncino che rappresentano lupi? La parte divertente in tutto ciò, è che una volta che vi date la possibilità di inserire un sacco di indizi, vi date la possibilità di inserire degli indizi davvero sottili ed esoterici. Se i giocatori li colgono, saranno soddisfatti di averlo fatto. Se non li notano o non li capiscono, va bene lo stesso: avete un sacco di altri indizi che possono cercare (e una volta che avranno effettivamente risolto il mistero, si divertiranno a ritrovare quegli indizi esoterici e a capire cosa volessero dire). COROLLARIO: TOLLERANZA NELLA RICERCA DEGLI INDIZI La massima “più indizi ci sono meglio è” è da tenere sempre a mente. Quando si progetta uno scenario investigativo si è naturalmente portati, almeno credo, a tenersi per sé alcune informazioni. È logico: dopotutto, un mistero si basa sulla mancanza di informazioni. E c'è differenza tra scoprire un sacco di indizi e scoprire che l'assassino ha scritto il suo indirizzo col sangue sul muro. Ma il desiderio di tenere per sé le informazioni fa più male che bene, secondo me. Quando tenete per voi un'informazione, essenzialmente state sbarrando una strada che potrebbe portare al successo. Questo ci riporta al consiglio di Garriott: a meno che non ci sia una ragione per cui la porta dovrebbe essere a prova di cannone, il giocatore dovrebbe essere premiato per la sua inventiva. O, per metterla in un altro modo: solo perché davanti ad una porta chiusa non troviamo a terra la chiave per aprirla, non vuol dire che non ci siano altri modi per passare. Tenendo a mente ciò, dovreste avere la volontà di aprirvi ed essere tolleranti nella ricerca degli indizi. Con questo intendo dire che, se i giocatori trovano un modo intelligente di portare avanti le indagini, doveste essere aperti all'idea di dar loro informazioni utili di conseguenza. Poniamola in un altro modo: non trattate la lista degli indizi a cui avete pensato durante la preparazione come ad una camicia di forza. Pensate invece al vostro lavoro di preparazione come una rete di salvataggio. Una volta mi affezionavo molto ad una soluzione intelligente quando la progettavo. Mi lasciavo coinvolgere emotivamente dall'idea che i miei giocatori scoprissero questa soluzione intelligente che avevo pensato. Di conseguenza, tendevo a rifiutare le altre soluzioni che trovava il party; dopotutto, se avessero funzionato, i giocatori non avrebbe mai scoperto la soluzione intelligente che era venuta in mente a me. Col passare del tempo, mi sono reso conto che è molto più divertente quando i giocatori mi sorprendono. È lo stesso motivo per cui evito di stravolgere il tiro dei dadi per preservare qualunque concetto drammatico mi sia venuto in mente. Di conseguenza, ora tendo a pensare alla soluzione che ho progettato come alla peggiore delle ipotesi, alla rete di salvataggio che appare quando i miei giocatori non riescono ad uscirsene con nulla di più interessante. Per essere tolleranti riguardo alla ricerca di indizi, dovete prima capire la situazione di base. (Chi è il lupo mannaro? Come ha ucciso questa vittima? Perché l'ha uccisa? Quando l'ha uccisa?) Poi dovete abbracciare le idee e i metodi inaspettati del party, e fare leva sul vostro lato permissivo quando dovete decidere se troveranno o meno un indizio a cui non avevate mai pensato prima. COROLLARIO: INDIZI PROATTIVI Ovvero Fateceli Sbattere Contro. A volte, nonostante tutti i vostri sforzi, i giocatori si faranno strada verso un vicolo cieco: non sanno cosa significano gli indizi o li ignorano o li usano per raggiungere conclusioni sbagliate e ora se ne stanno andando nella direzione sbagliata. (Quando uso la Regola dei Tre Indizi, mi rendo conto che questo accade spesso quando i giocatori non si rendono conto che in realtà c'è un mistero che va risolto; dopo tutto, i misteri non sono tutti palesi come lo può essere un cadavere.) È in questi casi che è utile avere un piano di riserva. Il problema in questo scenario è che i giocatori sono troppo passivi, o perché non hanno le informazioni che servono loro, o perché le stanno usando nel modo sbagliato. Quindi la soluzione è far sì che succeda qualcosa di attivo. Il consiglio di Raymon Chandler in questi casi di impasse era: “Fate entrare dalla porta un tizio con una pistola.” L'ultima spiaggia alla quale ricorro io è più o meno dello stesso avviso: il cattivo scopre che è il gruppo ad investigare e manda qualcuno ad ucciderli o a corromperli. Un'altra buona soluzione è “muore qualcun altro”. O, più in generale, “ha inizio la fase successiva del piano del cattivo”. L'effetto sarà quello di creare una nuova situazione o evento dinamico di modo che il gruppo possa interagirvi. L'idea di fondo, ovviamente, non è semplicemente “far succedere qualcosa”. Vorrete che questo nuovo evento dia al gruppo un nuovo indizio (o, ancora meglio, più indizi) che possono seguire per continuare l'avventura. Nel peggiore dei casi, comunque, potete progettare un ultimo escamotage estremo per salvare capra e cavoli e concludere in modo soddisfacente la situazione, non importa in che casino i giocatori si siano ficcati. Per esempio, nella nostra storia del lupo mannaro, se il gruppo perde totalmente la strada, potreste semplicemente far apparire il lupo mannaro che cercherà di ucciderli tutti (perché crede che “si stiano avvicinando troppo”). Di solito non dà chissà quale soddisfazione, ma almeno vi toglie da una brutta situazione. È l'ultimo piano alternativo quando tutti gli altri hanno fallito. COROLLARIO: I DEPISTAGGI SONO SOPRAVVALUTATI I depistaggi sono un elemento classico nel genere investigativo: tutte le prove puntano verso X, ma è una falsa pista! Il vero colpevole è Y! Quando si progetta uno scenario per un GDR, in ogni caso, i depistaggi sono sopravvalutati. Non mi azzardo a dire che non dovreste mai usarli, ma mi azzardo a dire che dovreste usarli con estrema cautela. Sostanzialmente per due ragioni: Primo, riuscire a far fare ai giocatori le giuste deduzioni è già abbastanza difficile. Metterci pure una falsa pista non fa altro che rendere il tutto più difficile. Più importante ancora è il fatto che una volta che i giocatori hanno raggiunto una conclusione, tenderanno a rimanerci aggrappati. Potrebbe essere estremamente difficile convincerli a lasciarla andare e riesaminare le prove. (Un modo per far funzionare un depistaggio è assicurarsi che ci sia una confutazione inoppugnabile: per esempio, gli omicidi continuano anche dopo che il gruppo fa arrestare un sospettato. Sfortunatamente il concetto che potreste avere di “confutazione inoppugnabile” potrebbe essere oggettivo quanto quello che avete di “un indizio davvero palese che non è possibile non venga colto”.) Secondo, non c'è davvero bisogno che mettiate una falsa pista: quasi sicuramente il gruppo lo farà al posto vostro. Se riempite la vostra avventura con nient'altro che indizi che puntano solo ed esclusivamente al vero colpevole, posso praticamente garantirvi che i giocatori inizieranno a sospettare di almeno altre tre persone prima di rendersi conto di chi c'è dietro a tutto. Si aggrapperanno con forza ai loro sospetti e cominceranno a tessere teorie complicate per spiegare il collegamento tra le prove che hanno trovato e il sospettato che vogliono. In altre parole, per progettare uno scenario investigativo il trucco è cercare di evitare incidenti stradali. Buttare una falsa pista nel calderone è come far ubriacare i giocatori prima di metterli al volante. COROLLARIO: NULLA È A PROVA DI STUPIDO Avete disposto con attenzione uno scenario in cui ci sono diversi percorsi per giungere alla soluzione, con dozzine di indizi a sostegno di ogni passo di ogni percorso. Avete anche un paio di piani di riserva pensati preventivamente per portare il gruppo sulla giusta strada se qualcosa dovesse andare storto. Cosa potrebbe mai andare storto? … come fate anche solo a pensarle certe cose? Non importa quanto accorti siate stati: la verità è che, prima o poi, qualcosa andrà storto nei vostri piani. Quando questo capiterà vorrete essere pronti a improvvisare nuovi piani sul momento. Ecco un estratto di un eccellente saggio di Ben Robbin Vi consiglio caldamente questo saggio. Dice più o meno tutto quello che pensavo di includere nella mia discussione di quest'ultimo corollario, quindi non perderò tempo a ripetere qualcosa che è già stato scritto così bene. Mi prenderò solo la soddisfazione di citare questo consiglio: Come abbiamo già detto, un modo per evitare questo tipo di problema è evitare di avere “un suggerimento chiave” sul quale si regge tutta l'avventura. Ma il consiglio di “scrivere le rivelazioni in anticipo” è ottimo. Come dice Robbins, “deve essere un elenco o un promemoria, non tutta la spiegazione”. Il mio consiglio è di fare una lista delle conclusioni che volete che i vostri giocatori raggiungano. Sotto ogni conclusione, scrivete ogni indizio che potrebbe condurli a quella conclusione. (Potreste usarla anche come lista di controllo del progetto per essere sicuri di avere abbastanza indizi a sostegno di ogni conclusione.) Nel momento in cui il gruppo riceve gli indizi, fateci un segno a fianco. (Questo vi permetterà di vedere subito se ci sono aree in cui ai giocatori mancano troppi indizi.) Per finire, ascoltate con attenzione quello che si dicono i giocatori. Quando hanno raggiunto una data conclusione, potete spuntarla per intero dalla lista. (Fate attenzione a non spuntarla appena la considerano una possibilità. Spuntatela solo quando hanno effettivamente concluso che sia vera.) Se vedete che sono tanti gli indizi che non vengono colti per raggiungere una conclusione, o che sono stati trovati tutti, ma che i giocatori ancora non ci sono arrivati, allora saprete che probabilmente è ora di cominciare a pensare a nuovi indizi da plasmare nell'avventura. L'ULTIMA PAROLA In sostanza, la questione si può semplicemente riassumere così: progettate diversi percorsi per raggiungere l'obiettivo. Incoraggiate l'ingegnosità del giocatore. Datevi un piano B. E ricordate la Regola dei Tre Indizi: Per ogni conclusione a cui volete che giungano i giocatori, includete almeno tre indizi Link all'originale: https://thealexandrian.net/wordpress/1118/roleplaying-games/three-clue-rule View full article
-
La Regola dei Tre Indizi
Articolo di The Alexandrian del 08 Maggio 2008 Gli scenari investigativi nei giochi di ruolo hanno la reputazione di finire spesso in disastro. I PG finiscono quasi sempre per prendere totalmente un'altra strada o non riuscire a trovare un dato indizio e l'intera situazione si inchioda o si incaglia sul primo scoglio che trova. I giocatori finiscono per non essere sicuri di cosa dovrebbero fare. Il DM finisce per avere la sensazione di aver fatto qualcosa di sbagliato. E l'intera serata finisce per essere noiosa o frustrante o entrambe le cose. Un tipico esempio può essere questo: quando il gruppo si trova su una scena del crimine, nessuno cerca fuori dalla casa, perciò non trovano mai le orme di un lupo che si trasformano in quelle di un essere umano. Falliscono il tiro di Cercare e non trovano le lettere d'amore nascoste, così non si renderanno mai conto che entrambe le donne erano corteggiate dallo stesso uomo. Trovano la cassa distrutta con la scritta CARNI DI DANNER, ma, anziché tornare indietro dal macellaio del posto con cui hanno parlato prima, decidono invece di tenere d'occhio il vicino impianto di trasformazione delle carni. Di fronte a problemi come questi, molti raggiungono una conclusione affrettata: che inserire degli scenari investigativi nei giochi di ruolo sia una pessima idea. Nel tipico giallo su un omicidio, per esempio, il protagonista è un brillante detective. I giocatori probabilmente non sono dei brillanti detective. Perciò inserire uno scenario investigativo è impossibile. O, come mi è stato detto una volta: “I giocatori non sono Sherlock Holmes.” Nonostante questa conclusione non sia corretta, c'è un po' di verità. Per esempio, in Uno Studio in Rosso Sherlock Holmes investiga su una scena del crimine. Scopre un mucchietto di cenere in un angolo della stanza. Lo studia con attenzione e arriva alla conclusione che la cenere viene da un sigaro Trichinipoli. Ora, vediamo come potremmo tradurre questo esempio apparentemente banale di deduzione sherlockiana sul tavolo: I giocatori dovrebbero riuscire a cercare per bene nella stanza. Dovrebbero interessarsi alla cenere abbastanza da esaminarla. Dovrebbero passare il tiro abilità Ricerca per analizzarla. Dovrebbero usare quelle informazioni per raggiungere la conclusione corretta. Sono quattro possibilità di fallimento. I giocatori potrebbero non riuscire a cercare per la stanza (o perché non ci pensano o perché fanno tiri bassi). Potrebbero non esaminare la cenere (perché non pensano sia importante). Potrebbero fallire il tiro per analizzarla. Potrebbero non riuscire a fare la deduzione corretta. Se riconoscere correttamente questo indizio è essenziale per proseguire nell'avventura (se, per esempio, il gruppo deve andare nel vicino negozio di sigari particolari e cominciare a fare domande), allora l'indizio diventa un collo di bottiglia: o il gruppo coglie l'indizio o va a finire contro un muro. I colli di bottiglia sono sempre un grosso problema nella creazione di un'avventura e devono essere evitati, ma quando ci troviamo in una situazione di tipo investigativo il problema è ancora peggiore: ogni indizio non è un solo collo di bottiglia, ma in realtà più colli di bottiglia. Perciò qui la soluzione è semplice: eliminare i colli di bottiglia. IL SENTIERO DI MOLLICHE DI PANE Nel GUMSHOE system di Robin D. Laws (utilizzato in Esoterroristi, Di cosa hai paura, e Sulle tracce di Cthuhlu), trovare gli indizi non è necessario. In ogni “scena” di una situazione investigativa, c'è un “indizio”. Si presume automaticamente che gli investigatori lo troveranno. Ciò elimina tre delle nostre quattro strettoie, e rimane solo la necessità di usare l'indizio per fare la deduzione corretta (cioè, la deduzione che ti porta alla “scena” seguente dove potrà venir rivelato l'indizio successivo). E, nel caso del GUMSHOE system, anche questo passaggio può avvenire in modo meccanico (coi giocatori che spendono i punti delle abilità investigative dei propri personaggi per ricevere dal master “deduzioni” sempre più precise). È una soluzione meccanica al problema. Ma se utilizzata in una sessione che segue in modo superficiale la struttura di una storia investigativa, credo che fallisca nel suo intento perché non sembra di stare giocando una storia di investigazione. L'errore fondamentale di Law, secondo me, sta nel partire dal presupposto che una storia investigativa equivalga a seguire un “sentiero di molliche di pane” (o meglio, di indizi). Ecco la citazione di un suo saggio a tal proposito: Ma, nella realtà dei fatti, questo tipo di trama ridotta semplicisticamente a “Da A si va a B e da lì a C e da lì a D” non è tipica del genere investigativo. Per dare un contro-esempio relativamente semplice, torniamo a Sherlock Homes in Uno Studio in Rosso: Questa è solo una piccola deduzione in un mistero molto più fitto, ma noterete che Holmes in realtà ha raccolto diversi indizi, li ha studiati, e poi da essi ha tratto una conclusione. Ed è questa, per l'appunto, la struttura tipica del genere investigativo: il detective raccoglie piano piano le prove fino a che non arriva una conclusione. Nelle note parole dello stesso Holmes, “Quando si elimina l'impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità.” In realtà, in molti casi la verità è che c'è bisogno di tante piccole deduzioni per raccogliere tutte le prove necessarie a risolvere il mistero. In ogni caso, come dimostra l'esempio di Uno studio in rosso, anche queste deduzioni più marginali possono emergere da un insieme di prove e non da un solo indizio isolato. Questa osservazione ci porta inesorabilmente alla soluzione che stavamo cercando: LA REGOLA DEI TRE INDIZI Ogni qualvolta realizzate uno scenario investigativo, dovreste inevitabilmente seguire la Regola dei Tre Indizi: Per ogni conclusione a cui volete che giungano i giocatori, includete almeno tre indizi. Perché tre? Perché probabilmente i giocatori si perderanno il primo; ignoreranno il secondo; e interpreteranno male il terzo prima di fare un incredibile volo pindarico che li farà arrivare dove volevate fin dall'inizio. Scherzo, ovviamente. Ma se pensate ad ogni indizio come un piano (il gruppo troverà X, arriverà alla conclusione Y e andrà a Z), allora quando avete tre indizi vi ritrovate non solo con un piano, ma con addirittura un piano B e uno C. E quando vi renderete conto che i vostri piani non sopravviveranno mai al confronto coi giocatori, capirete perché vi servono un piano B e uno C. Nella migliore delle ipotesi, ovviamente, il gruppo troverà tutti e tre gli indizi. Non c'è nulla di sbagliato. Potranno usare gli indizi per dare conferma ai loro sospetti e rafforzare le loro conclusioni (proprio come Sherlock Holmes). Nella peggiore delle ipotesi, dovrebbero essere in grado di usare almeno uno di questi indizi per raggiungere la conclusione corretta e proseguire nell'avventura. Ed ecco un suggerimento importante: la Regola dei Tre Indizi non ha eccezioni. “Ma Justin!” mi direte. “Questo indizio è davvero lampante. Non è possibile che il gruppo non ci arrivi.” Secondo la mia esperienza, probabilmente vi sbagliate. Da un lato, considerate che siete voi a creare la situazione. Sapete già qual è la soluzione del giallo. Questo vi rende difficile il giudicare in maniera obiettiva se una cosa è ovvia oppure no. E anche aveste ragione, che problema c'è? Avere indizi in più non darà alcun problema. Perché non prevenire anziché curare? ESTENDERE LA REGOLA DEI TRE INDIZI In realtà, sarebbe un'ottima idea tenere a mente il concetto base della Regola dei Tre Indizi, in senso lato, nella realizzazione di qualsiasi tipo di situazione. Richard Garriot, il designer dei videogiochi della serie Ultima e Tabula Rasa, una volta ha detto che il suo lavoro come game designer era assicurarsi che fosse possibile avere almeno una soluzione ad un problema senza impedire al giocatore di trovare altre soluzioni per conto proprio. Per esempio, se trovate una porta chiusa in uno degli Ultima, da qualche parte ci sarà anche una chiave. Ma potreste anche farvi strada con la forza; o scassinare la serratura; o puntarci contro un cannone e farla saltare. Warren Spector, che cominciò col lavorare con Garriott ad Ultima VI, in seguito divenne designer di Deus Ex. Segue la stessa filosofia di design e parla entusiasta dell'emozione che provava nel guardare qualcuno giocare al proprio videogioco e pensare, “Aspetta... funzionerà?” In realtà, quando progetto un'avventura cerco di portare questa filosofia di design al livello successivo: per ogni problema che si pone davanti al gruppo, mi assicuro che ci sia almeno una soluzione e poi rimango totalmente aperto a qualsiasi idea venga in mente ai giocatori. Ma per ogni problema a collo di bottiglia, mi assicuro che ci siano almeno tre soluzioni. Con problema a collo di bottiglia intendo ogni problema che necessita di essere risolto perché l'avventura possa procedere. Per esempio, mettiamo caso che ci sia una porta segreta dietro la quale c'è un tesoro a caso, ma sostanzialmente trascurabile. Trovare la porta segreta è un problema, ma non è un collo di bottiglia, perciò devo trovare un'unica soluzione. In D&D questa soluzione è semplice perché è scritta direttamente nelle regole: la porta segreta può essere trovata con un tiro di Cercare ben riuscito. Ma poniamo caso che, invece che un tesoro a caso, dietro quella porta ci sia qualcosa di vitale importanza. Perché l'avventura possa procedere, il gruppo deve trovare la porta segreta. Ora la porta segreta è un problema a collo di bottiglia e quindi cercherò di assicurarmi che ci siano almeno tre soluzioni. La prima soluzione è sempre la stessa: passare la prova di abilità di Cercare. A questo potremmo aggiungere un appunto in un altro scenario in cui si danno istruzioni ad un cultista perché “nasconda l'artefatto dietro la statua di Ra” (dove si trova la porta segreta); un diario consunto scritto dall'ideatore del complesso che fa riferimento alla porta; una seconda porta segreta che porta allo stesso luogo (questa conta come una soluzione separata perché introduce immediatamente un secondo tiro di Cercare come possibilità); una probabile situazione in cui il cattivo principale cercherà di scappare attraverso la porta segreta; la possibilità di interrogare i cultisti catturati; e così via. In realtà, una volta identificato un collo di bottiglia del genere, diventa abbastanza banale cominciare ad aggiungere soluzioni in questo modo. Ho visto alcuni master dire che questo rende le cose “troppo facili”. Ma in realtà soluzioni alternative così tendono a rendere lo scenario più interessante, non meno. Pensate alla nostra porta segreta, per esempio. Prima che cominciassimo ad aggiungere soluzioni alternative, era solo un tiro di dadi. Ora è stata pensata da una persona specifica; usata dai cultisti; e potenzialmente può rivelarsi una via di fuga. Quando inizierete ad usare più spesso queste tecniche della Regola dei Tre Indizi, scoprirete che i vostri scenari diventano ancora più solidi. Per esempio, prendiamo uno scenario investigativo su un omicidio in cui l'assassino è un lupo mannaro che cerca le sue ex amanti. Ci vengono in mente tre modi per identificare l'assassino: Pattugliare le strade della cittadina in una notte di luna piena. Rendersi conto che le vittime sono tutte ex amanti dello stesso uomo. Andare nella macelleria del posto, in cui lavora l'assassino, e trovare le confessioni dei suoi incubi e dei suoi peccati scritte col sangue sui muri del retro. Per ognuna di queste conclusioni (è un lupo mannaro; è un ex amante; dovremmo controllare la macelleria) avremo bisogno di tre indizi. È UN LUPO MANNARO: Orme che da quelle di un lupo si trasformano in quelle di un essere umano. Segni di artigli giganti sulle vittime. Una delle vittime aveva una pistola caricata con proiettili d'argento. È UN EX AMANTE: Lettere d'amore scritte dallo stesso uomo. Il diario di una delle vittime in cui si racconta di come lui la tradisse con un'altra delle vittime. Il ritratto dello stesso tizio o sul corpo delle vittime o custodito da qualche parte nelle loro case. CONTROLLARE LA MACELLERIA: Una cassa rotta su cui si legge CARNI DI DANNER, su una delle scene del crimine. Un biglietto su cui c'è scritto “incontriamoci alla macelleria” accartocciato e gettato in un cestino. Una nota che dice “incontrare P in macelleria” nell'agenda di una delle vittime. E in un attimo avete creato uno scenario con nove diverse opzioni di riuscita. E se rimanete aperti all'idea di “più indizi, meglio è” mentre progettate l'avventura, troverete ancora più possibilità. Per esempio, non sarebbe cosa facile lasciare un riferimento alla macelleria in una di quelle lettere d'amore? O riempire quel diario di irrequieti schizzi a carboncino che rappresentano lupi? La parte divertente in tutto ciò, è che una volta che vi date la possibilità di inserire un sacco di indizi, vi date la possibilità di inserire degli indizi davvero sottili ed esoterici. Se i giocatori li colgono, saranno soddisfatti di averlo fatto. Se non li notano o non li capiscono, va bene lo stesso: avete un sacco di altri indizi che possono cercare (e una volta che avranno effettivamente risolto il mistero, si divertiranno a ritrovare quegli indizi esoterici e a capire cosa volessero dire). COROLLARIO: TOLLERANZA NELLA RICERCA DEGLI INDIZI La massima “più indizi ci sono meglio è” è da tenere sempre a mente. Quando si progetta uno scenario investigativo si è naturalmente portati, almeno credo, a tenersi per sé alcune informazioni. È logico: dopotutto, un mistero si basa sulla mancanza di informazioni. E c'è differenza tra scoprire un sacco di indizi e scoprire che l'assassino ha scritto il suo indirizzo col sangue sul muro. Ma il desiderio di tenere per sé le informazioni fa più male che bene, secondo me. Quando tenete per voi un'informazione, essenzialmente state sbarrando una strada che potrebbe portare al successo. Questo ci riporta al consiglio di Garriott: a meno che non ci sia una ragione per cui la porta dovrebbe essere a prova di cannone, il giocatore dovrebbe essere premiato per la sua inventiva. O, per metterla in un altro modo: solo perché davanti ad una porta chiusa non troviamo a terra la chiave per aprirla, non vuol dire che non ci siano altri modi per passare. Tenendo a mente ciò, dovreste avere la volontà di aprirvi ed essere tolleranti nella ricerca degli indizi. Con questo intendo dire che, se i giocatori trovano un modo intelligente di portare avanti le indagini, doveste essere aperti all'idea di dar loro informazioni utili di conseguenza. Poniamola in un altro modo: non trattate la lista degli indizi a cui avete pensato durante la preparazione come ad una camicia di forza. Pensate invece al vostro lavoro di preparazione come una rete di salvataggio. Una volta mi affezionavo molto ad una soluzione intelligente quando la progettavo. Mi lasciavo coinvolgere emotivamente dall'idea che i miei giocatori scoprissero questa soluzione intelligente che avevo pensato. Di conseguenza, tendevo a rifiutare le altre soluzioni che trovava il party; dopotutto, se avessero funzionato, i giocatori non avrebbe mai scoperto la soluzione intelligente che era venuta in mente a me. Col passare del tempo, mi sono reso conto che è molto più divertente quando i giocatori mi sorprendono. È lo stesso motivo per cui evito di stravolgere il tiro dei dadi per preservare qualunque concetto drammatico mi sia venuto in mente. Di conseguenza, ora tendo a pensare alla soluzione che ho progettato come alla peggiore delle ipotesi, alla rete di salvataggio che appare quando i miei giocatori non riescono ad uscirsene con nulla di più interessante. Per essere tolleranti riguardo alla ricerca di indizi, dovete prima capire la situazione di base. (Chi è il lupo mannaro? Come ha ucciso questa vittima? Perché l'ha uccisa? Quando l'ha uccisa?) Poi dovete abbracciare le idee e i metodi inaspettati del party, e fare leva sul vostro lato permissivo quando dovete decidere se troveranno o meno un indizio a cui non avevate mai pensato prima. COROLLARIO: INDIZI PROATTIVI Ovvero Fateceli Sbattere Contro. A volte, nonostante tutti i vostri sforzi, i giocatori si faranno strada verso un vicolo cieco: non sanno cosa significano gli indizi o li ignorano o li usano per raggiungere conclusioni sbagliate e ora se ne stanno andando nella direzione sbagliata. (Quando uso la Regola dei Tre Indizi, mi rendo conto che questo accade spesso quando i giocatori non si rendono conto che in realtà c'è un mistero che va risolto; dopo tutto, i misteri non sono tutti palesi come lo può essere un cadavere.) È in questi casi che è utile avere un piano di riserva. Il problema in questo scenario è che i giocatori sono troppo passivi, o perché non hanno le informazioni che servono loro, o perché le stanno usando nel modo sbagliato. Quindi la soluzione è far sì che succeda qualcosa di attivo. Il consiglio di Raymon Chandler in questi casi di impasse era: “Fate entrare dalla porta un tizio con una pistola.” L'ultima spiaggia alla quale ricorro io è più o meno dello stesso avviso: il cattivo scopre che è il gruppo ad investigare e manda qualcuno ad ucciderli o a corromperli. Un'altra buona soluzione è “muore qualcun altro”. O, più in generale, “ha inizio la fase successiva del piano del cattivo”. L'effetto sarà quello di creare una nuova situazione o evento dinamico di modo che il gruppo possa interagirvi. L'idea di fondo, ovviamente, non è semplicemente “far succedere qualcosa”. Vorrete che questo nuovo evento dia al gruppo un nuovo indizio (o, ancora meglio, più indizi) che possono seguire per continuare l'avventura. Nel peggiore dei casi, comunque, potete progettare un ultimo escamotage estremo per salvare capra e cavoli e concludere in modo soddisfacente la situazione, non importa in che casino i giocatori si siano ficcati. Per esempio, nella nostra storia del lupo mannaro, se il gruppo perde totalmente la strada, potreste semplicemente far apparire il lupo mannaro che cercherà di ucciderli tutti (perché crede che “si stiano avvicinando troppo”). Di solito non dà chissà quale soddisfazione, ma almeno vi toglie da una brutta situazione. È l'ultimo piano alternativo quando tutti gli altri hanno fallito. COROLLARIO: I DEPISTAGGI SONO SOPRAVVALUTATI I depistaggi sono un elemento classico nel genere investigativo: tutte le prove puntano verso X, ma è una falsa pista! Il vero colpevole è Y! Quando si progetta uno scenario per un GDR, in ogni caso, i depistaggi sono sopravvalutati. Non mi azzardo a dire che non dovreste mai usarli, ma mi azzardo a dire che dovreste usarli con estrema cautela. Sostanzialmente per due ragioni: Primo, riuscire a far fare ai giocatori le giuste deduzioni è già abbastanza difficile. Metterci pure una falsa pista non fa altro che rendere il tutto più difficile. Più importante ancora è il fatto che una volta che i giocatori hanno raggiunto una conclusione, tenderanno a rimanerci aggrappati. Potrebbe essere estremamente difficile convincerli a lasciarla andare e riesaminare le prove. (Un modo per far funzionare un depistaggio è assicurarsi che ci sia una confutazione inoppugnabile: per esempio, gli omicidi continuano anche dopo che il gruppo fa arrestare un sospettato. Sfortunatamente il concetto che potreste avere di “confutazione inoppugnabile” potrebbe essere oggettivo quanto quello che avete di “un indizio davvero palese che non è possibile non venga colto”.) Secondo, non c'è davvero bisogno che mettiate una falsa pista: quasi sicuramente il gruppo lo farà al posto vostro. Se riempite la vostra avventura con nient'altro che indizi che puntano solo ed esclusivamente al vero colpevole, posso praticamente garantirvi che i giocatori inizieranno a sospettare di almeno altre tre persone prima di rendersi conto di chi c'è dietro a tutto. Si aggrapperanno con forza ai loro sospetti e cominceranno a tessere teorie complicate per spiegare il collegamento tra le prove che hanno trovato e il sospettato che vogliono. In altre parole, per progettare uno scenario investigativo il trucco è cercare di evitare incidenti stradali. Buttare una falsa pista nel calderone è come far ubriacare i giocatori prima di metterli al volante. COROLLARIO: NULLA È A PROVA DI STUPIDO Avete disposto con attenzione uno scenario in cui ci sono diversi percorsi per giungere alla soluzione, con dozzine di indizi a sostegno di ogni passo di ogni percorso. Avete anche un paio di piani di riserva pensati preventivamente per portare il gruppo sulla giusta strada se qualcosa dovesse andare storto. Cosa potrebbe mai andare storto? … come fate anche solo a pensarle certe cose? Non importa quanto accorti siate stati: la verità è che, prima o poi, qualcosa andrà storto nei vostri piani. Quando questo capiterà vorrete essere pronti a improvvisare nuovi piani sul momento. Ecco un estratto di un eccellente saggio di Ben Robbin Vi consiglio caldamente questo saggio. Dice più o meno tutto quello che pensavo di includere nella mia discussione di quest'ultimo corollario, quindi non perderò tempo a ripetere qualcosa che è già stato scritto così bene. Mi prenderò solo la soddisfazione di citare questo consiglio: Come abbiamo già detto, un modo per evitare questo tipo di problema è evitare di avere “un suggerimento chiave” sul quale si regge tutta l'avventura. Ma il consiglio di “scrivere le rivelazioni in anticipo” è ottimo. Come dice Robbins, “deve essere un elenco o un promemoria, non tutta la spiegazione”. Il mio consiglio è di fare una lista delle conclusioni che volete che i vostri giocatori raggiungano. Sotto ogni conclusione, scrivete ogni indizio che potrebbe condurli a quella conclusione. (Potreste usarla anche come lista di controllo del progetto per essere sicuri di avere abbastanza indizi a sostegno di ogni conclusione.) Nel momento in cui il gruppo riceve gli indizi, fateci un segno a fianco. (Questo vi permetterà di vedere subito se ci sono aree in cui ai giocatori mancano troppi indizi.) Per finire, ascoltate con attenzione quello che si dicono i giocatori. Quando hanno raggiunto una data conclusione, potete spuntarla per intero dalla lista. (Fate attenzione a non spuntarla appena la considerano una possibilità. Spuntatela solo quando hanno effettivamente concluso che sia vera.) Se vedete che sono tanti gli indizi che non vengono colti per raggiungere una conclusione, o che sono stati trovati tutti, ma che i giocatori ancora non ci sono arrivati, allora saprete che probabilmente è ora di cominciare a pensare a nuovi indizi da plasmare nell'avventura. L'ULTIMA PAROLA In sostanza, la questione si può semplicemente riassumere così: progettate diversi percorsi per raggiungere l'obiettivo. Incoraggiate l'ingegnosità del giocatore. Datevi un piano B. E ricordate la Regola dei Tre Indizi: Per ogni conclusione a cui volete che giungano i giocatori, includete almeno tre indizi Link all'originale: https://thealexandrian.net/wordpress/1118/roleplaying-games/three-clue-rule
-
Cerchiamo nuovi Newser, Traduttori e Moderatori!
Ciao Alonewolf! Commento anch'io perché mi piacerebbe propormi nel ruolo di Traduttrice. Ho studiato lingue e letteratura per, diciamo, tutta la vita, per diventare traduttrice. Tuttavia, ho sempre cercato di coniugare le mie passioni allo studio, completando una tesina di maturità su Tolkien e una tesi di laurea triennale su uno studio filologico (ai tempi ancora abbastanza pioneristico) della storia di Kullervo trasposta da Tolkien nel "Narn i Chîn Húrin", e una tesi di laurea magistrale di traduzione dei graphic novel della serie Avatar The Last Airbender, accompagnata da uno studio metodologico sul fumetto. Quindi sono laureata in Traduzione Letteraria e Saggistica all'Università di Pisa in lingua inglese e spagnola. Oltre a questi lavori dal respiro più "pop" in ambito accademico, ho anche lavorato come traduttrice per un sito web e la relativa pagina Facebook, nello specifico traducevo contenuti di intrattenimento. Per finire, ho da poco finito di tradurre il "mio" primo romanzo per una piccola casa editrice. Oltre a ciò, nella vita sono una cosplayer, lettrice appassionata e videogiocatrice, e negli ultimi anni mi sono avvicinata al mondo dei GDR (non su schermo), perché, pur essendo sempre stata interessata ai GDR e anche ai LARP, non avevo mai avuto la possibilità di poter avere effettivamente altri giocatori nelle mie vicinanze. Mi piacerebbe continuare ad occuparmi di traduzione in ambiti che mi interessino VERAMENTE. Perciò credo che questa opportunità potrebbe essere estremamente interessante!